
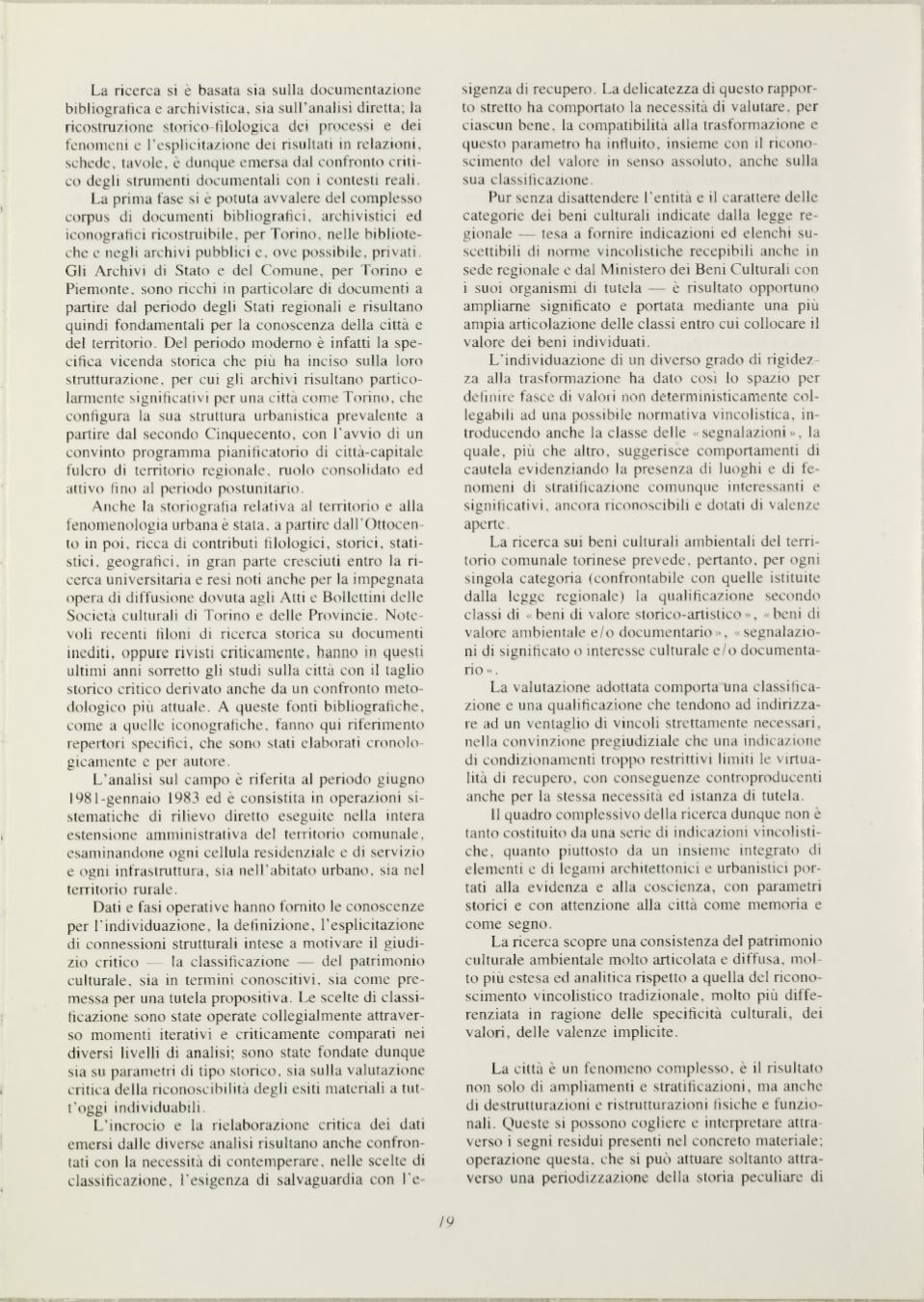
La ricerca si è basata sia sulla documentazione
bibliografica e archivistica, sia sull'analisi diretta; la
ricostruzione storico-filologica dei processi e dei
fenomeni e l'esplicitazione dei risultati in relazioni,
schede, tavole, è dunque emersa dal confronto
critico degli strumenti documentali con i contesti reali.
La prima fase si è potuta avvalere del complesso
corpus di documenti bibliografici, archivistici ed
iconografici ricostruibile, per Torino, nelle bibliote-
che e negli archivi pubblici e, ove possibile, privati.
Gli Archivi di Stato e del Comune, per Torino e
Piemonte, sono ricchi in particolare di documenti a
partire dal periodo degli Stati regionali e risultano
quindi fondamentali per la conoscenza della città e
del territorio. Del periodo moderno
è
infatti la spe-
cifica vicenda storica che più ha inciso sulla loro
strutturazione, per cui gli archivi risultano partico-
larmente significativi per una città come Torino, che
configura la sua struttura urbanistica prevalente a
partire dal secondo Cinquecento, con l'avvio di un
convinto programma pianificatorio di città-capitale
fulcro di territorio regionale, ruolo consolidato ed
attivo fino al periodo postunitario.
Anche la storiografia relativa al territorio e alla
fenomenologia urbana è stata, a partire dall'Ottocen-
to in poi, ricca di contributi filologici, storici, stati-
stici, geografici, in gran parte cresciuti entro la ri-
cerca universitaria e resi noti anche per la impegnata
opera di diffusione dovuta agli Atti e Bollettini delle
Società culturali di Torino e delle Provincie. Note-
voli recenti filoni di ricerca storica su documenti
inediti, oppure rivisti criticamente, hanno in questi
ultimi anni sorretto gli studi sulla città con il taglio
storico critico derivato anche da un confronto meto-
dologico più attuale. A queste fonti bibliografiche,
come a quelle iconografiche, fanno qui riferimento
repertori specifici, che sono stati elaborati
cronologicamente eper autore.
L'analisi sul campo è riferita al periodo giugno
1981-gennaio 1983 ed è consistita in operazioni si-
stematiche di rilievo diretto eseguite nella intera
estensione amministrativa del territorio comunale,
esaminandone ogni cellula residenziale e di servizio
e ogni infrastruttura, sia nell'abitato urbano, sia nel
territorio rurale.
Dati e fasi operative hanno fornito le conoscenze
per l'individuazione, la definizione, l'esplicitazione
di connessioni strutturali intese a motivare il giudi-
zio critico la classificazione del patrimonio
culturale, sia in termini conoscitivi, sia come pre-
messa per una tutela propositiva. Le scelte di classi-
ficazione sono state operate collegialmente attraver-
so momenti iterativi e criticamente comparati nei
diversi livelli di analisi; sono state fondate dunque
sia su parametri di tipo storico, sia sulla valutazione
critica della riconoscibilità degli esiti materiali a
tutt'oggi individuabili.
L'incrocio e la rielaborazione critica dei dati
emersi dalle diverse analisi risultano anche confron-
tati con la necessità di contemperare, nelle scelte di
classificazione, l'esigenza di salvaguardia con l'e-
sigenza di recupero. La delicatezza di questo rappor-
to stretto ha comportato la necessità di valutare, per
ciascun bene, la compatibilità alla trasformazione e
questo parametro ha influito, insieme con il
riconoscimento del valore in senso assoluto, anche sulla
sua classificazione.
Pur senza disattendere l'entità e il carattere delle
categorie dei beni culturali indicate dalla legge
regionale — tesa a fornire indicazioni ed elenchi su-
scettibili di norme vincolistiche recepibili anche in
sede regionale e dal Ministero dei Beni Culturali con
i suoi organismi di tutela è risultato opportuno
ampliarne significato e portata mediante una più
ampia articolazione delle classi entro cui collocare il
valore dei beni individuati.
L'individuazione di un diverso grado di rigidez-
za alla trasformazione ha dato così lo spazio per
definire fasce di valori non deterministicamente
collegabili ad una possibile normativa vincolistica,
introducendo anche la classe delle «segnalazioni», la
quale, più che altro, suggerisce comportamenti di
cautela evidenziando la presenza di luoghi e di fe-
nomeni di stratificazione comunque interessanti e
significativi, ancora riconoscibili e dotati di valenze
aperte.
La ricerca sui beni culturali ambientali del terri-
torio comunale torinese prevede, pertanto, per ogni
singola categoria (confrontabile con quelle istituite
dalla legge regionale) la qualificazione secondo
classi di «beni di valore storico-artistico» , «beni di
valore ambientale e/o documentario», «
segnalazioni di significato o interesse culturale e/o documenta-
rio».
La valutazione adottata comporta una classifica-
zione e una qualificazione che tendono ad indirizza-
re ad un ventaglio di vincoli strettamente necessari,
nella convinzione pregiudiziale che una indicazione
di condizionamenti troppo restrittivi limiti le
virtualitàdi recupero, con conseguenze controproducenti
anche per la stessa necessità ed istanza di tutela.
Il quadro complessivo della ricerca dunque non
è
tanto costituito da una serie di indicazioni vincolisti-
che, quanto piuttosto da un insieme integrato di
elementi e di legami architettonici e urbanistici por-
tati alla evidenza e alla coscienza, con parametri
storici e con attenzione alla città come memoria e
come segno.
La ricerca scopre una consistenza del patrimonio
culturale ambientale molto articolata e diffusa, mol-
to più estesa ed analitica rispetto a quella del ricono-
scimento vincolistico tradizionale, molto più diffe-
renziata in ragione delle specificità culturali, dei
valori, delle valenze implicite.
La città è un fenomeno complesso,
è
il risultato
non solo di ampliamenti e stratificazioni, ma anche
di destrutturazioni e ristrutturazioni fisiche e funzio-
nali. Queste si possono cogliere e interpretare attra-
verso i segni residui presenti nel concreto materiale;
operazione questa, che si può attuare soltanto
attraverso una periodizzazione della storia peculiare di
19


















