
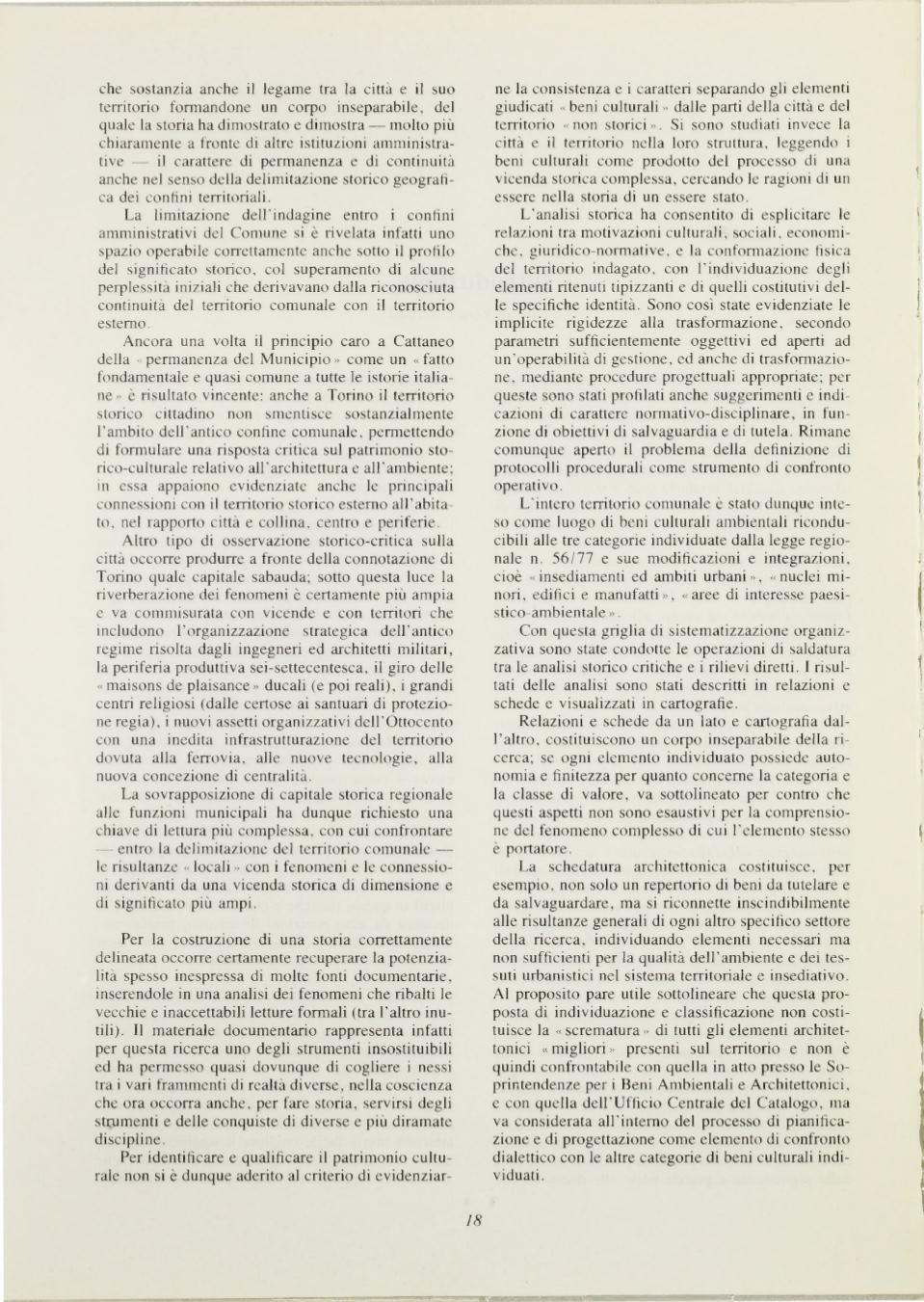
che sostanzia anche il legame tra la città e il suo
territorio formandone un corpo inseparabile, del
quale la storia ha dimostrato e dimostra — molto più
chiaramente a fronte di altre istituzioni amministra-
tive — il carattere di permanenza e di continuità
anche nel senso della delimitazione storico geografi-
ca dei confini territoriali.
La limitazione dell'indagine entro i confini
amministrativi del Comune si
è
rivelata infatti uno
spazio operabile correttamente anche sotto il profilo
del significato storico, col superamento di alcune
perplessità iniziali che derivavano dalla riconosciuta
continuità del territorio comunale con il territorio
esterno.
Ancora una volta il principio caro a Cattaneo
della « permanenza del Municipio » come un « fatto
fondamentale e quasi comune a tutte le istorie italia-
ne »
è
risultato vincente: anche a Torino il territorio
storico cittadino non smentisce sostanzialmente
l'ambito dell'antico confine comunale, permettendo
di formulare una risposta critica sul patrimonio
storico-culturale relativo all'architettura e all'ambiente;
in essa appaiono evidenziate anche le principali
connessioni con il territorio storico esterno all'abita-
to, nel rapporto città e collina, centro e periferie.
Altro tipo di osservazione storico-critica sulla
città occorre produrre a fronte della connotazione di
Torino quale capitale sabauda; sotto questa luce la
riverberazione dei fenomeni
è
certamente più ampia
e va commisurata con vicende e con territori che
includono l'organizzazione strategica dell'antico
regime risolta dagli ingegneri ed architetti militari,
la periferia produttiva sei-settecentesca, il giro delle
«
maisons de plaisance» ducali (e poi reali), i grandi
centri religiosi (dalle certose ai santuari di protezio-
ne regia), i nuovi assetti organizzativi dell'Ottocento
con una inedita infrastrutturazione del territorio
dovuta alla ferrovia, alle nuove tecnologie, alla
nuova concezione di centralità.
La sovrapposizione di capitale storica regionale
alle funzioni municipali ha dunque richiesto una
chiave di lettura più complessa, con cui confrontare
entro la delimitazione del territorio comunale —
le risultanze « locali » con i fenomeni e le connessio-
ni derivanti da una vicenda storica di dimensione e
di significato più ampi.
Per la costruzione di una storia correttamente
delineata occorre certamente recuperare la potenzia-
lità spesso inespressa di molte fonti documentarie,
inserendole in una analisi dei fenomeni che ribalti le
vecchie e inaccettabili letture formali (tra l'altro
inutili). Ilmaterialedocumentario rappresenta infatti
per questa ricerca uno degli strumenti insostituibili
ed ha permesso quasi dovunque di cogliere i nessi
tra i vari frammenti di realtà diverse, nella coscienza
che ora occorra anche, per fare storia, servirsi degli
strumenti e delle conquiste di diverse e più diramate
discipline.
Per identificare e qualificare il patrimonio cultu-
rale non si è dunque aderito al criterio di evidenziar-
ne la consistenza e i caratteri separando gli elementi
giudicati « beni culturali » dalle parti della città e del
territorio « non storici ». Si sono studiati invece la
città e il territorio nella loro struttura, leggendo i
beni culturali come prodotto del processo di una
vicenda storica complessa, cercando le ragioni di un
essere nella storia di un essere stato.
L'analisi storica ha consentito di esplicitare le
relazioni tra motivazioni culturali, sociali, economi-
che, giuridico-normative, e la conformazione fisica
del territorio indagato, con l'individuazione degli
elementi ritenuti tipizzanti e di quelli costitutivi del-
le specifiche identità. Sono così state evidenziate le
implicite rigidezze alla trasformazione, secondo
parametri sufficientemente oggettivi ed aperti ad
un'operabilità di gestione, ed anche di trasformazio-
ne, mediante procedure progettuali appropriate; per
queste sono stati profilati anche suggerimenti e indi-
cazioni di carattere normativo-disciplinare, in fun-
zione di obiettivi di salvaguardia e di tutela. Rimane
comunque aperto il problema della definizione di
protocolli procedurali come strumento di confronto
operativo.
L'intero territorio comunale è stato dunque inte-
so come luogo di beni culturali ambientali
riconducibili alle tre categorie individuate dalla legge
regionalen. 56/77 e suemodificazioni e integrazioni,
cioè « insediamenti ed ambiti urbani », « nuclei mi-
nori, edifici e manufatti», «aree di interesse
paesistico-ambientale » .
Con questa griglia di sistematizzazione
organizzativa sono state condotte leoperazionidi saldatura
tra le analisi storico critiche e i rilievi diretti. I
risultati delle analisi sono stati descritti in relazioni e
schede e visualizzati in cartografie.
Relazioni e schede da un lato e cartografia dal-
l'altro, costituiscono un corpo inseparabile della ri-
cerca; se ogni elemento individuato possiede auto-
nomia e finitezza per quanto concerne la categoria e
la classe di valore, va sottolineato per contro che
questi aspetti non sono esaustivi per la
comprensionedel fenomeno complesso di cui l'elemento stesso
è portatore.
La schedatura architettonica costituisce, per
esempio, non solo un repertorio di beni da tutelare e
da salvaguardare, ma si riconnette inscindibilmente
alle risultanze generali di ogni altro specifico settore
della ricerca, individuando elementi necessari ma
non sufficienti per la qualità dell'ambiente e dei
tessuti urbanisticinel sistema territoriale e insediativo.
Al proposito pare utile sottolineare che questa pro-
posta di individuazione e classificazione non
costituisce la « scrematura » di tutti gli elementi
architettonici «migliori »presenti sul territorio enon è
quindi confrontabile con quella in atto presso le So-
printendenze per i Beni Ambientali e Architettonici,
e con quella dell'Ufficio Centrale del Catalogo, ma
va considerata all'interno del processo di pianifica-
zione e di progettazione come elemento di confronto
dialettico con le altre categorie di beni culturali indi-
viduati.
18


















