
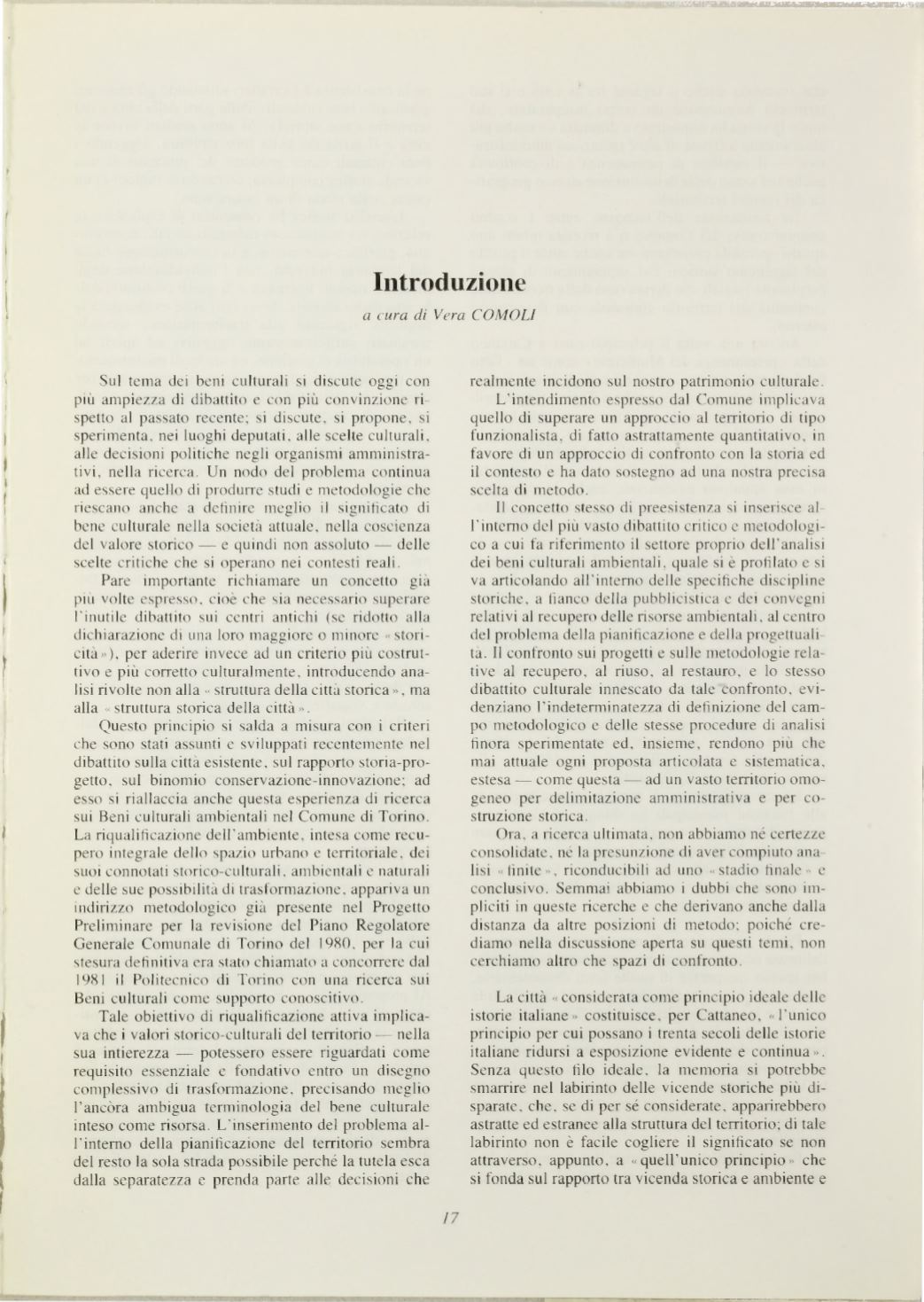
Introduzione
a cura di Vera COMOLI
Sul tema dei beni culturali si discute oggi con
più ampiezza di dibattito e con più convinzione ri-
spetto al passato recente; si discute, si propone, si
sperimenta, nei luoghi deputati, alle scelte culturali,
alle decisioni politiche negli organismi
amministrativi, nella ri
cerca.Unnodo del problema continua
ad essere quello di produrre studi e metodologie che
riescano anche a definire meglio il significato di
bene culturale nella società attuale, nella coscienza
del valore storico — e quindi non assoluto — delle
scelte critiche che si operano nei contesti reali.
Pare importante richiamare un concetto già
più volte espresso, cioè che sia necessario superare
l'inutile dibattito sui centri antichi (se ridotto alla
dichiarazione di una loro maggiore o minore « stori-
cità»), per aderire invece ad un criterio più
costruttivo e più corretto culturalmente, introducendo ana-
lisi rivolte non alla « struttura della città storica » , ma
alla « struttura storica della città..
Questo principio si salda a misura con i criteri
che sono stati assunti e sviluppati recentemente nel
dibattito sulla città esistente, sul rapporto storia-pro-
getto, sul binomio conservazione-innovazione; ad
esso si riallaccia anche questa esperienza di ricerca
sui Beni culturali ambientali nel Comune di Torino.
La riqualificazione dell'ambiente, intesa come recu-
pero integrale dello spazio urbano e territoriale, dei
suoi connotati storico-culturali, ambientali e naturali
e delle sue possibilità di trasformazione, appariva un
indirizzo metodologico già presente nel Progetto
Preliminare per la revisione del Piano Regolatore
Generale Comunale di Torino del 1980, per la cui
stesura definitiva era stato chiamato a concorrere dal
1981 il Politecnico di Torino con una ricerca sui
Beni culturali come supporto conoscitivo.
Tale obiettivo di riqualificazione attiva implica-
va che i valori storico-culturali del territorio — nella
sua interezza — potessero essere riguardati come
requisito essenziale e fondativo entro un disegno
complessivo di trasformazione, precisando meglio
l'ancóra ambigua terminologia del bene culturale
inteso come risorsa. L'inserimento del problema al-
l'interno della pianificazione del territorio sembra
del resto la sola strada possibile perché la tutela esca
dalla separatezza e prenda parte alle decisioni che
realmente incidono sul nostro patrimonio culturale.
L'intendimento espresso dal Comune implicava
quello di superare un approccio al territorio di tipo
funzionalista, di fatto astrattamente quantitativo, in
favore di un approccio di confronto con la storia ed
il contesto e ha dato sostegno ad una nostra precisa
scelta di metodo.
Il concetto stesso di preesistenza si inserisce al-
l'interno del più vasto dibattito critico e metodologi-
co a cui fa riferimento il settore proprio dell'analisi
dei beni culturali ambientali, quale si
è
profilato e si
va articolando all'interno delle specifiche discipline
storiche, a fianco della pubblicistica e dei convegni
relativi al recupero delle risorse ambientali, al centro
del problema della pianificazione e della
progettualità. Il confronto sui progetti e sulle metodologie rela-
tive al recupero, al riuso, al restauro, e lo stesso
dibattito culturale innescato da tale confronto, evi-
denziano l'indeterminatezza di definizione del cam-
po metodologico e delle stesse procedure di analisi
finora sperimentate ed, insieme, rendono più che
mai attuale ogni proposta articolata e sistematica,
estesa — come questa ad un vasto territorio omo-
geneo per delimitazione amministrativa e per co-
struzione storica.
Ora, a ricerca ultimata, non abbiamo né certezze
consolidate, né la presunzione di aver compiuto ana-
lisi « finite » , riconducibili ad uno « stadio finale » e
conclusivo. Semmai abbiamo i dubbi che sono im-
pliciti in queste ricerche e che derivano anche dalla
distanza da altre posizioni di metodo; poiché cre-
diamo nella discussione aperta su questi temi, non
cerchiamo altro che spazi di confronto.
La città « considerata come principio ideale delle
istorie italiane » costituisce, per Cattaneo, « l'unico
principio per cui possano i trenta secoli delle istorie
italiane ridursi a esposizione evidente e continua
» .
Senza questo filo ideale, la memoria si potrebbe
smarrire nel labirinto delle vicende storiche più di-
sparate, che, se di per sé considerate, apparirebbero
astratte ed estranee alla struttura del territorio; di tale
labirinto non è facile cogliere il significato se non
attraverso, appunto, a « quell'unico principio » che
si fonda sul rapporto tra vicenda storica e ambiente e
17


















