
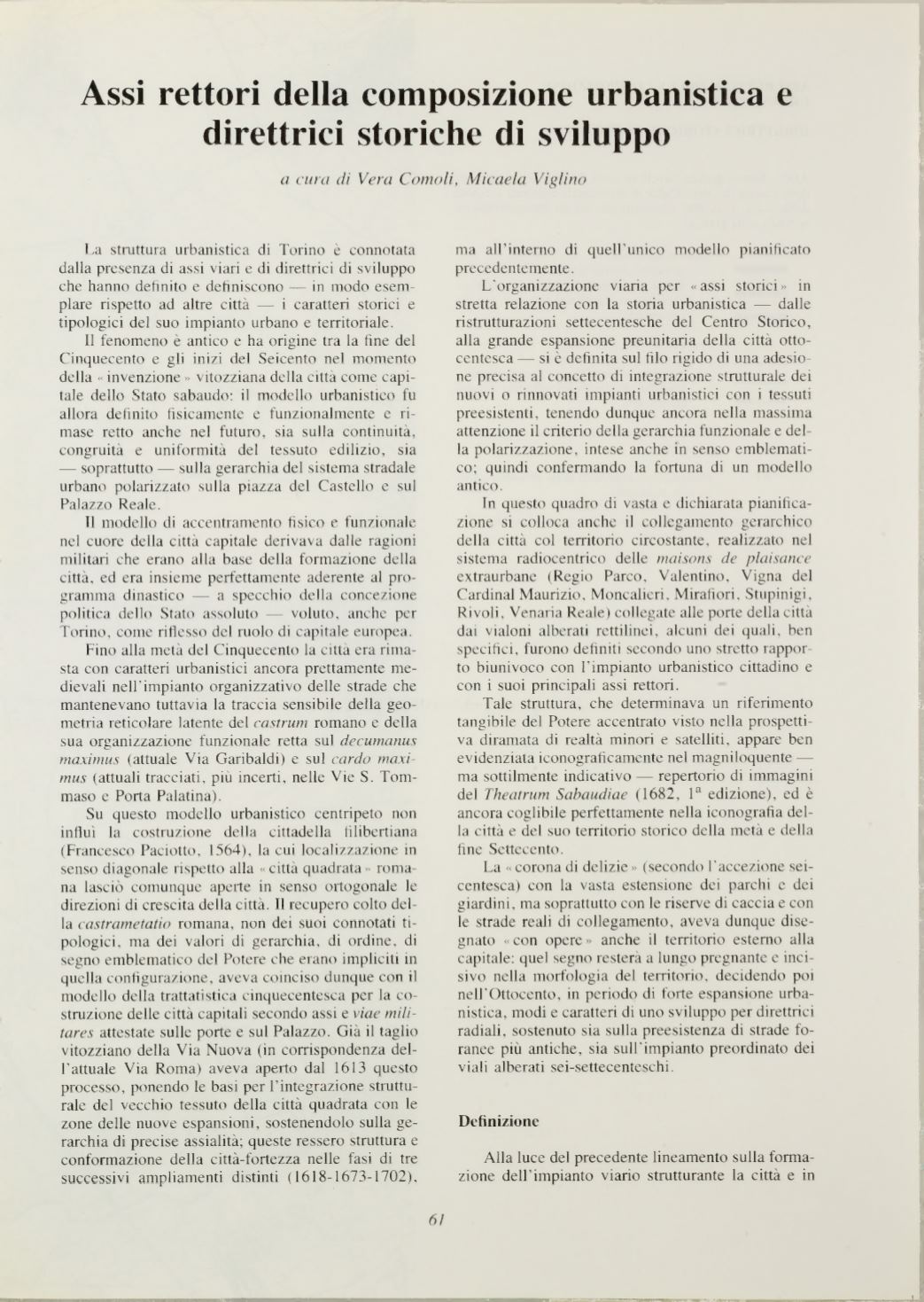
Assi rettori della composizione urbanistica e
direttrici storiche di sviluppo
a cura di Vera Comoli, Micaela Viglino
La struttura urbanistica di Torino è connotata
dalla presenza di assi viari e di direttrici di sviluppo
che hanno definito e definiscono — in modo esem-
plare rispetto ad altre città — i caratteri storici e
tipologici del suo impianto urbano e territoriale.
Il fenomeno è antico e ha origine tra la fine del
Cinquecento e gli inizi del Seicento nel momento
della « invenzione » vitozziana della città come capi-
tale dello Stato sabaudo: il modello urbanistico fu
allora definito fisicamente e funzionalmente e ri-
mase retto anche nel futuro, sia sulla continuità,
congruità e uniformità del tessuto edilizio, sia
soprattutto sulla gerarchia del sistema stradale
urbano polarizzato sulla piazza del Castello e sul
Palazzo Reale.
Il modello di accentramento fisico e funzionale
nel cuore della città capitale derivava dalle ragioni
militari che erano alla base della formazione della
città, ed era insieme perfettamente aderente al pro-
gramma dinastico a specchio della concezione
politica dello Stato assoluto voluto, anche per
Torino, come riflesso del ruolo di capitale europea.
Fino alla metà del Cinquecento la città era rima-
sta con caratteri urbanistici ancora prettamente me-
dievali nell'impianto organizzativo delle strade che
mantenevano tuttavia la traccia sensibile della geo-
metria reticolare latente del
castrum
romano e della
sua organizzazione funzionale retta sul
decumanus
maximus
(attuale Via Garibaldi) e sul
cardo
maximus
(attuali tracciati, più incerti, nelle Vie S. Tom-
maso e Porta Palatina).
Su questo modello urbanistico centripeto non
influì la costruzione della cittadella filibertiana
(Francesco Paciotto, 1564), la cui localizzazione in
senso diagonale rispetto alla « città quadrata » roma-
na lasciò comunque aperte in senso ortogonale le
direzioni di crescita della città.
Il
recupero colto del-
la
castrametatio
romana, non dei suoi connotati ti-
pologici, ma dei valori di gerarchia, di ordine, di
segno emblematico del Potere che erano impliciti in
quella configurazione, aveva coinciso dunque con il
modello della trattatistica cinquecentesca per la co-
struzione delle città capitali secondo assi e
viae
militares
attestate sulle porte e sul Palazzo. Già il taglio
vitozziano della Via Nuova (in corrispondenza del-
l'attuale Via Roma) aveva aperto dal 1613 questo
processo, ponendo le basi per l'integrazione struttu-
rale del vecchio tessuto della città quadrata con le
zone delle nuove espansioni, sostenendolo sulla ge-
rarchia di precise assialità; queste ressero struttura e
conformazione della città-fortezza nelle fasi di tre
successivi ampliamenti distinti (1618-1673-1702),
ma all'interno di quell'unico modello pianificato
precedentemente.
L'organizzazione viaria per «assi storici » in
stretta relazione con la storia urbanistica dalle
ristrutturazioni settecentesche del Centro Storico,
alla grande espansione preunitaria della città
ottocentesca si è definita sul filo rigido di una adesio-
ne precisa al concetto di integrazione strutturale dei
nuovi o rinnovati impianti urbanistici con i tessuti
preesistenti, tenendo dunque ancora nella massima
attenzione il criterio della gerarchia funzionale e del-
la polarizzazione, intese anche in senso emblemati-
co; quindi confermando la fortuna di un modello
antico.
In questo quadro di vasta e dichiarata pianifica-
zione si colloca anche il collegamento gerarchico
della città col territorio circostante, realizzato nel
sistema radiocentrico delle
maisons de plaisance
extraurbane (Regio Parco, Valentino, Vigna del
Cardinal Maurizio, Moncalieri, Mirafiori, Stupinigi,
Rivoli, Venaria Reale) collegate alle porte della città
dai vialoni alberati rettilinei, alcuni dei quali, ben
specifici, furono definiti secondo uno stretto rappor-
to biunivoco con l'impianto urbanistico cittadino e
con i suoi principali assi rettori.
Tale struttura, che determinava un riferimento
tangibile del Potere accentrato visto nella prospetti-
va diramata di realtà minori e satelliti, appare ben
evidenziata iconograficamente nel magniloquente
ma sottilmente indicativo repertorio di immagini
del
Theatrum Sabaudiae
(1682, la edizione), ed è
ancora coglibile perfettamente nella iconografia del-
la città e del suo territorio storico della metà e della
fine Settecento.
La « corona di delizie » (secondo l'accezione sei-
centesca) con la vasta estensione dei parchi e dei
giardini, ma soprattutto con le riserve di caccia e con
le strade reali di collegamento, aveva dunque dise-
gnato «con opere » anche il territorio esterno alla
capitale: quel segno resterà a lungo pregnante e inci-
sivo nella morfologia del territorio, decidendo poi
nell'Ottocento, in periodo di forte espansione urba-
nistica, modi e caratteri di uno sviluppo per direttrici
radiali, sostenuto sia sulla preesistenza di strade fo-
ranee più antiche, sia sull'impianto preordinato dei
viali alberati sei-settecenteschi.
Definizione
Alla luce del precedente lineamento sulla forma-
zione dell'impianto viario strutturante la città e in
61


















