
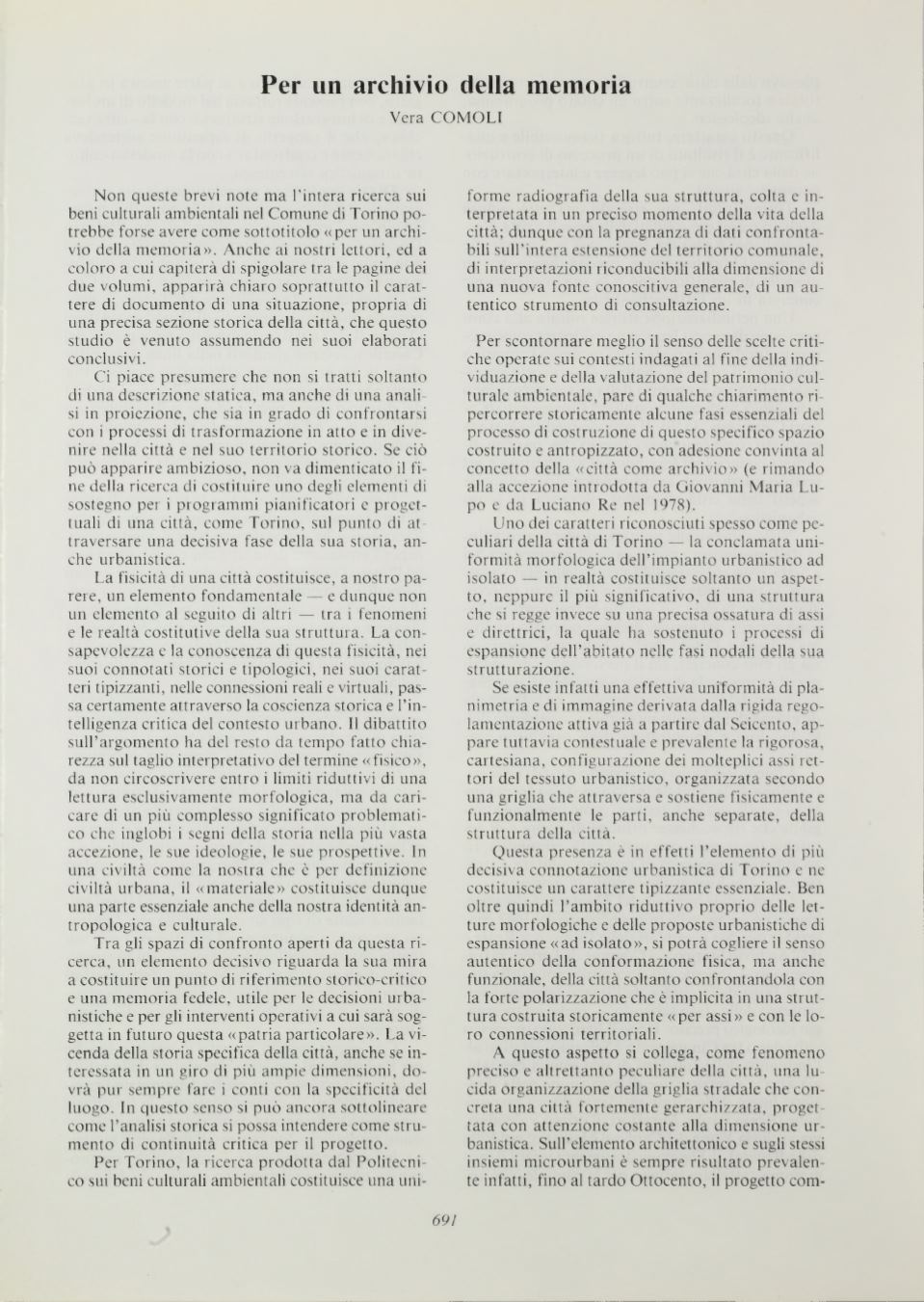
Per un archivio della memoria
Vera COMOLI
Non queste brevi note ma l'intera ricerca sui
beni culturali ambientali nel Comune di Torino po-
trebbe forse avere come sottotitolo «per un archi-
vio della memoria». Anche ai nostri lettori, ed a
coloro a cui capiterà di spigolare tra le pagine dei
due volumi, apparirà chiaro soprattutto il carat-
tere di documento di una situazione, propria di
una precisa sezione storica della città, che questo
studio è venuto assumendo nei suoi elaborati
conclusivi.
Ci piace presumere che non si tratti soltanto
di una descrizione statica, ma anche di una anali-
si in proiezione, che sia in grado di confrontarsi
con i processi di trasformazione in atto e in dive-
nire nella città e nel suo territorio storico. Se ciò
può apparire ambizioso, non va dimenticato il fi-
ne della ricerca di costituire uno degli elementi di
sostegno per i programmi pianificatori e proget-
tuali di una città, come Torino, sul punto di at-
traversare una decisiva fase della sua storia, an-
che urbanistica.
La fisicità di una città costituisce, a nostro pa-
rere, un elemento fondamentale — e dunque non
un elemento al seguito di altri — tra i fenomeni
e le realtà costitutive della sua struttura. La con-
sapevolezza e la conoscenza di questa fisicità, nei
suoi connotati storici e tipologici, nei suoi carat-
teri tipizzanti, nelle connessioni reali e virtuali, pas-
sa certamente attraverso la coscienza storica e l'in-
telligenza critica del contesto urbano. Il dibattito
sull'argomento ha del resto da tempo fatto chia-
rezza sul taglio interpretativo del termine «fisico»,
da non circoscrivere entro i limiti riduttivi di una
lettura esclusivamente morfologica, ma da cari-
care di un più complesso significato problemati-
co che inglobi i segni della storia nella più vasta
accezione, le sue ideologie, le sue prospettive. In
una civiltà come la nostra che è per definizione
civiltà urbana, il «materiale» costituisce dunque
una parte essenziale anche della nostra identità an-
tropologica e culturale.
Tra gli spazi di confronto aperti da questa ri-
cerca, un elemento decisivo riguarda la sua mira
a costituire un punto di riferimento storico-critico
e una memoria fedele, utile per le decisioni urba-
nistiche e per gli interventi operativi a cui sarà sog-
getta in futuro questa «patria particolare». La vi-
cenda della storia specifica della città, anche se in-
teressata in un giro di più ampie dimensioni, do-
vrà pur sempre fare i conti con la specificità del
luogo. In questo senso si può ancora sottolineare
come l'analisi storica si possa intendere come stru-
mento di continuità critica per il progetto.
Per Torino, la ricerca prodotta dal Politecni-
co sui beni culturali ambientali costituisce una uni-
forme radiografia della sua struttura, colta e in-
terpretata in un preciso momento della vita della
città; dunque con la pregnanza di dati confronta-
bili sull'intera estensione del territorio comunale,
di interpretazioni riconducibili alla dimensione di
una nuova fonte conoscitiva generale, di un au-
tentico strumento di consultazione.
Per scontornare meglio il senso delle scelte criti-
che operate sui contesti indagati al fine della indi-
viduazione e della valutazione del patrimonio cul-
turale ambientale, pare di qualche chiarimento ri-
percorrere storicamente alcune fasi essenziali del
processo di costruzione di questo specifico spazio
costruito e antropizzato, con adesione convinta al
concetto della «città come archivio» (e rimando
alla accezione introdotta da Giovanni Maria Lu-
po e da Luciano Re nel 1978).
Uno dei caratteri riconosciuti spesso come pe-
culiari della città di Torino — la conclamata uni-
formità morfologica dell'impianto urbanistico ad
isolato — in realtà costituisce soltanto un aspet-
to, neppure il più significativo, di una struttura
che si regge invece su una precisa ossatura di assi
e direttrici, la quale ha sostenuto i processi di
espansione dell'abitato nelle fasi nodali della sua
strutturazione.
Se esiste infatti una effettiva uniformità di pla-
nimetria e di immagine derivata dalla rigida rego-
lamentazione attiva già a partire dal Seicento, ap-
pare tuttavia contestuale e prevalente la rigorosa,
cartesiana, configurazione dei molteplici assi ret-
tori del tessuto urbanistico, organizzata secondo
una griglia che attraversa e sostiene fisicamente e
funzionalmente le parti, anche separate, della
struttura della città.
Questa presenza è in effetti l'elemento di più
decisiva connotazione urbanistica di Torino e ne
costituisce un carattere tipizzante essenziale. Ben
oltre quindi l'ambito riduttivo proprio delle let-
ture morfologiche e delle proposte urbanistiche di
espansione «ad isolato», si potrà cogliere il senso
autentico della conformazione fisica, ma anche
funzionale, della città soltanto confrontandola con
la forte polarizzazione che è implicita in una strut-
tura costruita storicamente «per assi» e con le lo-
ro connessioni territoriali.
A questo aspetto si collega, come fenomeno
preciso e altrettanto peculiare della città, una lu-
cida organizzazione della griglia stradale che con-
creta una città fortemente gerarchizzata, proget-
tata con attenzione costante alla dimensione ur-
banistica. Sull'elemento architettonico e sugli stessi
insiemi microurbani è sempre risultato prevalen-
te infatti, fino al tardo Ottocento, il progetto corn-
691


















