
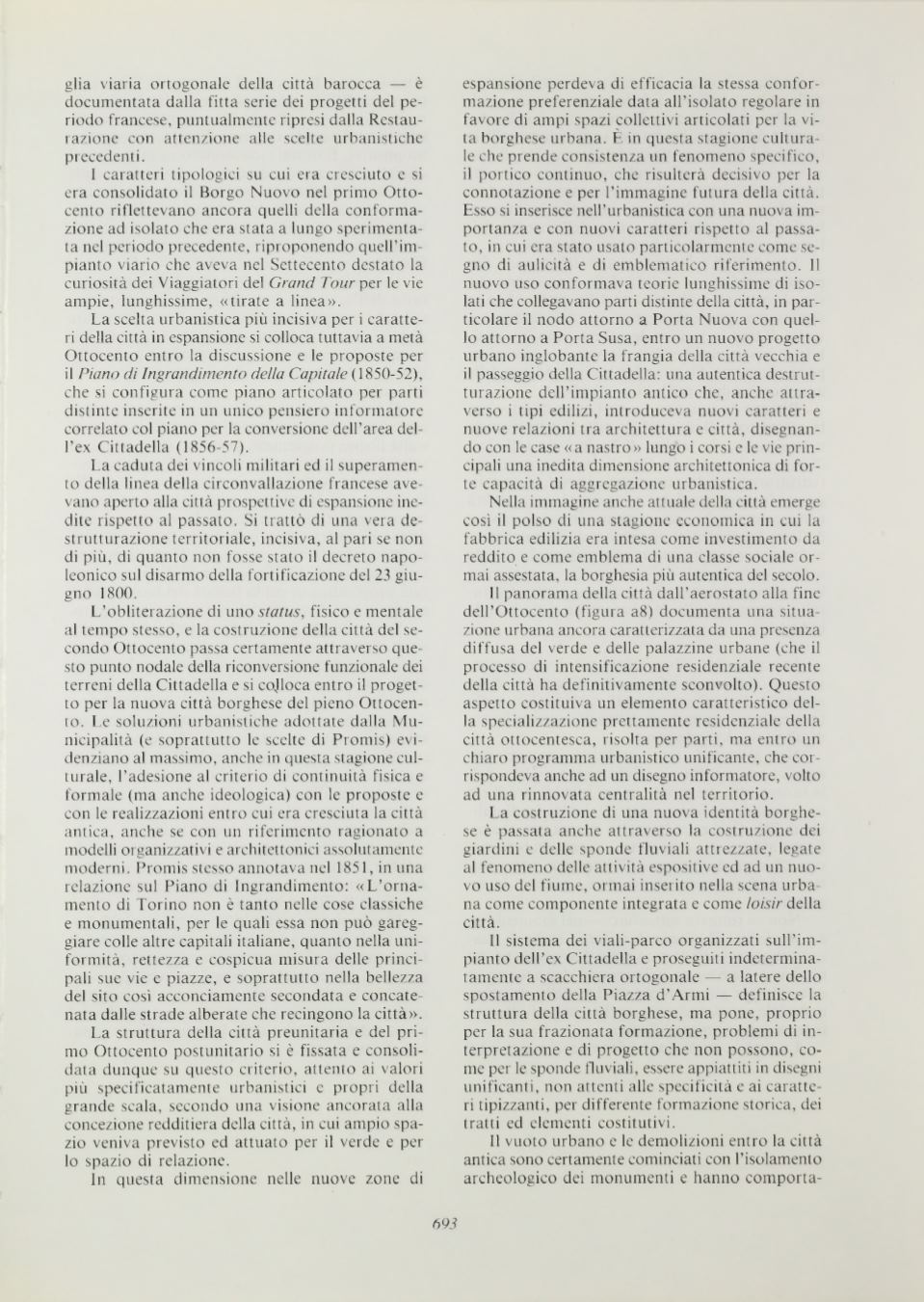
glia viaria ortogonale della città barocca — è
documentata dalla fitta serie dei progetti del pe-
riodo francese, puntualmente ripresi dalla Restau-
razione con attenzione alle scelte urbanistiche
precedenti.
I caratteri tipologici su cui era cresciuto e si
era consolidato il Borgo Nuovo nel primo Otto-
cento riflettevano ancora quelli della conforma-
zione ad isolato che era stata a lungo sperimenta-
ta nel periodo precedente, riproponendo quell'im-
pianto viario che aveva nel Settecento destato la
curiosità dei Viaggiatori del
Grand Tour
per le vie
ampie, lunghissime, «tirate a linea».
La scelta urbanistica più incisiva per i caratte-
ri della città in espansione si colloca tuttavia a metà
Ottocento entro la discussione e le proposte per
il
Piano di Ingrandimento della Capitale
(1850-52),
che si configura come piano articolato per parti
distinte inserite in un unico pensiero informatore
correlato col piano per la conversione dell'area del-
l'ex Cittadella (1856-57).
La caduta dei vincoli militari ed il superamen-
to della linea della circonvallazione francese ave-
vano aperto alla città prospettive di espansione ine-
dite rispetto al passato. Si trattò di una vera de-
strutturazione territoriale, incisiva, al pari se non
di più, di quanto non fosse stato il decreto napo-
leonico sul disarmo della fortificazione del 23 giu-
gno 1800.
L'obliterazione di uno
status,
fisico e mentale
al tempo stesso, e la costruzione della città del se-
condo Ottocento passa certamente attraverso que-
sto punto nodale della riconversione funzionale dei
terreni della Cittadella e si cojloca entro il proget-
to per la nuova città borghese del pieno Ottocen-
to. Le soluzioni urbanistiche adottate dalla Mu-
nicipalità (e soprattutto le scelte di Promis) evi-
denziano al massimo, anche in questa stagione cul-
turale, l'adesione al criterio di continuità fisica e
formale (ma anche ideologica) con le proposte e
con le realizzazioni entro cui era cresciuta la città
antica, anche se con un riferimento ragionato a
modelli organizzativi e architettonici assolutamente
moderni. Promis stesso annotava nel 1851, in una
relazione sul Piano di Ingrandimento: «L'orna-
mento di Torino non è tanto nelle cose classiche
e monumentali, per le quali essa non può gareg-
giare colle altre capitali italiane, quanto nella uni-
formità, rettezza e cospicua misura delle princi-
pali sue vie e piazze, e soprattutto nella bellezza
del sito così acconciamente secondata e concate-
nata dalle strade alberate che recingono la città».
La struttura della città preunitaria e del pri-
mo Ottocento postunitario si è fissata e consoli-
data dunque su questo criterio, attento ai valori
più specificatamente urbanistici e propri della
grande scala, secondo una visione ancorata alla
concezione redditiera della città, in cui ampio spa-
zio veniva previsto ed attuato per il verde e per
lo spazio di relazione.
In questa dimensione nelle nuove zone di
espansione perdeva di efficacia la stessa confor-
mazione preferenziale data all'isolato regolare in
favore di ampi spazi collettivi articolati per la vi-
ta borghese urbana. È in questa stagione cultura-
le che prende consistenza un fenomeno specifico,
il portico continuo, che risulterà decisivo per la
connotazione e per l'immagine futura della città.
Esso si inserisce nell'urbanistica con una nuova im-
portanza e con nuovi caratteri rispetto al passa-
to, in cui era stato usato particolarmente come se-
gno di aulicità e di emblematico riferimento. Il
nuovo uso conformava teorie lunghissime di iso-
lati che collegavano parti distinte della città, in par-
ticolare il nodo attorno a Porta Nuova con quel-
lo attorno a Porta Susa, entro un nuovo progetto
urbano inglobante la frangia della città vecchia e
il passeggio della Cittadella: una autentica destrut-
turazione dell'impianto antico che, anche attra-
verso i tipi edilizi, introduceva nuovi caratteri e
nuove relazioni tra architettura e città, disegnan-
do con le case «a nastro» lungo i corsi e le vie prin-
cipali una inedita dimensione architettonica di for-
te capacità di aggregazione urbanistica.
Nella immagine anche attuale della città emerge
così il polso di una stagione economica in cui la
fabbrica edilizia era intesa come investimento da
reddito e come emblema di una classe sociale or-
mai assestata, la borghesia più autentica del secolo.
Il panorama della città dall'aerostato alla fine
dell'Ottocento (figura a8) documenta una situa-
zione urbana ancora caratterizzata da una presenza
diffusa del verde e delle palazzine urbane (che il
processo di intensificazione residenziale recente
della città ha definitivamente sconvolto). Questo
aspetto costituiva un elemento caratteristico del-
la specializzazione prettamente residenziale della
città ottocentesca, risolta per parti, ma entro un
chiaro programma urbanistico unificante, che cor-
rispondeva anche ad un disegno informatore, volto
ad una rinnovata centralità nel territorio.
La costruzione di una nuova identità borghe-
se è passata anche attraverso la costruzione dei
giardini e delle sponde fluviali attrezzate, legate
al fenomeno delle attività espositive ed ad un nuo-
vo uso del fiume, ormai inserito nella scena urba-
na come componente integrata e come
loisir
della
città.
Il sistema dei viali-parco organizzati sull'im-
pianto dell'ex Cittadella e proseguiti indetermina-
tamente a scacchiera ortogonale — a latere dello
spostamento della Piazza d'Armi — definisce la
struttura della città borghese, ma pone, proprio
per la sua frazionata formazione, problemi di in-
terpretazione e di progetto che non possono, co-
me per le sponde fluviali, essere appiattiti in disegni
unificanti, non attenti alle specificità e ai caratte-
ri tipizzanti, per differente formazione storica, dei
tratti ed elementi costitutivi.
Il vuoto urbano e le demolizioni entro la città
antica sono certamente cominciati con l'isolamento
archeologico dei monumenti e hanno comporta-
693


















