
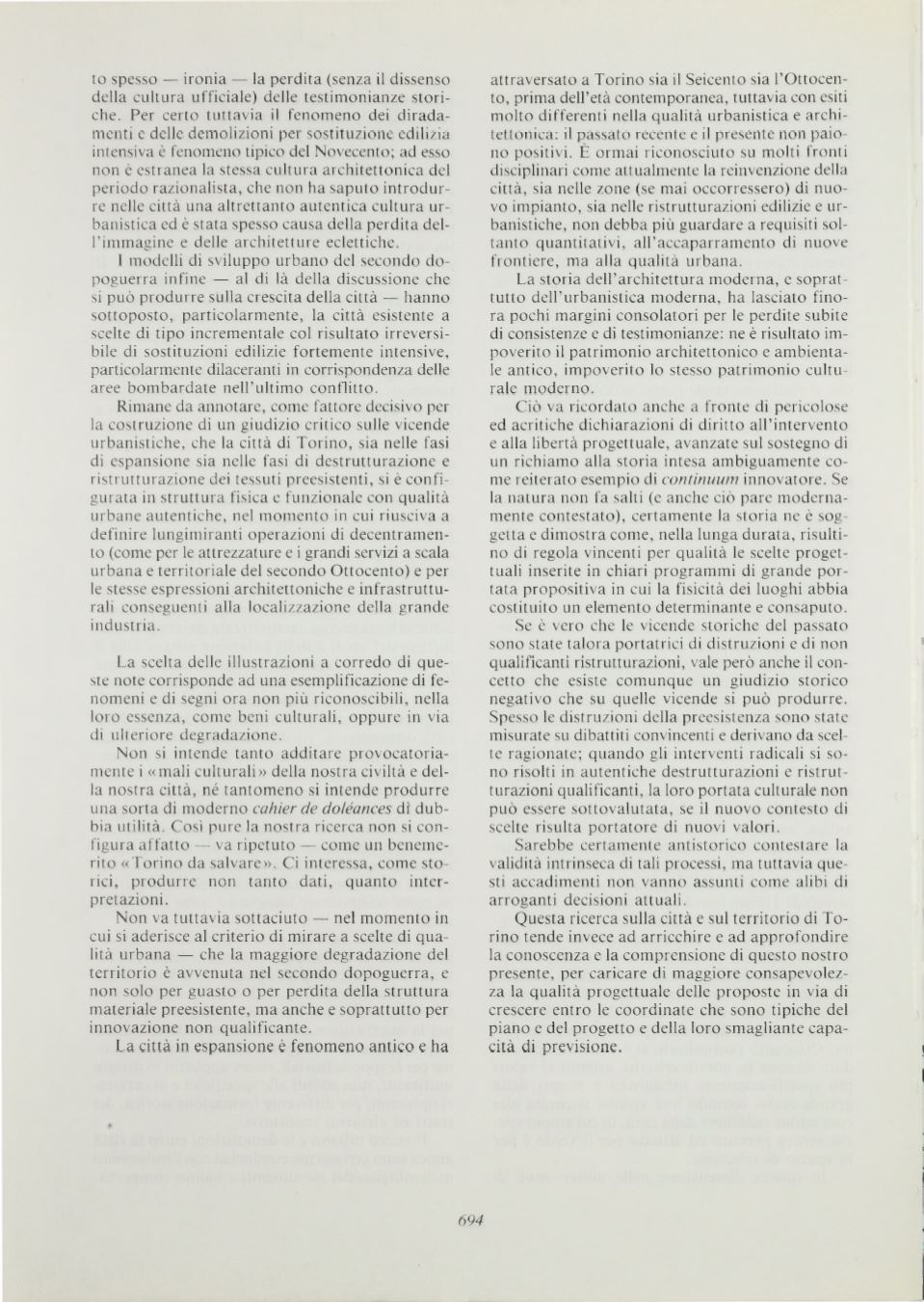
to spesso — ironia — la perdita (senza il dissenso
della cultura ufficiale) delle testimonianze stori-
che. Per certo tuttavia il fenomeno dei dirada-
menti e delle demolizioni per sostituzione edilizia
intensiva è fenomeno tipico del Novecento; ad esso
non è estranea la stessa cultura architettonica del
periodo razionalista, che non ha saputo introdur-
re nelle città una altrettanto autentica cultura ur-
banistica ed è stata spesso causa della perdita del-
l'immagine e delle architetture eclettiche.
I modelli di sviluppo urbano del secondo do-
poguerra infine — al di là della discussione che
si può produrre sulla crescita della città — hanno
sottoposto, particolarmente, la città esistente a
scelte di tipo incrementale col risultato irreversi-
bile di sostituzioni edilizie fortemente intensive,
particolarmente dilaceranti in corrispondenza delle
aree bombardate nell'ultimo conflitto.
Rimane da annotare, come fattore decisivo per
la costruzione di un giudizio critico sulle vicende
urbanistiche, che la città di Torino, sia nelle fasi
di espansione sia nelle fasi di destrutturazione e
ristrutturazione dei tessuti preesistenti, si è confi-
gurata in struttura fisica e funzionale con qualità
urbane autentiche, nel momento in cui riusciva a
definire lungimiranti operazioni di decentramen-
to (come per le attrezzature e i grandi servizi a scala
urbana e territoriale del secondo Ottocento) e per
le stesse espressioni architettoniche e infrastruttu-
rali conseguenti alla localizzazione della grande
industria.
La scelta delle illustrazioni a corredo di que-
ste note corrisponde ad una esemplificazione di fe-
nomeni e di segni ora non più riconoscibili, nella
loro essenza, come beni culturali, oppure in via
di ulteriore degradazione.
Non si intende tanto additare provocatoria-
mente i «mali culturali» della nostra civiltà e del-
la nostra città, né tantomeno si intende produrre
una sorta di moderno
cahier de doléances
di dub-
bia utilità. Così pure la nostra ricerca non si con-
figura affatto — va ripetuto — come un beneme-
rito «Torino da salvare». Ci interessa, come sto-
rici, produrre non tanto dati, quanto inter-
pretazioni.
Non va tuttavia sottaciuto — nel momento in
cui si aderisce al criterio di mirare a scelte di qua-
lità urbana — che la maggiore degradazione del
territorio è avvenuta nel secondo dopoguerra, e
non solo per guasto o per perdita della struttura
materiale preesistente, ma anche e soprattutto per
innovazione non qualificante.
La città in espansione è fenomeno antico e ha
attraversato a Torino sia il Seicento sia l'Ottocen-
to, prima dell'età contemporanea, tuttavia con esiti
molto differenti nella qualità urbanistica e archi-
tettonica: il passato recente e il presente non paio-
no positivi. È ormai riconosciuto su molti fronti
disciplinari come attualmente la reinvenzione della
città, sia nelle zone (se mai occorressero) di nuo-
vo impianto, sia nelle ristrutturazioni edilizie e ur-
banistiche, non debba più guardare a requisiti sol-
tanto quantitativi, all'accaparramento di nuove
frontiere, ma alla qualità urbana.
La storia dell'architettura moderna, e soprat-
tutto dell'urbanistica moderna, ha lasciato fino-
ra pochi margini consolatori per le perdite subite
di consistenze e di testimonianze: ne è risultato im-
poverito il patrimonio architettonico e ambienta-
le antico, impoverito lo stesso patrimonio cultu-
rale moderno.
Ciò va ricordato anche a fronte di pericolose
ed acritiche dichiarazioni di diritto all'intervento
e alla libertà progettuale, avanzate sul sostegno di
un richiamo alla storia intesa ambiguamente co-
me reiterato esempio di
continuum
innovatore. Se
la natura non fa salti (e anche ciò pare moderna-
mente contestato), certamente la storia ne è sog-
getta e dimostra come, nella lunga durata, risulti-
no di regola vincenti per qualità le scelte proget-
tuali inserite in chiari programmi di grande por-
tata propositiva in cui la fisicità dei luoghi abbia
costituito un elemento determinante e consaputo.
Se è vero che le vicende storiche del passato
sono state talora portatrici di distruzioni e di non
qualificanti ristrutturazioni, vale però anche il con-
cetto che esiste comunque un giudizio storico
negativo che su quelle vicende si può produrre.
Spesso le distruzioni della preesistenza sono state
misurate su dibattiti convincenti e derivano da scel-
te ragionate; quando gli interventi radicali si so-
no risolti in autentiche destrutturazioni e ristrut-
turazioni qualificanti, la loro portata culturale non
può essere sottovalutata, se il nuovo contesto di
scelte risulta portatore di nuovi valori.
Sarebbe certamente antistorico contestare la
validità intrinseca di tali processi, ma tuttavia que-
sti accadimenti non vanno assunti come alibi di
arroganti decisioni attuali.
Questa ricerca sulla città e sul territorio di To-
rino tende invece ad arricchire e ad approfondire
la conoscenza e la comprensione di questo nostro
presente, per caricare di maggiore consapevolez-
za la qualità progettuale delle proposte in via di
crescere entro le coordinate che sono tipiche del
piano e del progetto e della loro smagliante capa-
cità di previsione.
694


















