
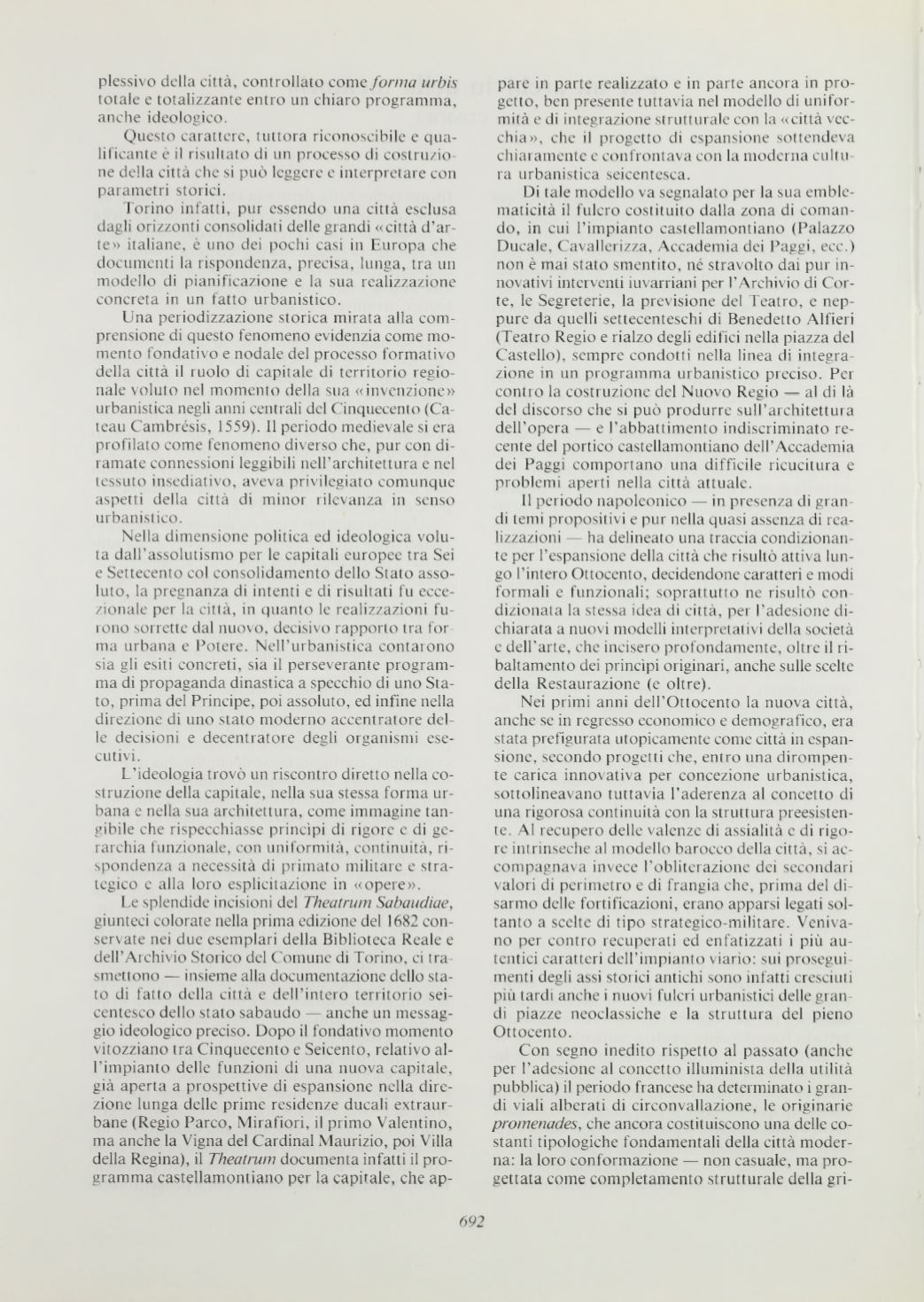
plessivo della città, controllato come
forma urbis
totale e totalizzante entro un chiaro programma,
anche ideologico.
Questo carattere, tuttora riconoscibile e qua-
lificante è il risultato di un processo di costruzio-
ne della città che si può leggere e interpretare con
parametri storici.
Torino infatti, pur essendo una città esclusa
dagli orizzonti consolidati delle grandi «città d'ar-
te» italiane, è uno dei pochi casi in Europa che
documenti la rispondenza, precisa, lunga, tra un
modello di pianificazione e la sua realizzazione
concreta in un fatto urbanistico.
Una periodizzazione storica mirata alla com-
prensione di questo fenomeno evidenzia come mo-
mento fondativo e nodale del processo formativo
della città il ruolo di capitale di territorio regio-
nale voluto nel momento della sua «invenzione»
urbanistica negli anni centrali del Cinquecento (Ca-
teau Cambrésis, 1559). Il periodo medievale si era
profilato come fenomeno diverso che, pur con di-
ramate connessioni leggibili nell'architettura e nel
tessuto insediativo, aveva privilegiato comunque
aspetti della città di minor rilevanza in senso
urbanistico.
Nella dimensione politica ed ideologica volu-
ta dall'assolutismo per le capitali europee tra Sei
e Settecento col consolidamento dello Stato asso-
luto, la pregnanza di intenti e di risultati fu ecce-
zionale per la città, in quanto le realizzazioni fu-
rono sorrette dal nuovo, decisivo rapporto tra for-
ma urbana e Potere. Nell'urbanistica contarono
sia gli esiti concreti, sia il perseverante program-
ma di propaganda dinastica a specchio di uno Sta-
to, prima del Principe, poi assoluto, ed infine nella
direzione di uno stato moderno accentratore del-
le decisioni e decentratore degli organismi ese-
cutivi.
L'ideologia trovò un riscontro diretto nella co-
struzione della capitale, nella sua stessa forma ur-
bana e nella sua architettura, come immagine tan-
gibile che rispecchiasse principi di rigore e di ge-
rarchia funzionale, con uniformità, continuità, ri-
spondenza a necessità di primato militare e stra-
tegico e alla loro esplicitazione in «opere».
Le splendide incisioni del
Theatrum Sabaudiae,
giunteci colorate nella prima edizione del 1682 con-
servate nei due esemplari della Biblioteca Reale e
dell'Archivio Storico del Comune di Torino, ci tra-
smettono — insieme alla documentazione dello sta-
to di fatto della città e dell'intero territorio sei-
centesco dello stato sabaudo — anche un messag-
gio ideologico preciso. Dopo il fondativo momento
vitozziano tra Cinquecento e Seicento, relativo al-
l'impianto delle funzioni di una nuova capitale,
già aperta a prospettive di espansione nella dire-
zione lunga delle prime residenze ducali extraur-
bane (Regio Parco, Mirafiori, il primo Valentino,
ma anche la Vigna del Cardinal Maurizio, poi Villa
della Regina), il
Theatrum
documenta infatti il pro-
gramma castellamontiano per la capitale, che ap-
pare in parte realizzato e in parte ancora in pro-
getto, ben presente tuttavia nel modello di unifor-
mità e di integrazione strutturale con la «città vec-
chia », che il progetto di espansione sottendeva
chiaramente e confrontava con la moderna cultu-
ra urbanistica seicentesca.
Di tale modello va segnalato per la sua emble-
maticità il fulcro costituito dalla zona di coman-
do, in cui l'impianto castellamontiano (Palazzo
Ducale, Cavallerizza, Accademia dei Paggi, ecc.)
non è mai stato smentito, né stravolto dai pur in-
novativi interventi iuvarriani per l'Archivio di Cor-
te, le Segreterie, la previsione del Teatro, e nep-
pure da quelli settecenteschi di Benedetto Alfieri
(Teatro Regio e rialzo degli edifici nella piazza del
Castello), sempre condotti nella linea di integra-
zione in un programma urbanistico preciso. Per
contro la costruzione del Nuovo Regio — al di là
del discorso che si può produrre sull'architettura
dell'opera — e l'abbattimento indiscriminato re-
cente del portico castellamontiano dell'Accademia
dei Paggi comportano una difficile ricucitura e
problemi aperti nella città attuale.
Il periodo napoleonico — in presenza di gran-
di temi propositivi e pur nella quasi assenza di rea-
lizzazioni — ha delineato una traccia condizionan-
te per l'espansione della città che risultò attiva lun-
go l'intero Ottocento, decidendone caratteri e modi
formali e funzionali; soprattutto ne risultò con-
dizionata la stessa idea di città, per l'adesione di-
chiarata a nuovi modelli interpretativi della società
e dell'arte, che incisero profondamente, oltre il ri-
baltamento dei principi originari, anche sulle scelte
della Restaurazione (e oltre).
Nei primi anni dell'Ottocento la nuova città,
anche se in regresso economico e demografico, era
stata prefigurata utopicamente come città in espan-
sione, secondo progetti che, entro una dirompen-
te carica innovativa per concezione urbanistica,
sottolineavano tuttavia l'aderenza al concetto di
una rigorosa continuità con la struttura preesisten-
te. Al recupero delle valenze di assialità e di rigo-
re intrinseche al modello barocco della città, si ac-
compagnava invece l'obliterazione dei secondari
valori di perimetro e di frangia che, prima del di-
sarmo delle fortificazioni, erano apparsi legati sol-
tanto a scelte di tipo strategico-militare. Veniva-
no per contro recuperati ed enfatizzati i più au-
tentici caratteri dell'impianto viario: sui prosegui-
menti degli assi storici antichi sono infatti cresciuti
più tardi anche i nuovi fulcri urbanistici delle gran-
di piazze neoclassiche e la struttura del pieno
Ottocento.
Con segno inedito rispetto al passato (anche
per l'adesione al concetto illuminista della utilità
pubblica) il periodo francese ha determinato i gran-
di viali alberati di circonvallazione, le originarie
promenades,
che ancora costituiscono una delle co-
stanti tipologiche fondamentali della città moder-
na: la loro conformazione — non casuale, ma pro-
gettata come completamento strutturale della gri-
692


















