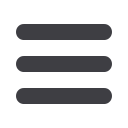
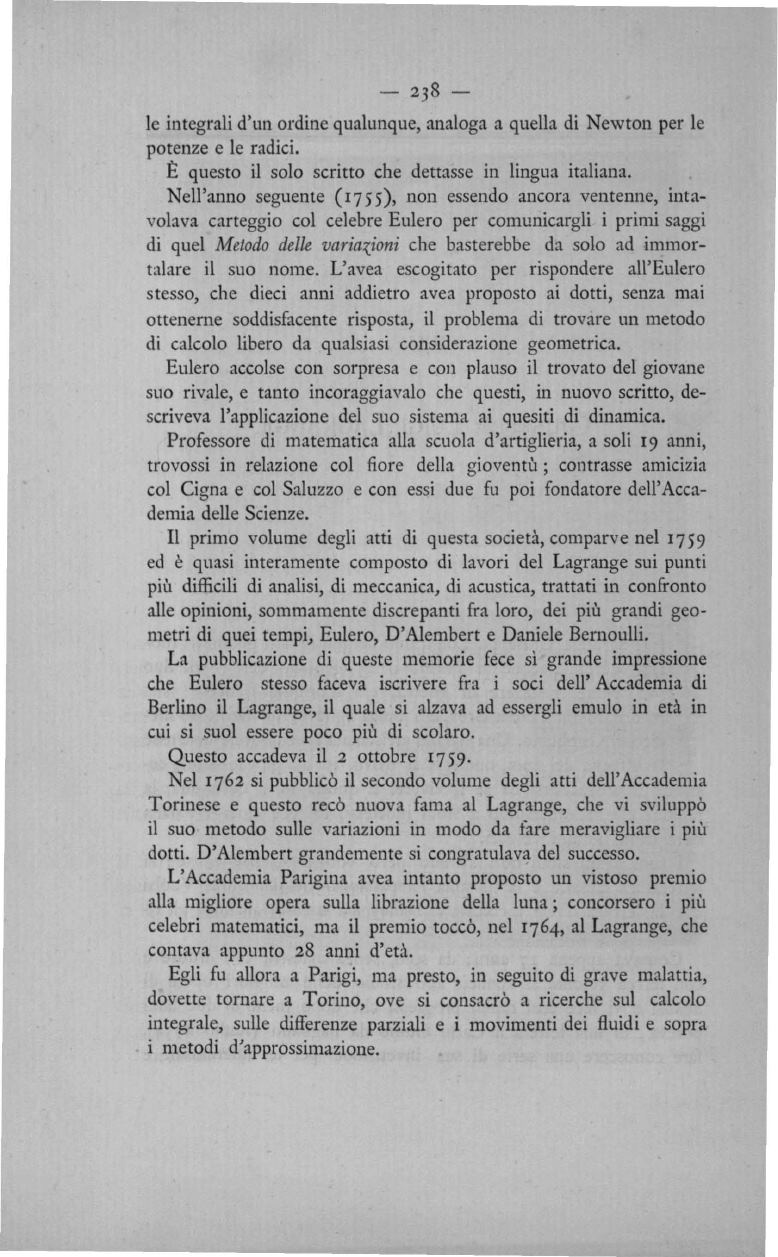
- 238 -
le integrali d'un ordine qualunque, analoga a quella di Newton per le
potenze e le radici.
È
questo il solo scritto che dettasse in lingua italiana.
Nell'anno seguente (17 55), non essendo ancora ventenne, inta–
volava carteggio col celebre Eulero per comunicargli i primi saggi
di quel
Metodo delle variazioni
che basterebbe da solo ad immor–
talare il suo nome. L'avea escogitato per rispondere all'Eulero
stesso, che dieci anni addietro avea proposto ai dotti, senza mai
ottenerne soddisfacente risposta, il problema di trovare un metodo
di calcolo libero da qualsiasi considerazione geometrica.
Eulero accolse con sorpresa e con plauso il trovato del giovane
suo rivale, e tanto incoraggiavalo che questi, in nuovo scritto, de–
scriveva l'applicazione del suo sistema ai quesiti di dinamica.
Professore di matematica alla scuola d'artiglieria, a soli 19 anni,
trovossi in relazione col fiore della
gioventù ;
contrasse amicizia
col Cigna e col Saluzzo e con essi due fu poi fondatore dell'Acca–
demia delle Scienze.
Il primo volume degli atti di questa società, comparve nel 1759
ed è quasi interamente composto di lavori del Lagrange sui punti
più difficili di analisi, di meccanica, di acustica, trattati in confronto
alle opinioni, sommamente discrepanti fra loro, dei più grandi geo–
metri di quei tempi, Eulero, D'Alembert e Daniele Bernoulli.
La pubblicazione di queste memorie fece si grande impressione
che Eulero stesso faceva iscrivere fra i soci dell' Accademia di
Berlino
il
Lagrange, il quale si alzava ad essergli emulo in età in
cui si suol essere poco più di scolaro.
Questo accadeva
il
2
ottobre 1759.
Nel 1762 si pubblicò
il
secondo volume degli atti dell'Accademia
Torinese e questo recò nuova fama al Lagrange, che vi sviluppò
il suo metodo sulle variazioni in modo da fare meravigliare i più
dotti. D'Alembert grandemente si congratulava del successo.
L'Accademia Parigina avea intanto proposto un vistoso premio
alla migliore opera sulla librazione della luna; concorsero i più
celebri matematici, ma
il
premio toccò, nel 1764, al Lagrange, che
contava appunto
28
anni d'ed.
Egli fu allora a Parigi, ma presto, in seguito di grave malattia,
dovette tornare a T orino, ove si consacrò a ricerche sul calcolo
integrale, sulle differenze parziali e i movimenti dei fluidi e sopra
i metodi d'approssimazione.


















