
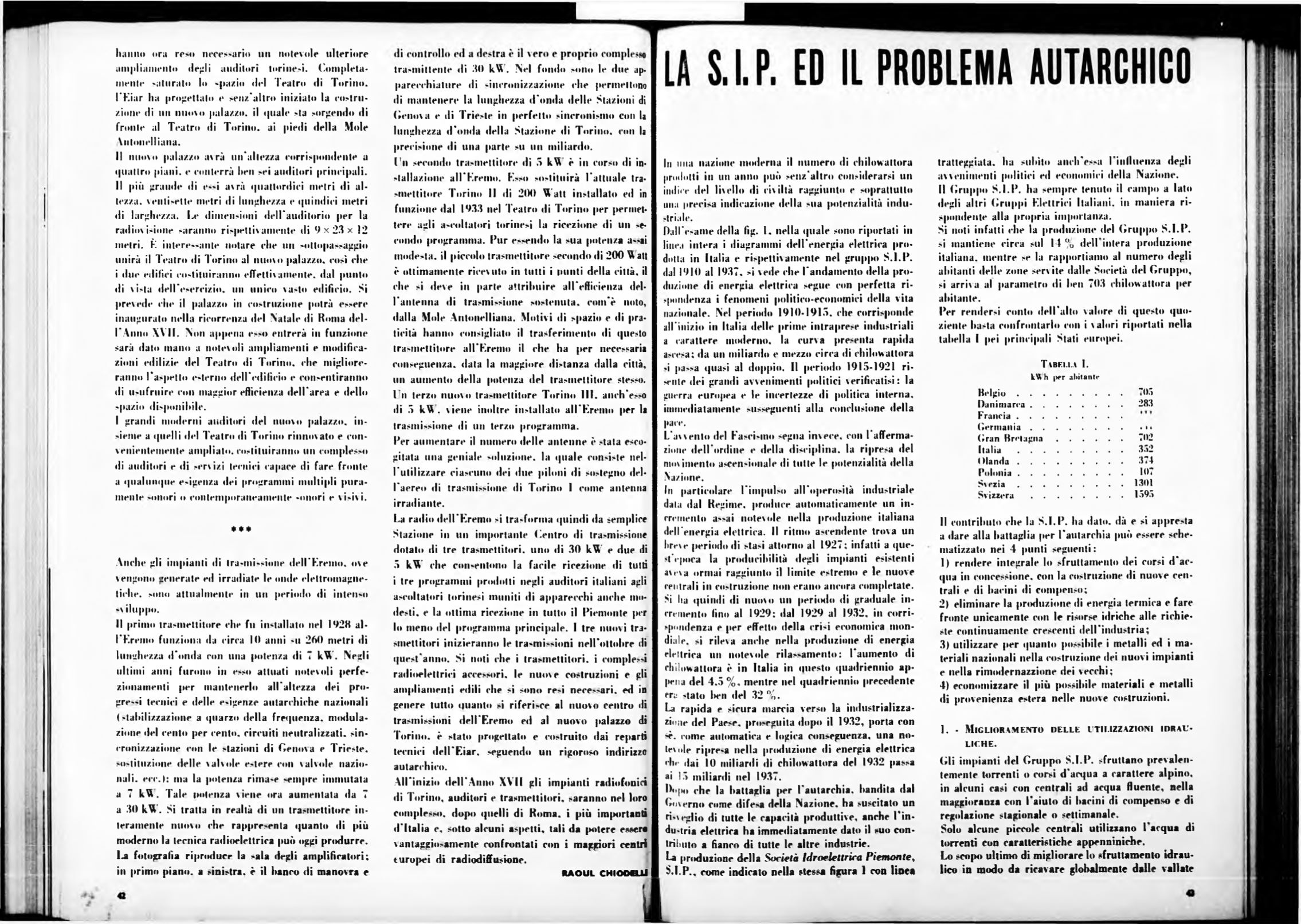
hanno ora reso necessario un notevole ulteriore
ampliamento defili auditori torinesi. Completa
mente «attirato lo spazio del Teatro di Torino.
l'E ia r ha progettato e senz'altro iniziato la costru
zione di un nuovo palazzo, il «piale sta sorbendo di
fronte al Teatro di Torino, ai piedi della Mole
Autonelliana.
Il nuo\o palazzo a\rà un'altezza corrispondente a
quattro piani, e conterrà ben sei auditori principali.
Il più firaude di es«i a\rà quattordici metri di al
tezza. ventisette metri di lunghezza e quindici metri
di larghezza. Le dimensioni dell'auditorio per la
radio\ isione saranno rispettivamente di 9 x 23 x 12
metri. È interessante notare clic mi sottopassaggio
unirà il Teatro di Torino al nuovo palazzo, cosi che
i due edifici costituiranno elTettivamente. dal punto
di vista dell'esercizio, un unico \asto edifìcio. Si
prevede che il palazzo in costruzione potrà essere
inaugurato nella ricorrenza del Natale di Roma del-
I *Anno X V II. Non appena esso entrerà ili funzione
sarà dato mano a notevoli ampliamenti e modifica
zioni edilizie del Teatro di Torino, che migliore
ranno l'aspetto esterno dell'edifìcio e consentiranno
di usufruire con maggior efficienza dell'area e dello
spazio disponibile.
I grandi moderni auditori del nuovo palazzo, in
sieme a quelli del Teatro di Torino rinnovato e con
venientemente ampliato, costituiranno uu complesso
di auditori e di serv izi tecnici capace di fare fronte
a qualunque esigenza dei programmi multipli pura
mente sonori o contemporaneamente «onori e visivi.
* * *
Anche fili impianti di tra«mi«sioiie dell'Kremo. ove
vendono «generate ed irradiate le onde elettromagne
tiche. sono attualmente in uu periodo di intenso
•\ iluppo.
II primo trasmettitore che fu installato nel 1928 al-
I*Eremo funziona da circa 10 anni «u 260 metri di
lunghezza d'onda con una potenza di 7 kW . Negli
ultimi anni furono in esso attuati notevoli perfe
zionamenti per mantenerlo all'altezza dei prò*
}ire«*i tecnici e delle e«igenze autarchiche nazionali
(stabilizzazione a quarzo della frequenza, modula
zione del cento per cento, circuiti neutralizzati, sin
cronizzazione con le stazioni di Genova e Trieste,
sostituzione delle \al\ole estere con \alvole nazio
nali. ecc.): ma la potenza rimase sempre immutata
a 7 k\X . Tale potenza viene ora aumentata da 7
a 30 kW . Si tratta in realtà di un trasmettitore in
teramente nuovo che rappresenta quanto di più
moderno la tecnica radioelettrica può oggi produrre.
I.a fotografìa riproduce la sala degli amplificatori;
in primo piano, a sinistra, è il hancu di manovra e
trasmittente di 30 k ^ . Nel fondo sono le due ap-
parecchiature di sincronizzazione che permettono
di mantenere la luiifiliezza d'onda delle Stazioni di
Genova e di Trieste in perfetto sincronismo con la
luiifghezza d ’onda della Stazione di Torino, con la
precisione di una parte su un miliardo.
l Tn secondo trasmettitore di 3 k\\ è in corso di in
stallazione ali*Eremo. Esso sostituirà l'attuale tra
smettitore Torino II di 200 W att installato ed in
funzione dal 1933 nel Teatro di Torino per permet
tere asili ascoltatori torinesi la ricezione di un se
condo profgramma. Pu r essendo la sua potenza a«sai
modesta, il piccolo trasmettitore secondo di 200 Vi att
è ottimamente ricevuto in tutti i punti della città, il
che si deve ili parte attribuire all'cHicienza del
l'antenna di trasmissione sostenuta, com'è noto,
dalla Mole Autonelliana. Motivi di spazio e di pra
ticità hanno consigliato il trasferimento di questo
trasmettitore all*Eremo il che ha per necessaria
conseguenza, data la mafifiiore distanza dalla città,
un aumento della potenza del trasmettitore stesso.
I n terzo nuovo trasmettitore Torino I I I . anch'esso
di 5 kW . viene inoltre installato all'Erem o per la
trasmissione di un terzo profgramma.
Per aumentare il numero delle antenne è stata esco-
fgitata una fgeniale soluzione, la quale consiste nel-
l'utilizzare ciascuno dei due piloni di sostegno del
l'aereo di trasmissione di Torino I come antenna
irradiante.
La radio dell*Eremo si trasforma quindi da semplice
Stazione in un importante dentro di trasmissione
dotato di tre trasmettitori, uno di 30 kW e due di
3 k W che consentono la facile ricezione di tutti
i tre profgrammi prodotti nefgli auditori italiani afili
ascoltatori torinesi muniti di apparecchi anche mo
desti. e la ottima ricezione in tutto il Piemonte per
lo meno del profgramma principale. I tre nuovi tra
smettitori inizieranno le trasmissioni nell'ottobre di
quest'anno. Si noti che i trasmettitori, i complessi
radioelettrici accessori, le nuove costruzioni e (gli
ampliamenti edili che si sono resi necessari, ed in
genere tutto quanto si riferisce al nuovo centro di
trasmissioni dell'Erenio ed al nuovo palazzo di
Torino, è stato progettato e costruito dai reparti
tecnici d e ll'E ia r. seguendo un rigoroso indirizzo
autarchico.
A ll'in izio d ell'Anno X V II gli impianti radiofonici
di Torino, auditori e trasmettitori, saranno nel loro
complesso, dopo quelli di Koma. i più importanti
d 'Italia e, sotto alcuni aspetti, tali da potere esser*
vantaggiosamente confrontati con i maggiori centri
turopei di radiodiffusione.
RAOUL CHIOD ILO
In una nazione moderna il numero di chilowattora
prodotti in un anno può senz'altro considerarsi un
indire del livello di civiltà raggiunto e soprattutto
una precisa indicazione della sua potenzialità indu
striale.
Dall'esame della fìg. 1. nella quale sono riportati in
linea intera i diagrammi dell'energia elettrica pro
dotta in Italia e rispettivamente nel gruppo S .I.P .
dal 1910 al 1937. si vede che l'andamento della pro
duzione di energia elettrica segue con perfetta r i
spondenza i fenomeni politico-economici della vita
nazionale. Nel periodo 1910-1913. che corrisponde
all'inizio in Italia delle prime intraprese industriali
a carattere moderno, la curva presenta rapida
ascesa; da un miliardo e mezzo circa di chilowattora
«i passa quasi al doppio. Il periodo 1915-1921 r i
sente dei grandi avvenimenti politici verificatisi: la
jiuerra europea e le incertezze di politica interna,
immediatamente susseguenti alla conclusione della
pace.
L ’avvento del Fascismo segna invece, con l'afferma
zione d e ll’ordine e della disciplina, la ripresa del
movimento ascensionale di tutte le potenzialità della
Nazione.
In particolare l'impulso all'operosità industriale
data dal Regime, produce automaticamente un in
cremento assai notevole nella produzione italiana
dell'energia elettrica. Il ritmo ascendente trova un
breve periodo di stasi attorno al 1927; infatti a que
st’epoca la producibilità degli impianti esistenti
aveva ormai raggiunto il limite estremo e le nuove
centrali in costruzione non erano ancora completate.
Si lia quindi di nuovo un periodo di graduale in
cremento fino al 1929: dal 1929 al 1932, in corri
spondenza e per effetto della crisi economica mon
diale. si rileva anche nella produzione di energia
elettrica un notevole rilassamento: l'aumento di
chilowattora è in Italia in questo quadriennio ap
pena del 4.3 % , mentre nel quadriennio precedente
era «tato ben del 32
% .
La rapida e sicura marcia verso la industrializza
zione del Paese, proseguita dopo il 1932, porta con
sè. come automatica e logica conseguenza, una no
tevole ripresa nella prefazione di energia elettrica
che dai 10 miliardi di chilowattora del 1932 passa
ai 13 miliardi nel 1937.
Dopo che la battaglia per l'autarchia, bandita dal
Governo come difesa della Nazione, ha suscitato un
ri«\eglio di tutte le capacità produttive, anche l'in-
du«tria elettrica ha immediatamente dato il suo con
tributo a fianco di tutte le altre industrie.
La produzione della
Società Id ro elettrica Piem o n te
,
S .I.P ., come indicato nella stessa figura 1 con linea
tratteggiata, ha subito aneli'essa 1 influenza degli
avvenimenti politici ed economici della Nazione.
Il Gruppo S .I.P . ha sempre tenuto il campo a lato
degli altri G ruppi Elettrici Italiani, in maniera r i
spondente alla propria importanza.
Si noti infatti che la produzione ilei Gruppo S .I.P .
si mantiene circa sul 1-1 % dell intera produzione
italiana, mentre se la rapportiamo al numero degli
abitanti «Ielle zone serv ite dalle Società del Gruppo,
si arriva al parametro di ben 703 chilowattora per
abitante.
Per rendersi conto dell'alto valore di questo quo
ziente basta confrontarlo con i valori riportati nella
tabella I pei principali Stati europei.
T
vbei
.
i
.
a
I.
k\X h (*rr abitante
B e lg i o ......................................"05
Danimarca................................. 283
Fra n cia......................................
G e rm a n ia .................................
. »»
Gran B r e ta g n a ........................702
I t a l i a ......................................352
( M anda......................................374
Po lo n ia......................................107
S v e z i a ......................................1301
S v iz z e r a ................................. 1595
Il contributo che la S .I.P . ha dato, dà e si appresta
a dare alla battaglia per l'autarchia può essere sche
matizzato nei 4 punti seguenti:
1) rendere integrale lo sfruttamento dei corsi d 'ac
qua in concessione, con la costruzione di nuove cen
trali e di bacini di compenso;
2) eliminare la produzione di energia termica e fare
fronte unicamente con le risorse idriche alle richie
ste continuamente crescenti dell’industria;
3) utilizzare per quanto possibile i metalli ed i ma
teriali nazionali nella costruzione dei nuovi impianti
e nella rimodernazzione dei vecchi;
4) economizzare il più possibile materiali e metalli
di provenienza estera nelle nuove costruzioni.
1. - M
ig lio r a m en t o
d e l l e
u t iliz z a z io n i
id r a u
l ic h e
.
G li impianti del Gruppo S .I.P . sfruttano prevalen
temente torrenti o corsi d ’acqua a carattere alpino,
in alcuni casi con centrali ad acqua fluente, nella
maggioranza con l ’aiuto di bacini di compenso e di
regolazione stagionale o settimanale.
Solo alcune piccole centrali utilizzano 1 acqua di
torrenti con caratteristiche appenniniche.
Lo scopo ultimo di migliorare lo sfruttamento idrau
lico in modo da ricavare globalmente dalle vallate


















