
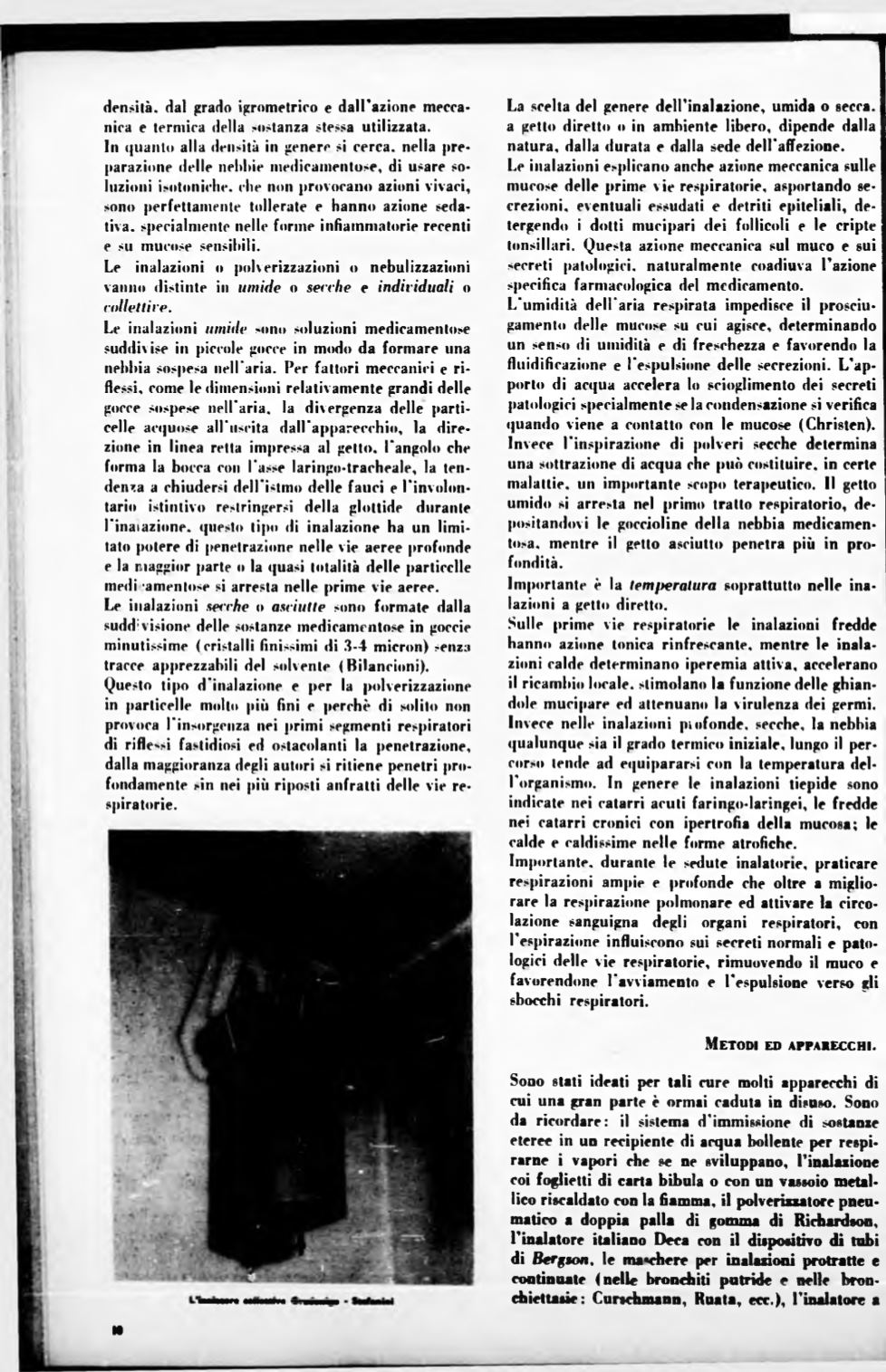
densità, dal grado igrometrico e dall'azione mecca
nica e termica della sostanza stessa utilizzata.
In quanto alla densità in genere si cerca, nella pre
parazione delle nebbie medicamentose, di usare so
luzioni isotoniche, che non provocano azioni vivaci,
sono perfettamente tollerate e hanno azione seda
tiva. specialmente nelle forme infiammatorie recenti
e su mucose sensibili.
Le inalazioni o polverizzazioni o nebulizzazioni
vanno distinte in
umide
o
secche
e
individuali
o
collettive.
Le inalazioni
umide
sono soluzioni medicamentose
suddivise in piccole gocce in modo da formare una
nebbia sospesa nell'aria. Per fattori meccanici e ri
flessi, come le dimensioni relativamente grandi delle
gocce sospese nell'aria, la divergenza delle parti-
celle acquose all'uscita dall'apparecchio, la dire
zione in linea retta impressa al getto, l'angolo che
forma la bocca con l'asse laringo-tracheale, la ten
denza a chiudersi dell'istmo delle fauci e l'involon
tario istintivo restringersi della glottide durante
l'inalazione, questo tipo di inalazione ha un limi
tato potere di penetrazione nelle vie aeree profonde
e la maggior parte o la quasi totalità delle particclle
medi •amentose si arresta nelle prime vie aeree.
Le inalazioni
sei'che
o
asciutte
sono formate dalla
suddivisione delle sostanze medicamentose in goccie
minutissime (cristalli finissimi di 3-4 micron) senza
tracce apprezzabili del solvente ( Bilancioni).
Questo tipo d'inalazione e per la polverizzazione
in particelle molto più fini e perchè di solito non
provoca l'insorgenza nei primi segmenti respiratori
di riflessi fastidiosi ed ostacolanti la penetrazione,
dalla maggioranza degli autori si ritiene penetri pro
fondamente >*in nei più riposti anfratti delle vie re
spiratorie.
La scelta del genere dell'inalazione, umida o secca,
a getto diretto o in ambiente libero, dipende dalla
natura, dalla durata e dalia sede dell'affezione.
Le inalazioni e>plicano anche azione meccanica sulle
mucose delle prime vie respiratorie, asportando se
crezioni. eventuali essudati e detriti epiteliali, de
tergendo i dotti mucipari dei follicoli e le cripte
tonsillari. Questa azione meccanica sul muco e sui
secreti patologici, naturalmente coadiuva l'azione
specifica farmacologica del medicamento.
L'umidità dell'aria respirata impedisce il prosciu
gamento delle mucose su cui agisce, determinando
un sensi» di umidità e di freschezza e favorendo la
fluidificazione e l'espulsione delle secrezioni. L'ap
porto di acqua accelera lo scioglimento dei secreti
patologici specialmente se la condensazione si verifica
quando viene a contatto con le mucose (Christen).
Invece l'inspirazione di polveri secche determina
una sottrazione di acqua che può costituire, in certe
malattie, un importante scopo terapeutico. Il getto
umido si arresta nel primo tratto respiratorio, de
positandovi le goccioline della nebbia medicamen
tosa. mentre il getto asciutto penetra più in pro
fondità.
Importante è la
tem/teratura
soprattutto nelle ina
lazioni a getto diretto.
Sulle prime vie respiratorie le inalazioni fredde
hanno azione tonica rinfrescante, mentre le inala
zioni calde determinano iperemia attiva, accelerano
il ricambio locale, stimolano la funzione delle ghian
dole mucipare ed attenuano la virulenza dei germi.
Invece nelle inalazioni piofonde, secche, la nebbia
qualunque sia il grado termici» iniziale, lungo il per
corso tende ad equipararsi con la temperatura del
l'organismo. In genere le inalazioni tiepide sono
indicate nei catarri acuti faringo-laringei, le fredde
nei catarri cronici con ipertrofìa della mucosa; le
calde e caldissime nelle forme atrofiche.
Importante, durante le sedute inalatone, praticare
respirazioni ampie e profonde che oltre a miglio
rare la respirazione polmonare ed attivare la circo
lazione sanguigna degli organi respiratori, con
l'espirazione influiscono sui secreti normali e pato
logici delle vie respiratorie, rimuovendo il muco e
favorendone l'avviamento e l'espulsione verso gli
sbocchi respiratori.
M
e t o d i
ed
a p p a r e c c h i
.
Sono stati ideati per tali cure molti apparecchi di
cui una gran parte è ormai caduta in disuso. Sono
da ricordare: il sistema d'immissione di sostanze
eteree in un recipiente di acqua bollente per respi
rarne i vapori che se ne sviluppano, l’inalazione
coi foglietti di carta bibula o con un vassoio metal
lico riscaldato con la fiamma, il polverizzatore pneu
matico a doppia palla di gomma di Rirhardson,
l’inalatore italiano Deca con il dispositivo di tubi
di
Bergaon.
le ma«chere per inalazioni protratte e
continuate (nelle bronchiti putride e nelle bron-
chiettasie: Curschmann, Ruata, ecc.), l’inalatore a
M


















