
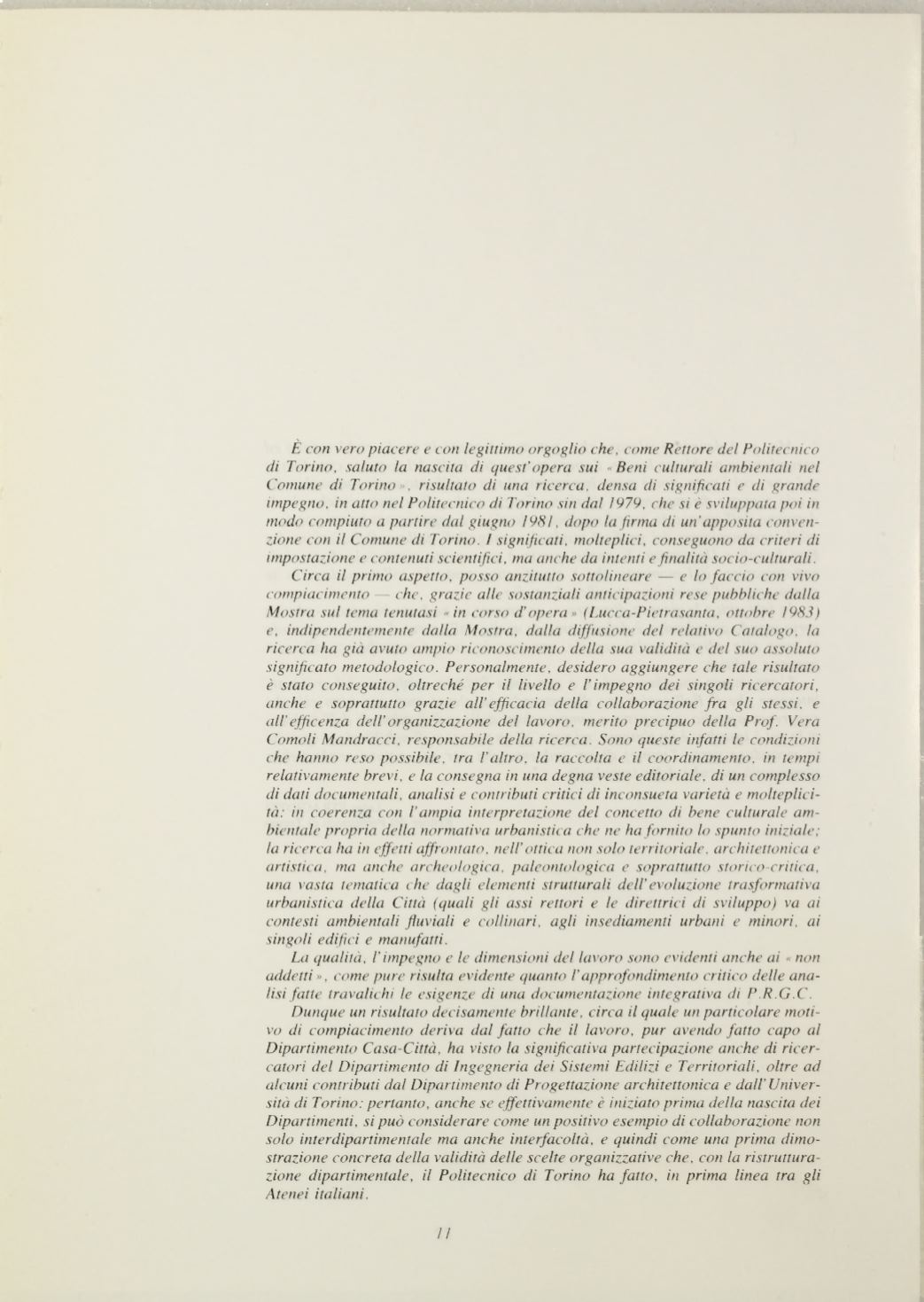
È con vero piacere e con legittimo orgoglio che, come Rettore del Politecnico
di Torino, saluto la nascita di quest'opera sui « Beni culturali ambientali nel
Comune di Torino » , risultato di una ricerca, densa di significati e di grande
impegno, in atto nel Politecnico di Torino sin dal 1979, che si è sviluppata poi in
modo compiuto a partire dal giugno 1981, dopo la firma di un'apposita conven-
zione con il Comune di Torino. I significati, molteplici, conseguono da criteri di
impostazione e contenuti scientifici, ma anche da intenti e finalità socio-culturali.
Circa il primo aspetto, posso anzitutto sottolineare — e lo faccio con vivo
compiacimento — che, grazie alle sostanziali anticipazioni rese pubbliche dalla
Mostra sul tema tenutasi «
in
corso d'opera» (Lucca-Pietrasanta, ottobre 1983)
e, indipendentemente dalla Mostra, dalla diffusione del relativo Catalogo, la
ricerca ha già avuto ampio riconoscimento della sua validità e del suo assoluto
significato metodologico. Personalmente, desidero aggiungere che tale risultato
è stato conseguito, oltreché per il livello e l' impegno dei singoli ricercatori,
anche e soprattutto grazie all'efficacia della collaborazione fra gli stessi, e
all' efficienza dell' organizzazione del lavoro, merito precipuo della Prof. Vera
Comoli Mandracci, responsabile della ricerca. Sono queste infatti le condizioni
che hanno reso possibile, tra l'altro, la raccolta e il coordinamento, in tempi
relativamente brevi, e la consegna in una degna veste editoriale, di un complesso
di dati documentali, analisi e contributi critici di inconsueta varietà e
molteplicità: in coerenza con l'ampia interpretazione del concetto di bene culturale am-
bientale propria della normativa urbanistica che ne ha fornito lo spunto iniziale;
la ricerca ha in effetti affrontato, nell' ottica non solo territoriale, architettonica e
artistica, ma anche archeologica, paleontologica e soprattutto storico-critica,
una vasta tematica che dagli elementi strutturali dell'evoluzione trasformativa
urbanistica della Città (quali gli assi rettori e le direttrici di sviluppo) va ai
contesti ambientali fluviali e collinari, agli insediamenti urbani e minori, ai
singoli edifici e manufatti.
La qualità, l' impegno e le dimensioni del lavoro sono evidenti anche ai « non
addetti », come pure risulta evidente quanto l'approfondimento critico delle ana-
lisi fatte travalichi le esigenze di una documentazione integrativa di P.R.G.C.
Dunque un risultato decisamente brillante, circa il quale un particolare moti-
vo di compiacimento deriva dal fatto che il lavoro, pur avendo fatto capo al
Dipartimento Casa-Città, ha visto la significativa partecipazione anche di ricer-
catori del Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali, oltre ad
alcuni contributi dal Dipartimento di Progettazione architettonica e dall' Univer-
sità di Torino: pertanto, anche se effettivamente è iniziato prima della nascita dei
Dipartimenti, si può considerare come un positivo esempio di collaborazione non
solo interdipartimentale ma anche interfacoltà, e quindi come una prima dimo-
strazione concreta della validità delle scelte organizzative che, con la ristruttura-
zione dipartimentale, il Politecnico di Torino ha fatto, in prima linea tra gli
Atenei italiani.
//


















