
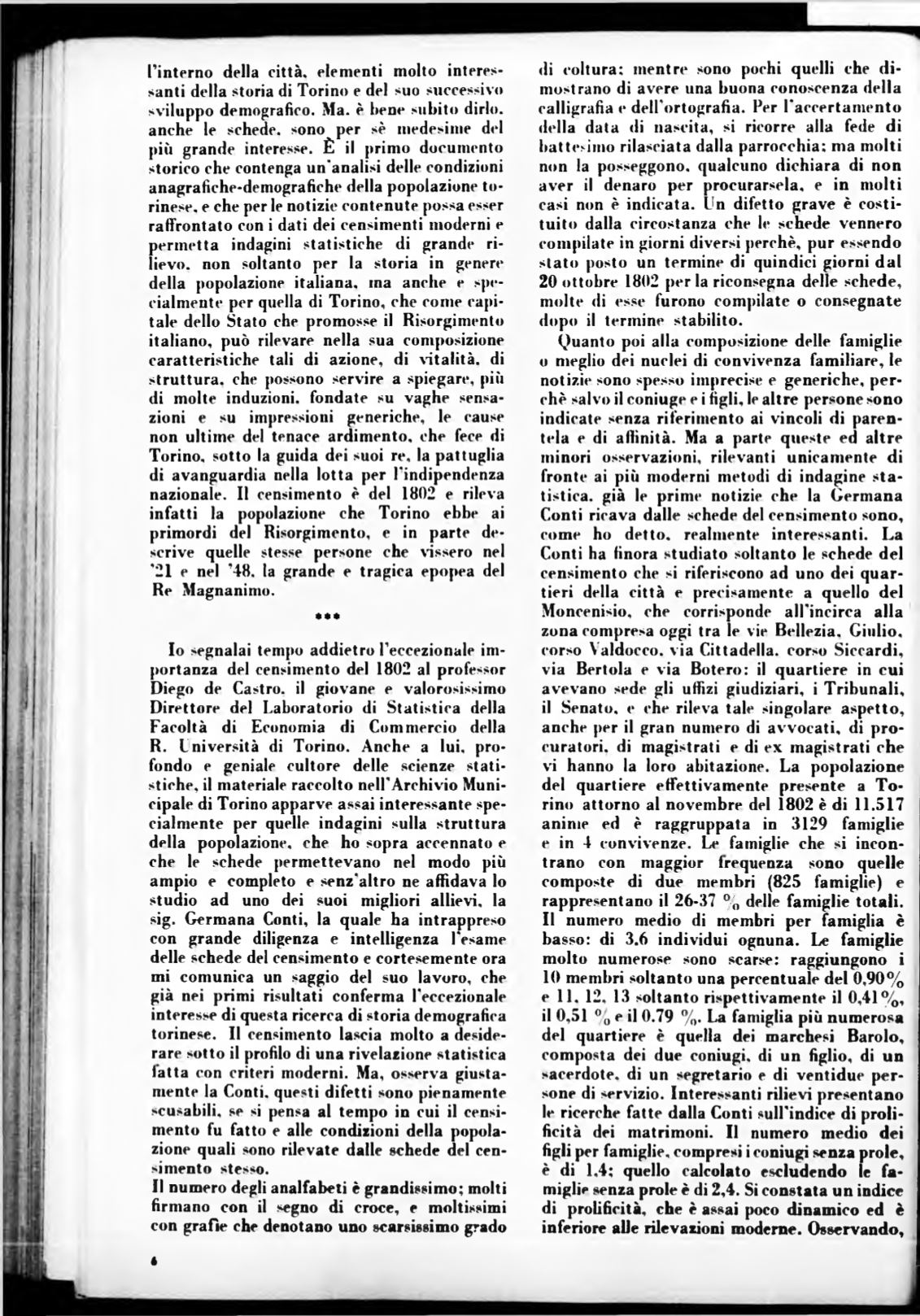
l’interno della città, elementi molto interes
santi della storia di Torino e del suo successivo
sviluppo demografico. Ma.
è
bene subito dirlo,
anche le schede, sono per sè medesime del
più grande interesse. È il primo documento
storico che contenga un'analisi delle condizioni
anagratìche-demografiche della popolazione to
rinese. e che per le notizie contenute possa esser
raffrontato con i dati dei censimenti moderni e
permetta indagini statistiche di grande ri
lievo, non soltanto per la storia in genere
della popolazione italiana, ina anche e spe
cialmente per quella di Torino, che come capi
tale dello Stato che promosse il Risorgimento
italiano, può rilevare nella sua composizione
caratteristiche tali di azione, di vitalità, di
struttura, che possono servire a spiegare, più
di molte induzioni, fondate su vaghe sensa
zioni e su impressioni generiche, le cause
non ultime del tenace ardimento, che fece di
Torino, sotto la guida dei suoi re, la pattuglia
di avanguardia nella lotta per l'indipendenza
nazionale. Il censimento è del 1802 e rileva
infatti la popolazione che Torino ebbe ai
primordi del Risorgimento, e in parte de
scrive quelle stesse persone che vissero nel
’21 e nel ’48. la grande e tragica epopea del
Re Magnanimo.
* * *
Io segnalai tempo addietro l’eccezionale im
portanza del censimento del 1802 al professor
Diego de Castro, il giovane e valorosissimo
Direttore del Laboratorio di Statistica della
Facoltà di Economia di Commercio della
R . Ln iversità di Torino. Anche a lui, pro
fondo e geniale cultore delle scienze stati
stiche, il materiale raccolto nell'Archivio Muni
cipale di Torino apparve assai interessante spe
cialmente per quelle indagini sulla struttura
della popolazione, che ho sopra accennato e
che le schede permettevano nel modo più
ampio e completo e senz'altro ne affidava lo
studio ad uno dei suoi migliori allievi, la
sig. Germana Conti, la quale ha intrappreso
con grande diligenza e intelligenza l'esame
delle schede del censimento e cortesemente ora
mi comunica un saggio del suo lavoro, che
già nei primi risultati conferma l'eccezionale
interesse di questa ricerca di storia demografica
torinese. Il censimento lascia molto a deside
rare sotto il profilo di una rivelazione statistica
latta con criteri moderni. Ma, osserva giusta
mente la Conti, questi difetti sono pienamente
scusabili, se si pensa al tempo in cui il censi
mento fu fatto e alle condizioni della popola
zione quali sono rilevate dalle schede del cen
simento stesso.
Il numero degli analfabeti è grandissimo; molti
firmano con il segno di croce, e moltissimi
con grafìe che denotano uno scarsissimo grado
di coltura; mentre sono pochi quelli che d i
mostrano di avere una buona conoscenza della
calligrafìa e deU'ortografìa. Per l'accertamento
della data di nascita, si ricorre alla fede di
battesimo rilasciata dalla parrocchia; ma molti
non la posseggono, qualcuno dichiara di non
aver il denaro per procurarsela, e in molti
casi non è indicata. Un difetto grave è costi
tuito dalla circostanza che le schede vennero
compilate in giorni diversi perchè, pur essendo
stato posto un termine di quindici giorni dal
20 ottobre 1802 perla riconsegna delle schede,
molte di esse furono compilate o consegnate
dopo il termine stabilito.
Quanto poi alla composizione delle famiglie
o meglio dei nuclei di convivenza familiare, le
notizie sono spesso imprecise e generiche, per
chè salvo il coniuge e i figli, le altre persone sono
indicate senza riferimento ai vincoli di paren
tela e di affinità. Ma a parte queste ed altre
minori osservazioni, rilevanti unicamente di
fronte ai più moderni metodi di indagine sta
tistica. già le prime notizie che la Germana
Conti ricava dalle schede del censimento sono,
come ho detto, realmente interessanti. L a
Conti ha finora studiato soltanto le schede del
censimento che si riferiscono ad uno dei quar
tieri della città e precisamente a quello del
Moncenisio, che corrisponde all'incirca alla
zona compresa oggi tra le vie Bellezia. Giulio,
corso Valdocco, via Cittadella, corso Siccardi,
via Bertola e via Botero: il quartiere in cui
avevano sede gli uffizi giudiziari, i T ribunali,
il Senato, e che rileva tale singolare aspetto,
anche per il gran numero di avvocati, di pro
curatori. di magistrati e di ex magistrati che
vi hanno la loro abitazione. L a popolazione
del quartiere effettivamente presente a T o
rino attorno al novembre del 1802 è di 11.517
anime ed è raggruppata in 3129 famiglie
e in 4 convivenze. Le famiglie che si incon
trano con maggior frequenza sono quelle
composte di due membri (825 famiglie) e
rappresentano il 26-37 % delle famiglie totali.
Il numero medio di membri per famiglia è
basso: di 3.6 individui ognuna. Le famiglie
molto numerose sono scarse: raggiungono i
10 membri soltanto una percentuale del 0 ,90%
e 11. 12, 13 soltanto rispettivamente il 0 ,41% ,
1 0,51 ° 0 e il 0.79 % . La famiglia più numerosa
del quartiere è quella dei marchesi Barolo,
composta dei due coniugi, di un figlio, di un
sacerdote, di un segretario e di ventidue per
sone di servizio. Interessanti rilievi presentano
le ricerche fatte dalla Conti sull'indice di proli
ficità dei matrimoni. Il numero medio dei
figli per famiglie, compresi i coniugi senza prole,
è di 1,4; quello calcolato escludendo le fa
miglie senza prole è di 2,4. Si constata
un indice
di prolificità, che è assai poco
dinamico ed
è
inferiore alle rilevazioni
moderne. Osservando,
*


















