
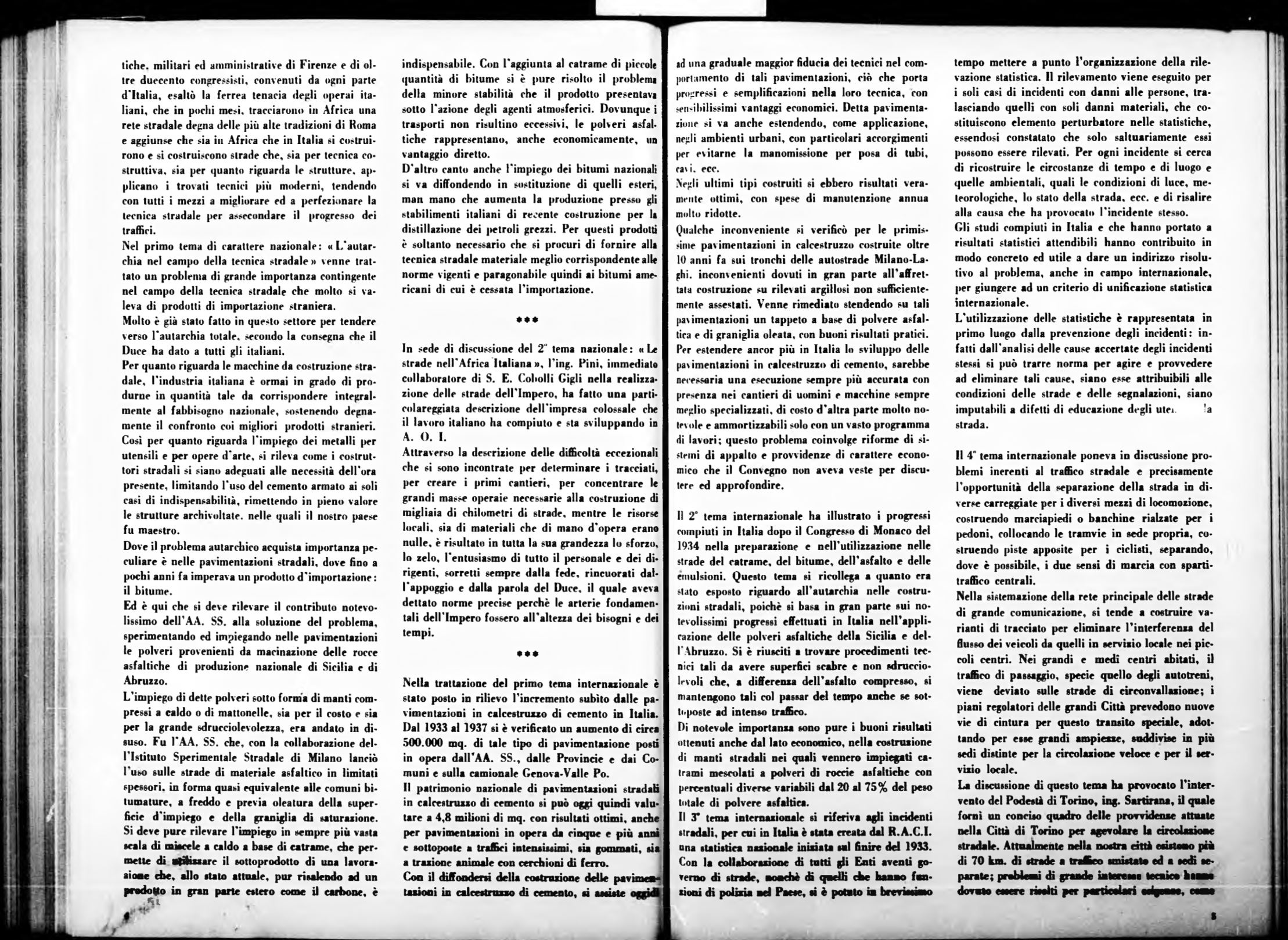
tiche. militari ed amministrative di Firenze e di ol
tre duecento congressisti, convenuti da ogni parte
d'Italia, esaltò la ferrea tenacia degli operai ita
liani, che in pochi mesi, tracciarono in Africa una
rete stradale degna delle più alte tradizioni di Roma
e aggiunse che sia in Africa che in Italia si costrui
rono e si costruiscono strade che, sia per tecnica co
struttiva, sia per quanto riguarda le strutture, ap
plicano i trovati tecnici più moderni, tendendo
con tutti i mezzi a migliorare ed a perfezionare la
tecnica stradale per assecondare il progresso dei
traffici.
Mei primo tema di carattere nazionale : « L'autar
chia nel campo della tecnica stradale » venne trat
tato un problema di grande importanza contingente
nel campo della tecnica stradale che molto si va
leva di prodotti di importazione straniera.
Molto è già stato fatto in questo settore per tendere
verso l'autarchia totale, secondo la consegna che il
Duce ha dato a tutti gli italiani.
Per quanto riguarda le macchine da costruzione stra
dale, l'industria italiana è ormai in grado di pro
durne in quantità tale da corrispondere integral
mente al fabbisogno nazionale, sostenendo degna
mente il confronto coi migliori prodotti stranieri.
Così per quanto riguarda l'impiego dei metalli per
utensili e per opere d'arte, si rileva come i costrut
tori stradali si siano adeguati alle necessità dell'ora
presente, limitando l'uso del cemento armato ai soli
casi di indispensabilità, rimettendo in pieno valore
le strutture archivoltate. nelle quali il nostro paese
fu maestro.
Dove il problema autarchico acquista importanza pe
culiare è nelle pavimentazioni stradali, dove fino a
pochi anni fa imperava un prodotto d'importazione:
il bitume.
Ed è qui che si deve rilevare il contributo notevo
lissimo dell'AA. SS. alia soluzione del problema,
sperimentando ed impiegando nelle pavimentazioni
le polveri provenienti da macinazione delle rocce
asfaltiche di produzione nazionale di Sicilia e di
Abruzzo.
L'impiego di dette polveri sotto forma di manti com
pressi a caldo o di mattonelle, sia per il costo e sia
per la grande sdrucciolevolezza, era andato in di
suso. Fu l'AA . SS. che, con la collaborazione del
l'istituto Sperimentale Stradale di Milano lanciò
1uso sulle strade di materiale asfaltico in limitati
spessori, in forma quasi equivalente alle comuni bi
tumature, a freddo e previa oleatura della super
ficie d'impiego e della graniglia di saturazione.
Si deve pure rilevare l'impiego in sempre più vasta
scala di miscele a caldo a base di catrame, die per*
inette di atitizxare il sottoprodotto di una lavora*
aione che, allo stato attuale, pur risalendo ad un
prodotto in gran parte estero come il carbone, è
S i
indispensabile. Con l'aggiunta al catrame di piccole
quantità di bitume si è pure risolto il problema
della minore stabilità che il prodotto presentava
sotto l'azione degli agenti atmosferici. Dovunque i
trasporti non risultino eccessivi, le polveri asfal
tiche rappresentano, anche economicamente, un
vantaggio diretto.
D'altro canto anche l'impiego dei bitumi nazionali
si va diffondendo in sostituzione di quelli esteri,
man mano che aumenta la produzione presso gli
stabilimenti italiani di recente costruzione per la
distillazione dei petroli grezzi. Per questi prodotti
è soltanto necessario che si procuri di fornire alla
tecnica stradale materiale meglio corrispondente alle
norme vigenti e paragonabile quindi ai bitumi ame
ricani di cui è cessata l'importazione.
* ♦ *
In sede di discussione del 2° tema nazionale: «L e
strade nell'Africa Italiana», l'ing. Pini, immediato
collaboratore di S. E. Coltoli» Gigli nella realizza
zione delle strade dell'impero, ha fatto una parti
colareggiata descrizione dell'impresa colossale che
il lavoro italiano ha compiuto e sta sviluppando in
A. 0 . I.
Attraverso la descrizione delle difficoltà eccezionali
che si sono incontrate per determinare i tracciati,
per creare i primi cantieri, per concentrare le
grandi masse operaie necessarie alla costruzione di
migliaia di chilometri di strade, mentre le risorse
locali, sia di materiali che di mano d'opera erano
nulle, è risultato in tutta la sua grandezza lo sforzo,
10 zelo, l'entusiasmo di tutto il personale e dei di*
rigenti, sorretti sempre dalla fede, rincuorati dal*
l'appoggio e dalla parola del Duce, il quale aveva
dettato norme precise perchè le arterie fondamen
tali dell'impero fossero all'altezza dei bisogni e dei
tempi.
• * *
Nella trattazione del primo tema internazionale è
stato posto in rilievo l'incremento subito dalle pa*
vimentazioni in calcestruzzo di cemento in Italia.
Dal 1933 al 1937 si è verificato un aumento di circa
500.000 mq. di tale tipo di pavimentazione posti
in opera dall'AA. SS., dalle Provincie e dai Co*
muni e sulla camionale Genova*Valle Po.
11 patrimonio nazionale di pavimentazioni stradali
in calcestruzzo di cemento si può oggi quindi valu*
tare a 4,8 milioni di mq. con risultati ottimi, anche
per pavimentazioni in opera da cinque e più anni
e sottoposte a traffici intensissimi, sia gommati, sia
a trazione animale con cerchioni di ferro.
Con il diffondersi della coatraaione delle pavimeo*
ad una graduale maggior fiducia dei tecnici nel com
portamento di tali pavimentazioni, ciò che porta
progressi e semplificazioni nella loro tecnica, con
sensibilissimi vantaggi economici. Detta pavimenta
zione si va anche estendendo, come applicazione,
ne^li ambienti urbani, con particolari accorgimenti
per evitarne la manomissione per posa di tubi,
cavi. ecc.
Ne^li ultimi tipi costruiti si ebbero risultati vera
mente ottimi, con spese di manutenzione annua
molto ridotte.
Qualche inconveniente si verificò per le primis
sime pavimentazioni in calcestruzzo costruite oltre
10 anni fa sui tronchi delle autostrade Milano-La-
ghi. inconvenienti dovuti in gran parte all'affret
tata costruzione su rilevati argillosi non sufficiente
mente assestati. Venne rimediato stendendo su tali
pa\imentazioni un tappeto a base di polvere asfal
tica e di graniglia oleata, con buoni risultati pratici.
Per estendere ancor più in Italia lo sviluppo delle
pavimentazioni in calcestruzzo di cemento, sarebbe
necessaria una esecuzione sempre più accurata con
presenza nei cantieri di uomini e macchine sempre
meglio specializzati, di costo d'altra parte molto no
tevole e ammortizzabili solo con un vasto programma
di lavori; questo problema coinvolge riforme di si
stemi di appalto e provvidenze di carattere econo
mico che il Convegno non aveva veste per discu
tere ed approfondire.
1 2° tema internazionale ha illustrato i progressi
compiuti in Italia dopo il Congresso di Monaco del
1934 nella preparazione e nell'utilizzazione nelle
strade del catrame, del bitume, deU'asfalto e delle
emulsioni. Questo tema si ricollega a quanto era
stato esposto riguardo all'autarchia nelle costru*
zioni stradali, poiché si basa in gran parte sui no
tevolissimi progressi effettuati in Italia nell'appli-
cazione delle polveri asfaltiche della Sicilia e del
l'Abruzzo. Si è riusciti a trovare procedimenti tec
nici tali da avere superfici scabre e non sdruccio*
levoli che, a differenza dell'asfalto compresso, si
mantengono tali col passar del tempo anche se sot
toposte ad intenso traffico.
Di notevole importanza sono pure i buoni risultati
ottenuti anche dal lato economico, nella costruzione
di manti stradali nei quali vennero impiegati ca
trami mescolati a polveri di roccie asfaltiche con
percentuali diverse variabili dal 20 al 75% del peso
totale di polvere asfaltica.
Il
3°
tema internazionale si riferiva agli incidenti
stradali, per cui in Italia è stata creata dal R .A.C .I.
una statistica nazionale iniziata sul finire del
1933.
Con la collaborazione di tatti gli End aventi go-
tempo mettere a punto l'organizzazione della rile
vazione statistica. Il rilevamento viene eseguito per
i soli casi di incidenti con danni alle persone, tra
lasciando quelli con soli danni materiali, che co
stituiscono elemento perturbatore nelle statistiche,
essendosi constatato che solo saltuariamente essi
possono essere rilevati. Per ogni incidente si cerca
di ricostruire le circostanze di tempo e di luogo e
quelle ambientali, quali le condizioni di luce, me
teorologiche, lo stato delia strada, ecc. e di risalire
alla causa che ha provocato l'incidente stesso.
Gli studi compiuti in Italia e che hanno portato a
risultati statistici attendibili hanno contribuito in
modo concreto ed utile a dare un indirizzo risolu
tivo al problema, anche in campo internazionale,
per giungere ad un criterio di unificazione statistica
internazionale.
L'utilizzazione delle statistiche è rappresentata in
primo luogo dalla prevenzione degli incidenti: in
fatti dall'analisi delle cause accertate degli incidenti
stessi si può trarre norma per agire e provvedere
ad eliminare tali cause, siano esse attribuibili alle
condizioni delle strade e delle segnalazioni, siano
imputabili a difetti di educazione degli utei.
la
strada.
Il 4° tema internazionale poneva in discussione pro
blemi inerenti al traffico stradale e precisamente
l'opportunità della separazione della strada in di
verse carreggiate per i diversi mezzi di locomozione,
costruendo marciapiedi o banchine rialzate per i
pedoni, collocando le tramvie in sede propria, co
struendo piste apposite per i ciclisti, separando,
dove è possibile, i due sensi di marcia con sparti-
traffico centrali.
Nella sistemazione della rete principale delle strade
di grande comunicazione, si tende a costruire va
rianti di tracciato per eliminare l'interferenza del
flusso dei veicoli da quelli in servizio locale nei pic
coli centri. Nei grandi e medi centri abitati, il
traffico di passaggio, specie quello degli autotreni,
viene deviato sulle strade di circonvallazione; i
piani regolatori delle grandi Città prevedono nuove
vie di cintura per questo transito speciale, adot
tando per esse grandi ampiezze, suddivise in più
sedi distinte per la circolazione veloce e per il ser
vizio locale.
La discussione di questo tema ha provocato l'inter
vento del Podestà di Torino, ing. Sartirana, il quale
fornì un conciso quadro delle provvidenze attuate
nella Città di Torino per agevolare la circolazione
stradale. Attualmente nella nostra città esistono più
di 70 km. di strade a traffico smistato ed a sedi se
parate; problemi di grande interesae tecnico ha— a
dovuto essere risolti per particolari esigerne, eoaae
t
tazioni in calcestruzzo di cemento, si assiste
verno di strade, nonché di quelli che hanno fun
zioni di polizia nel Paese, si è potato in brevissimo


















