
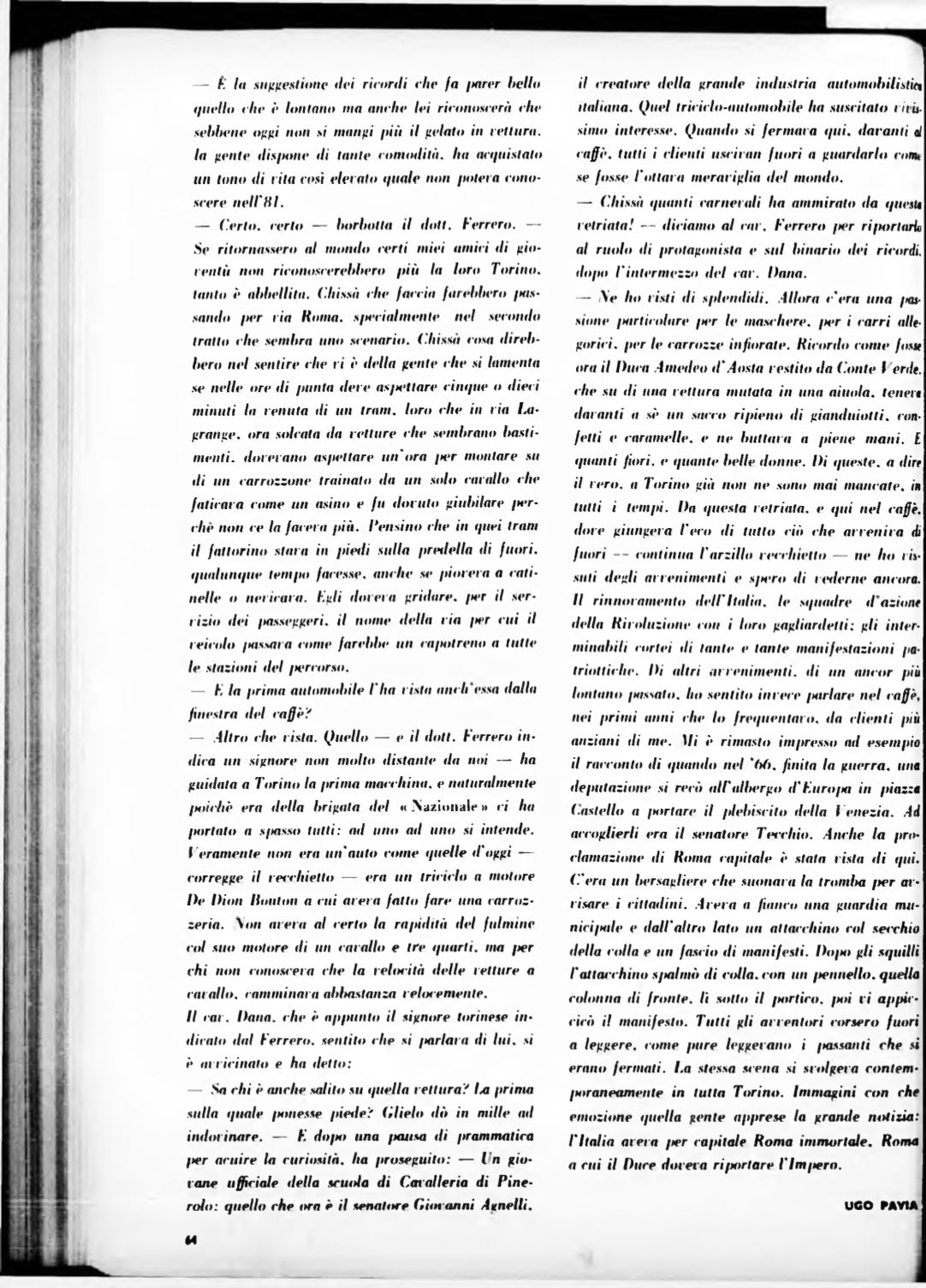
— F. la
s ii
gestione dei ricordi che fa parer bello
(indio che è lontano ma anche lei riconoscerà che
sebbene oppi non si manpi più il pelato in vettura,
la pente dispone di tante comodità, ha acquistato
un tono di vita così elevato quale non poteva cono
scere nell'HI.
— Certo, certit — borbotta il dott. Ferrerò. —
Se ritornassero al mondo certi miei amici di gio
ventù non riconoscerebbero più la litro Torino,
tanto è abbellita. Chissà che faccia farebbero /tas
sando per via Ritma, specialmente nel secondo
tratto che sembra uno scenario. Chissà cosa direb
bero nel sentire che vi è della pente che si lamenta
se nelle ore di punta deve asfaltare cinque o dieci
minuti la venuta di un tram, loro che in via La-
pranpe. ora solcala ila vetture che sembrano basti
menti. dovevano aspettare un'ora \ter montare su
ili un carrozzone trainato da un solo cavallo che
faticava come un asino e fu dovuto piubilare for
che non ce la faceva più. Pensino che in quei tram
il fattorino stava in piedi sulla pretlella di fuori,
qualunque tempo facesse, anche se pioveva a cati
nelle o nevicava. Fpli doveva prillare, /ter il ser
vizio dei itassepperi. il nome della via /
ut
cui il
veicolo passava come farebbe un capotreno a tutte
le stazioni del /tercorso.
— F la prima automobile l’Iia vista aneli essa dalla
finestra del caffè?
— Altro che vista. Quellit — e il dott. Ferrerò in
dica un sipnore non molto distante ila noi — ha
puidata a Torino la prima marchimi, e naturalmente
Itoirhè era della bripata ilei « Nazionale » ri ha
portato a s/tasso tutti: ad uno ad uno si intende.
Veramente non era un'auto come quelle d'oppi —
rorreppe il vecchietto — era un trincio a motore
De Dion Itolituli a cui aveva fatto fare una carroz
zeria. !\on aveva al certo la rapidità del fulmine
col suo motore di un cavallo e tre ipiarti. ma /ter
chi non conosceva che la velocità delle vetture a
cavallo, camminava abbastanza velocemente.
Il rav. Dana, che è appunto il sipnore torinese in-
dicato dal Ferrerò, sentito che si /tarlava di lui. si
è avvicinato e ha detto:
— Sa chi è miche salito su quella vettura? !
m
prima
sulla quale /
h
inesse piede? Glielo dò in mille ad
indovinare. — F (lofio una /tansa di prammatica
/ter acuire la curiosità, ha prosepuito: — I n pio
vane ufficiale della srtutla di Cavalleria di Pine-
rolo: quello che ora è il senatore Giovanni Alineili.
il creatore della pramle industria automobilistitt
italiana. Quel triciclo-automobile ha suscitato vil is
simo interesse. Quando si fermava ipii. davanti al
caffè, tutti i clienti usrivan fuori a puardarlo rim
se fosse ruttava meraviplia ilei mondo.
— Chissà quanti carnevali ha ammiralo da questi
vetriata! — diciamo al cav. Ferrerò fter riportarla
al ruolo ili protaponista e sul binario dei ricordi,
dopo l'intermezzo del cav. Dana.
— I\e ho visti di splendidi. Allora c'era una /tas
siane iMirtimlare /ter le maschere, fter i carri alle-
parici, per le carrozze infiorate. Ricordo come fosst
ora il Duca Amedeo d'Aosta vestito da ('.onte t enie,
che su di una vettura mutata in una aiuola, tenera
davanti a sè un sacro ripieno ili pianiluiotti. con
fetti e caramelle, e ne buttava a piene mani. E
quanti fiori, e quante belle donne. Di queste, a dire
il vero, a Torino più non ne sono mai mancate, in
tutti i tempi. Da questa vetriata, e qui nel caffè,
dove piunpeva l'eco ili tutto ciò che avveniva di
fuori — continua l'arzillo verrliietto — ne ho vis
suti depli avvenimenti e s/tero ili interne aurora.
Il rinnovamento dell'Italia, le squadre dazione
della Rivoluzione ron i loro papliariletti: pii inter
minabili cortei ili tante e tante manifestazioni pa-
triottirlie. Di altri avvenimenti, di un anror più
lontano /tassato. lui sentito invere /tarlare nel raffè,
nei primi anni che lo frequentavo, da clienti più
anziani di me. Mi è rimasto impresso ad esempio
il racconto ili quando nel '66. finita la puerra. una
deputazione si recò all'allterpo d'F.uro/ia in piazza
(.astello a portare il plebiscito della Venezia. Ad
arroplierli era il senatore Terrhio. Anrhe la prò-
rlamazione di Roma rapitale è stata vista di qui.
('.'era un bersagliere rhe suonava la tromba /ter av
visare i ritladini. Aveva a fianco una puardia mu-
nici/iale e dall'altro lato un attacchino col secchio
della colla e un fascio di manifesti. Do/to pii squilli
l'attacchino s/talmò di colla, con un /tennello. quella
colonna di fronte, lì sotto il /tortini, [n i vi appic
cicò il manifesto. Tutti pii avventori corsero fuori
a leppere, come pure leppevano i /tassanti che si
erano fermati. La stessa scena si svolgeva contem•
fHtraneamenle in tutta Torino. Immagini con che
emozione quella pente apprese la praiule notizia:
l'Italia aveva /ter capitale Roma immortale. Roma
a cui il Dure doveva ri/tartare l'im/tero.
UGO PAVIA
«4


















