
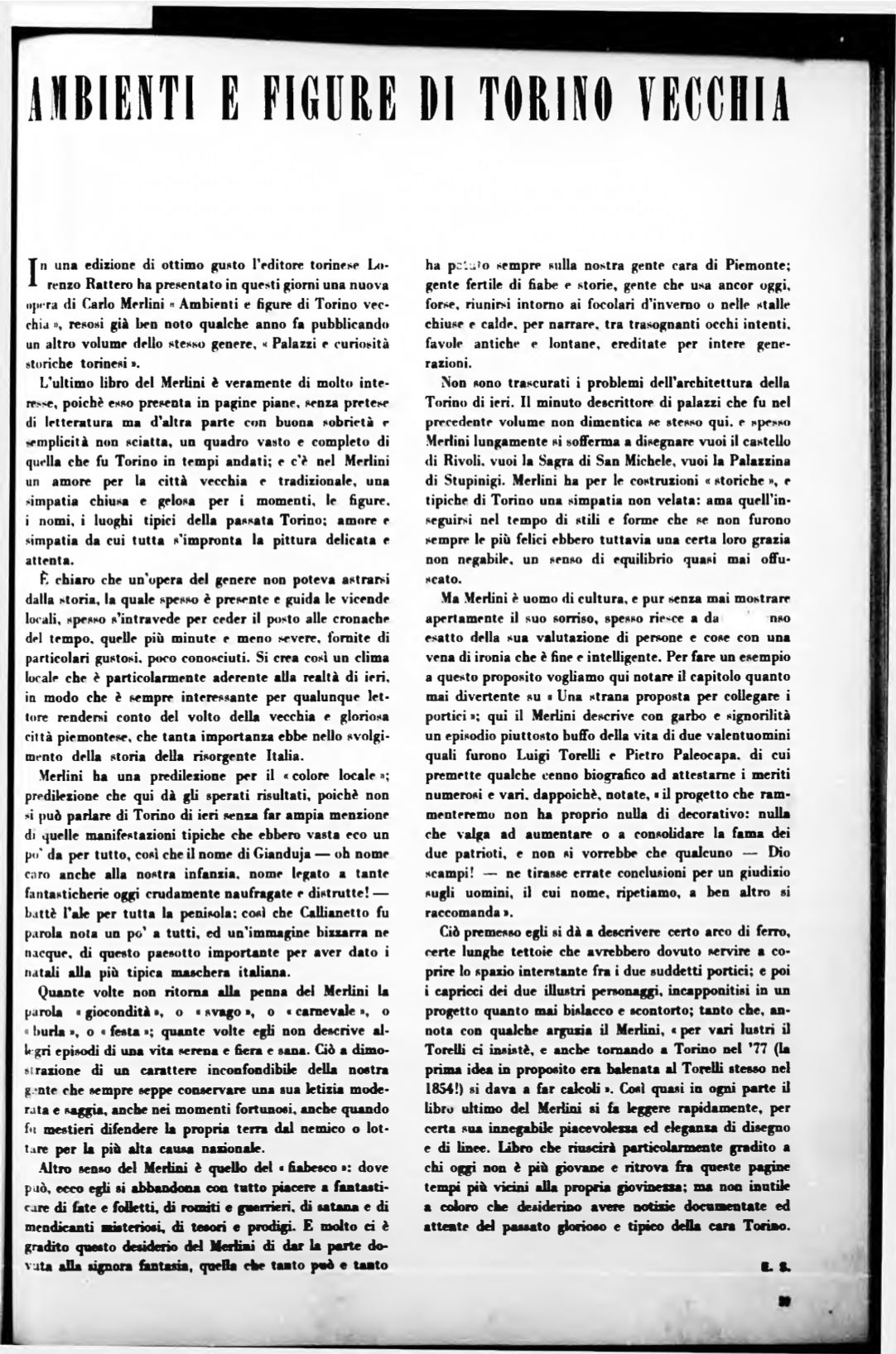
ilBIENTI E FIGURE »l TORIIO VECCHIA
I
n una edizione di ottimo gusto l’editore torinese Lo
renzo Rattero ha presentato in questi giorni una nuova
o|MTa di Carlo Merlini « Am bienti e figure di Torino vec
chia », resosi già ben noto qualche anno fa pubblicando
un altro volume dello stesso genere, « Palazzi e curiosità
storiche torinesi ».
L’ultim o libro del M erlini è veramente di molto inte
resse, poiché esso presenta in pagine piane, senza pretese
di letteratura ma d’altra parte con buona sobrietà e
••empiicità non sciatta, un quadro vasto e completo di
quella che fu Torino in tempi andati; e
c'è
nel M erlini
un amore per la città vecchia e tradizionale, una
simpatia chiusa e gelosa per i momenti, le figure,
i nomi, i luoghi tipici della passata Torino; amore e
simpatia da cui tutta s’impronta la pittura delicata e
attenta.
fi chiaro che un’opera del genere non poteva astrarsi
dalla storia, la quale spesso è presente e guida le vicende
locali, spesso s’intravede per ceder il posto alle cronache
del tempo, quelle più m inute e meno severe, fornite di
particolari gustosi, poco conosciuti. Si crea così un clim a
(orale che è particolarmente aderente alla realtà di ieri,
in modo che è sempre interessante per qualunque let
tore rendersi conto del volto della vecchia e gloriosa
città piemontese, che tanta importanza ebbe nello svolgi
mento della storia della risorgente Italia.
Merlini ha una predilezione per il « colore locale »;
predilezione che qui dà gli sperati risultati, poiché non
si può parlare di Torino di ieri senza far ampia menzione
di quelle manifestazioni tipiche che ebbero vasta eco un
po’ da per tutto, così che il nome di Gianduja — oh nome
caro anche alla nostra infanzia, nome legato a tante
fantasticherie oggi crudamente naufragate e distrutte! —
battè l’ale per tutta la penisola: così che Callianetto fu
parola nota un po’ a tu tti, ed un'immagine bizzarra ne
nacque, di questo paesotto importante per aver dato i
natali alla più tipica maschera italiana.
Quante volte non ritorna alla penna del M erlini la
parola « giocondità », o « svago », o « carnevale », o
« burla », o « festa »; quante volte egli non descrìve al
legri episodi di una vita serena e fiera e sana. Ciò a dimo
strazione di un carattere inconfondibile della nostra
g*nte che sempre seppe conservare una sua letizia mode
rata e saggia, anche nei momenti fortunosi, anche quando
fu mestieri difendere la propria terra dal nemico o lot
tare per la più alta causa nazionale.
Altro senso del Meriini è quello del ■fiabesco »: dove
può,
ecco egli si abbandona con tatto piacere a fantasti
care di fate e folletti, di romiti e guerrieri, di satana e di
mendicanti misteriosi, di tesori e prodigi. E molto ci è
gradito questo desiderio del Meriini di dar la parte do
vuta alla signora fantasia, quella che tanto p#ò e tanto
ha p e lilo sempre sulla nostra gente cara di Piem onte;
gente fertile di fiabe e storie, gente che usa ancor oggi,
forse, riunirsi intorno ai focolari d’inverno o nelle stalle
chiuse e calde, per narrare, tra trasognanti occhi intenti,
favole antiche e lontane, ereditate per intere gene
razioni.
Non sono trascurati i problemi dell’architettura della
Torino di ieri. Il minuto descrittore di palazzi che fu nel
precedente volume non dimentica se stesso qui. e spesso
Merlini lungamente si sofferma a disegnare vuoi il castello
di R ivo li, vuoi la Sagra di San Michele, vuoi la Palazzina
di Stupinigi. M erlini ha per le costruzioni « storiche », e
tipiche di Torino una simpatia non velata: ama quell’in-
seguirsi nel tempo di stili e forme che se non furono
sempre le più felici ebbero tuttavia una certa loro grazia
non negabile, un senso di equilibrio quasi mai offu
scato.
Ma M erlini è uomo di cultura, e pur senza mai mostrare
apertamente il suo sorriso, spesso riesce a da
nso
esatto della sua valutazione di persone e cose con una
vena di ironia che è fine e intelligente. Per fare un esempio
a questo proposito vogUamo qui notare il capitolo quanto
mai divertente su « Una strana proposta per collegare i
portici »; qui il M erlini descrive con garbo e signorilità
un episodio piuttosto buffo della vita di due valentuom ini
quali furono Luigi Torelli e Pietro Paleocapa. di cui
premette qualche cenno biografico ad attestarne i m eriti
numerosi e vari, dappoiché, notate, « il progetto che ram-
menteremo non ha proprio nulla di decorativo: nulla
che valga ad aumentare o a consolidare la fama dei
due patrioti, e non si vorrebbe che qualcuno — Dio
scampi! — ne tirasse errate conclusioni per un giudizio
sugli uom ini, il cui nome, ripetiamo, a ben altro si
raccomanda ».
Ciò premesso egli si dà a descrìvere certo arco di ferro,
certe lunghe tettoie che avrebbero dovuto servire a co
prire Io spazio intentante fra i due suddetti portici; e poi
i caprìcci dei due illustri personaggi, incapponitisi in un
progetto quanto mai bislacco e scontorto; tanto che, an
nota con qualche arguzia il Meriini, «per vari lustri il
Torelli ci insistè, e anche tornando a Torino nel *77 (la
prima idea in proposito era balenata al Torelli stesso nel
1854!) si dava a far calcoli ». Così quasi in ogni parte il
libro ultimo del Merlini si fa leggere rapidamente, per
certa sua innegabile piacevolezza ed eleganza di disegno
e di linee. Libro che riuscirà particolarmente gradito a
chi oggi non è più giovane e ritrova fra queste pagine
tempi più vicini alla propria giovinezza; ma non inutile
a coloro che desiderino avere notizie documentate ed
attente dei passato glorioso e tipico della cara Torino.
K. S.


















