
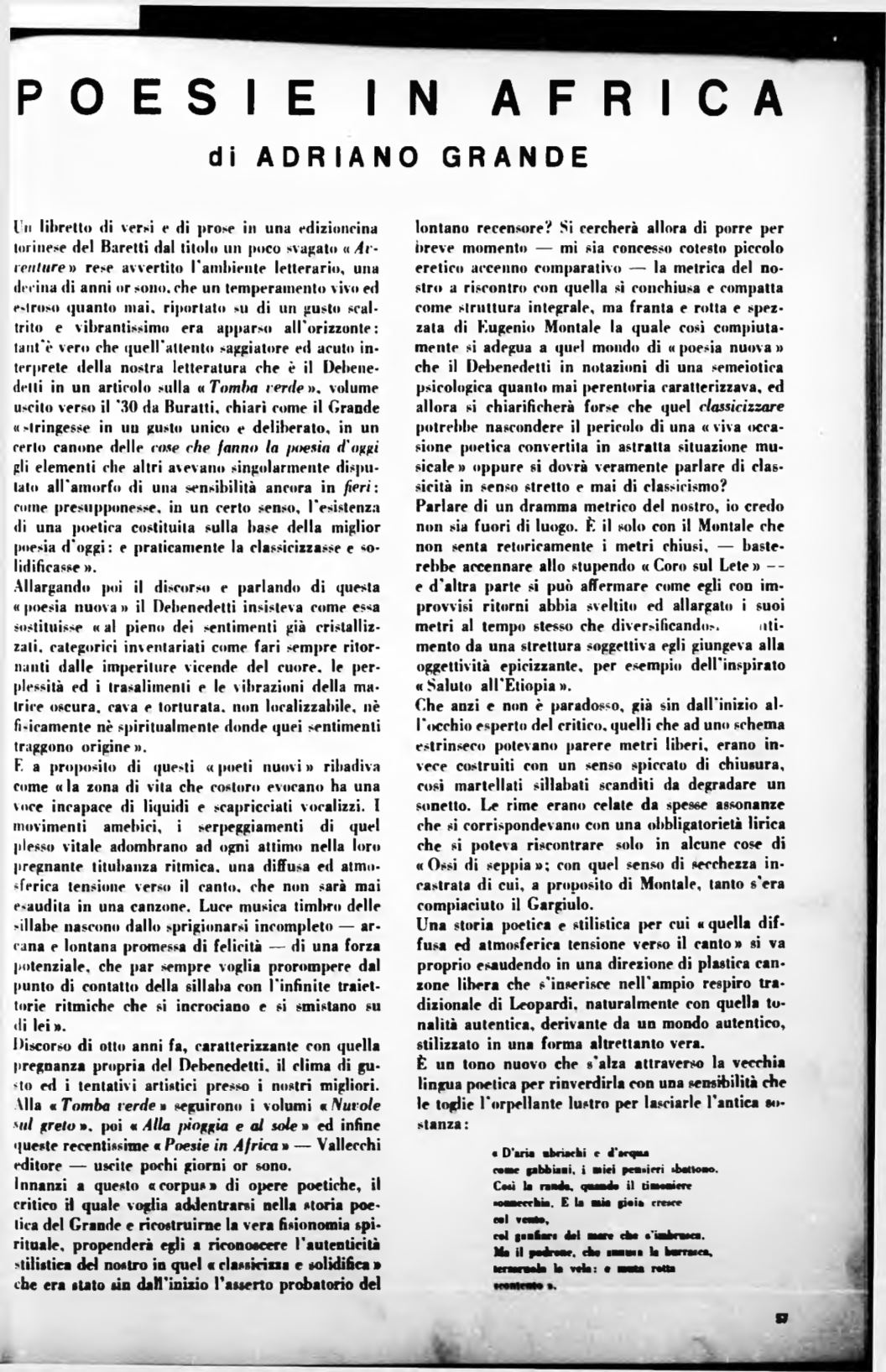
P O E S I E I N A F R I C A
di ADRIANO GRANDE
Un libretto di versi e di prose in una cdizioncina
torinese del Baretti dal titolo un poco svagato «Av
venture» rese avvertito l'ambiente letterario, una
decina di anni or sono, che un temperamento vivo ed
*■> Iroso quanto mai. riportato >u di un gusto scal
trito e vibrantissimo era apparso all'orizzonte:
tant'è vero che ijueH'attento saggiatore ed acuto in
terprete della nostra letteratura che è il Debene-
detti in un articolo sulla « Tomba verde», volume
uscito verso il '30 da Buratti, chiarì come il Grande
«stringesse in uu gusto unico e deliberato, in un
certo canone delle rose che fanno la /toesin d'ofifii
pii elementi che altri avevano singolarmente dispu
tato all'amorfo di una sensibilità ancora in fieri:
come presupponesse, in un certo senso, l'esistenza
di una poetica costituita sulla base della miglior
poesia d'oggi : e praticamente la classicizzasse e so
lidificasse ».
Allargando poi il discorso e parlando di questa
« poesia nuova » il Debenedetti insisteva come essa
sostituisse « al pieno dei sentimenti già cristalliz
zati, categorici inventariati come fari sempre ritor
nanti dalle imperiture vicende del cuore, le per
plessità ed i trasalimenti e le vibrazioni della ma
trice oscura, cava e torturata, non localizzabile, nè
fisicamente nè spiritualmente donde quei sentimenti
traggono origine ».
E a proposito di questi « poeti nuovi » ribadiva
come « la zona di vita che costoro evocano ha una
voce incapace di liquidi e scapricciati vocalizzi. I
movimenti amebici, i serpeggiamenti di quel
plesso vitale adombrano ad ogni attimo nella loro
pregnante titubanza ritmica, una diffusa ed atmo
sferica tensione verso il canto, che non sarà mai
e.audita in una canzone. Luce musica timbro delle
sillabe nascono dallo sprigionarsi incompleto — ar
cana e lontana promessa di felicità — di una forza
potenziale, che par sempre voglia prorompere dal
punto di contatto della sillaba con l'infìnite traiet
torie ritmiche che si incrociano e si smistano su
di lei ».
Discorso di otto anni fa, caratterizzante con quella
pregnanza propria del Debenedetti, il clima di gu-
sto ed i tentativi artistici presso i nostri migliori.
Alla a Tomba verde » seguirono i volumi a Nuvole
sul greto ». poi « Alla pioggia e al sole » ed infine
queste recentissime « Poesie in Africa » — Vallecchi
editore — uscite pochi giorni or sono.
Innanzi a questo «corpus» di opere poetiche, il
critico il quale voglia addentrarsi nella storia poe
tica del Grande e ricostruirne la vera fisionomia spi*
rituale, propenderà egli a riconoscere l'autenticità
stilistica del nostro in quel « classicizza c solidifica »
che era stato sin dall'inizio l'asserto probatorio del
lontano recensore? Si cercherà allora di porre per
breve momento — mi sia concesso cotesto piccolo
eretico accenno comparativo — la metrica del no
stro a riscontro con quella sì conchiusa e compatta
come struttura integrale, ma franta e rotta e spez
zata di Eugenio Montale la quale così compiuta-
mente si adegua a quel mondo di « poesia nuova »
che il Debenedetti in notazioni di una semeiotica
psicologica quanto mai perentoria caratterizzava, ed
allora si chiarificherà forse che quel classicizzare
potrebbe nascondere il pericolo di una « viva occa
sione poetica convertita in astratta situazione mu
sicale » oppure si dovrà veramente parlare di clas
sicità in senso stretto e mai di classicismo?
Parlare di un dramma metrico del nostro, io credo
non sia fuori di luogo. È il solo con il Montale che
non senta retoricamente i metri chiusi, — baste
rebbe accennare allo stupendo «Coro sul Lete» --
e d'altra parte si può affermare come egli con im
provvisi ritorni abbia sveltito ed allargato i suoi
metri al tempo stesso che diversificandos.
uti-
mento da una strettura soggettiva egli giungeva alla
oggettività epicizzante, per esempio dell'inspirato
« Saluto all'Etiopia ».
Che auzi e non è paradosso, già sin dall'inizio al
l'occhio esperto del critico, quelli che ad uno schema
estrinseco potevano parere metri liberi, erano in
vece costruiti con un senso spiccato di chiusura,
cosi martellati sillabati scanditi da degradare un
sonetto. Le rime erano celate da spesse assonanze
che si corrispondevano con una obbligatorietà lirica
che si poteva riscontrare solo in alcune cose di
«Ossi di seppia»; con quel senso di secchezza in
castrata di cui, a proposito di Montale, tanto s'era
compiaciuto il Gargiulo.
Una storia poetica e stilistica per cui « quella dif
fusa ed atmosferica tensione verso il canto» si va
proprio esaudendo in una direzione di plastica can-
zone libera che s'inserisce nell'ampio respiro tra
dizionale di Leopardi, naturalmente con quella to
nalità autentica, derivante da un mondo autentico,
stilizzato in una forma altrettanto vera.
È un tono nuovo che s'alza attraverso la vecchia
lingua poetica per rinverdirla con una sensibilità che
le toglie l'orpellante lustro per lasciarle l'antica so
stanza :
• D'aria abriachi e d'arqaa
rame gabbiani, i miri pentirci •battono.
Coti la randa, quando il timoniere
«oonerrhia. E la mia gioia crexe
col vento,
col ganiarr del mare che t'inbm ci.
Ma il padnae, dm a—ma la U n n o ,
tenaraoln la vela: • M ia rotta
V


















