
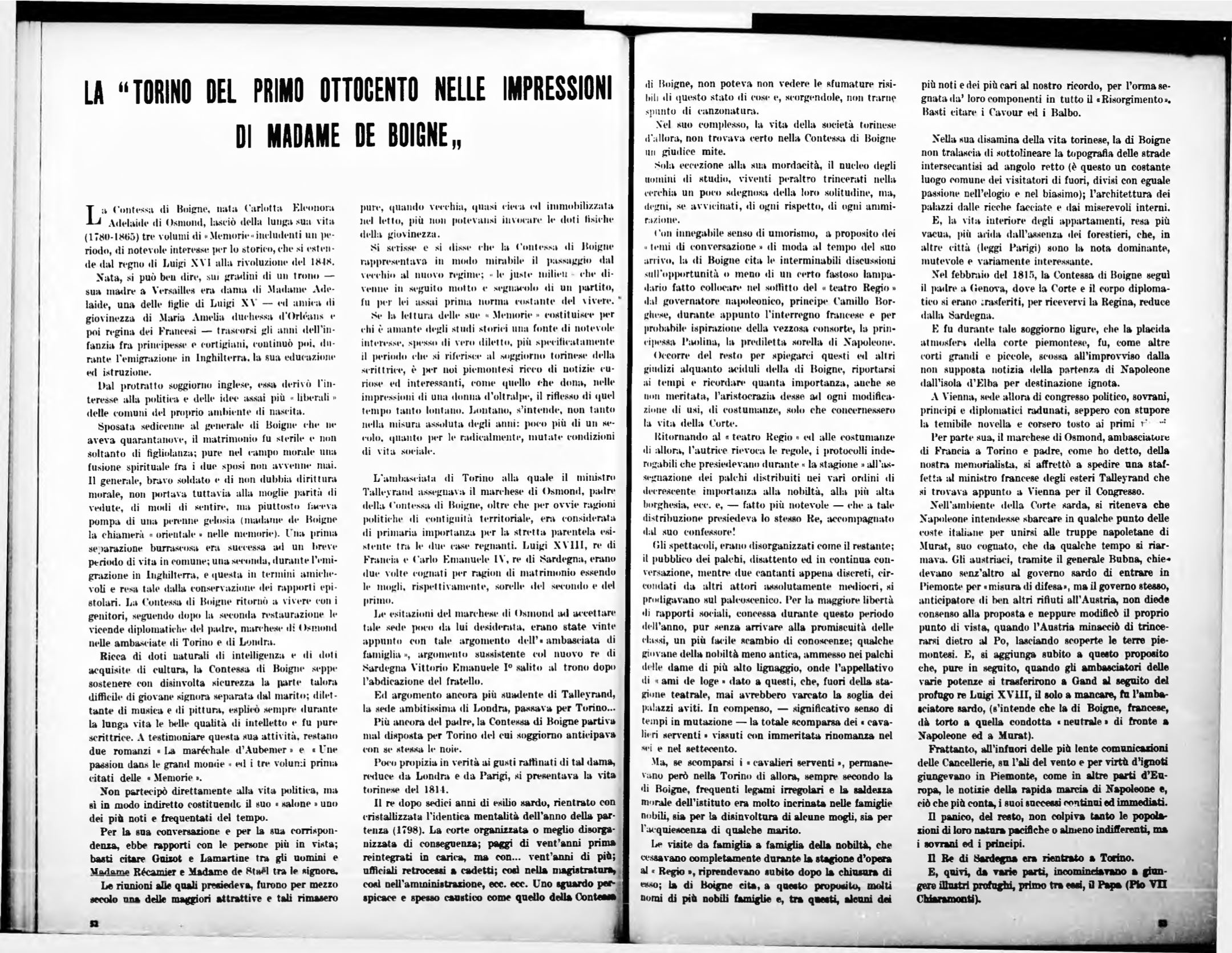
ut “ TORINO DEL PRIMO OTTOCENTO NELLE IMPRESSIONI
DI MADAME DE BOIGNE „
L
a Contessa di Boigne, nata Carlotta Eleonora
Adelaide di Osmond, lasciò della lunga sua vita
(
1780
-
1865
) tre volumi di «Memorie••includenti un pe
riodo, di notevole interesse per lo storico, che si esten
de dal regno «li Luigi X V I alla rivoluzione del
1848
.
Nata, si può ben dire, sui gradini di un trono —
sua madre a Versailles era dama «li Madame Ade
laide, una delle tiglio di Luigi X\ — od amica di
giovinezza di Maria Amelia duchessa d'Orleans e
poi regina dei Francesi — trascorsi gli anni dell in
fanzia fra principesse e cortigiani, continuò poi, du
rante remigrazione in Inghilterra, la sua educazione
ed istruzione.
Dal protratto soggiorno inglese, essa derivò l’in
teresse alla politica e delle idee assai più « liberali •
delle comuni del proprio ambiente di nascita.
Sposata sedicenne al generale «li Boigne ohe ne
aveva quarantanove, il matrimonio fu st«*rile «* non
soltanto «li figliolanza; pure nel campo morale una
fusione spirituale fra i due sposi non avvenne mai.
Il generai»*, bravo sohlato «* «li non dubbia dirittura
morale, non portava tuttavia alla moglie parità di
vedute, di modi di sentire, ma piuttosto fjkceva
pompa di una perenne gelosia (madame «le Boigne
la chiamerà
«
orientale
»
nelle memorie). I na prima
separazione burrascosa era successa a«l un breve
perio«lo di vita in comune; una seconda, durante l’emi
grazione in Inghilterra, e «[Uesta in termini amiche
voli e resa tale «ialla conservazione «lei rapporti epi
stolari. La Contessa «li Boigne ritornò a vivere con i
genitori, seguendo dopo la seconda restaurazione 1«*
vicende diplomatiche del padre, marchese «li Osmond
nelle ambasciate di Torino e di Londra.
Ricca di doti naturali «li intelligenza e di «l«»ti
acquisite di cultura, la Contessa di Boigne seppe
sostenere con disinvolta sicurezza la parte talora
difficile di giovane signora separata «lai marito; «filet
tante di musica e «li pittura, espino sempre «lurante
la lunga vita le belle qualità «li intelletto e fu pure
scrittrice. A testimoniare questa sua attività, restano
due romanzi « I*» maréchale d ’Aubemer » e « Une
passiou dans le grami momie • e«l i tre volumi prima
citati delle « Memorie ».
Non partecipò direttamente alla vita politica, ma
sì in modo indiretto costituemlc il suo * salone » uno
dei più noti e frequentati del tempo.
Per la sua conversazione e per la sua corrispon
denza, ebbe rapporti con le persone più in vista;
basti citare Gnizot e Lamartine tra gli uomini e
M d a n w Récamier e Madame de Stael tra le signore.
Le riunioni alle quali presiedeva, furono per mezzo
secolo una delle maggiori attrattive e tali rimasero
pure, «juando vecchia, quasi cieca «*«l immobilizzata
nel letto, più non potevansi invocare le «loti tìsiche
«l«*lla giovinezza.
Si scrisse e si «fisse «die la Contessa «li Boigne
rappresentava in modo mirabile il passaggio dal
vecchio al nuovo regime; « !«• justo milieu • che «li
vellile in seguito motto c segnacolo di un partito,
fu per lei assai prima norma costante del vivere. 1
Se la lettura d«*lle sue ><Memorie • costituisce per
chi è amante degli studi st«*ri« i una fonte «li notevole
interesse, spesso di vero «filetto, più specificatamente
il periodo clic si riferisce al soggiorno torinese della
scrittrice, è por noi piemontesi ricco di u«*tizie cu
riose ed interessanti, come «niello che dona, nelle
impressioni «fi una donna «l’oltralpe, il riflesso di quel
tempo tanto lontano. Lontano, s’intende, non tanto
nella misura assoluta «legli anni: poco più «li un se
tolo. «|iianto per le ra«licalmente, mutate condizioni
di vita sociale.
L'ambasciata di Torino alla quale il ministro
Talleyraml assegnava il marchese «li Osmond, padre
della Contessa «li Boigne, oltre che per ovvie ragioni
politiche «li contiguità territoriale, era considerata
di primaria importanza per la stretta parentela esi
stente tra le dm* case regnanti. Luigi X V
11
I, re «fi
Francia e Carlo Kmanuele IV, re «li Sardegna, erano
«lue volte cognati p«*r ragion «li matrimonio essendo
le mogli, rispettivamente, sorelle «U*l secondo e «lei
primo.
Le esitazioni del marchese di Osmond ad accettare
tale sede poco «la lui desiderata, erano state vinte
appunto con tale argomento «lell’ « ambasciata di
famiglia », argomento sussistente c«d nuovo re di
Sardegna Vittorio Kmanuele
1
° salito al tromi dopo
l’abdicazione del fratello.
Ed argomento ancora più suadente di Talleyrand,
la sede ambitissima «li Londra, passava per Torino...
P iù ancora del pa«lre, la Contessa di Boigne partiva
mal «fisposta per Torino «lei cui soggiorno anticipava
con se stessa le noie.
Poco propizia in verità ai gusti raffinati di tal «lama,
re«Iuce da Lomlra e da Parigi, si presentava la vita
torinese del
1814
.
11 re dopo sedici anni di esilio sardo, rientrato con
cristallizzata l'identica mentalità dell’anno della par
tenza (
1798
). La corte organizzata o meglio disorga
nizzata di conseguenza; paggi di vent’anni prima
reintegrati in carica, ma con... vent’anni dì più;
ufficiali retrocessi a cadetti; così nella magistratura,
così neH'amminÌ8trazione, ecc. ecc. Uno sguardo per
spicace e spesso caustico come quello della Contea**
» I
di Boigne, non poteva non vedere le sfumature risi
bili «li questo stato «li cose e, scorgendole, non trarne
spunto di canzonatura.
Nel suo complesso, la vita «Iella s«>cietà torinese
d'allora, non trovava certo nella Contessa di Boigne
un giudice mite.
Sola eccezione alla sua mordacità, il nucleo «legli
uomini di studio, viventi p«*raltro trincerati nella
cerchia un poco sdegnosa della loro solitudine, ma,
degni, se avvicinati, «li ogni rispetto, di «tgni amm i
razione.
Con innegabile senso di umorismo, a proposito dei
« temi «fi conversazione • «li moda al tempo del suo
arrivo, la di Boigne cita le interminabili discussioni
sull'opportunità o meno «li un certo fastoso lampa-
«lario fatto collocare nel soffitto del « teatro Regio »
•lai governatore napoleonico, principi* Camillo Bor-
ghese, durante appunto l'interregno francese e per
probabile ispirazione della vezzosa consorte, la prin-
«•ipessa Paolina, la prediletta sorella «li Napoleone.
Occorre del resto per spiegarci questi e«l altri
giudizi alquanto aciduli della di Boigne, riportarsi
ai tempi e ricordare quanta importanza, anche se
non meritata, l’aristocrazia desse a«l ogni modifica-
zinne «li usi, «li costumanze, solo che concernessero
la vita «Iella Corte.
Ritornando al « teatro Regio *>e«l alle costumanze
«li allora, l’autrice rievoca le regole, i protocolli inde-
rogabili che presiedevano durante « la stagione »•all’as
segnazione «lei palchi distribuiti nei vari ordini di
decrescente importanza alla nobiltà, alla più alta
borghesia, ecc. e, — fatto più notevole — che a tale
distribuzione presiedeva lo stesso Re, accompagnato
«lai suo confessore!
(Ili spettacoli, erano disorganizzati come il restante;
il pubblico dei palchi, disattento ed in continua con
versazione, mentre «lue cantanti appena discreti, cir-
condati da altri attori assolutamente mediocri, si
prodigavano sul palcoscenico. Per la maggiore libertà
«li rapporti sociali, concessa durante questo periodo
«lell’anno, pur senza arrivare alla promiscuità delle
classi, un più facile scambio «li conoscenze; qualche
giovane della nobiltà meno antica, ammesso nei palchi
«It ile dame di più alto lignaggio, onde l’appellativo
di <ami «le loge » dato a questi, che, fuori della sta
gione teatrale, mai avrebbero varcato la soglia dei
palazzi aviti. In compenso, — significativo senso di
tempi in mutazione — la totale scomparsa dei « cava
li* ri serventi » vissuti con immeritata rinomanza nel
sei e nel settecento.
Ma, se scomparsi i « cavalieri serventi », permane
vano però nella Torino di allora, sempre secondo la
•li Boigne, frequenti legami irregolari e la saldezza
morale dell’istituto era molto incrinata nelle famiglie
nobili, sia per la disinvoltura di alcune mogli, sia per
l'acquiescenza di qualche marito.
Ije visite da famiglia a famiglia della nobiltà, che
cessavano completamente durante la stagione d’opera
al x Regio », riprendevano subito dopo la chiusura di
**so; la di boigne cita, a questo proposito, molti
nomi di più nobili famiglie e, tra
questi, alcuni d à
più noti e dei più cari al nostro ricordo, per l’orma se
gnata da’ loro componenti in tutto il «Risorgimento».
Basti citare i Cavour ed i Balbo.
Nella sua disamina della vita torinese, la di Boigne
non tralascia «li sottolineare la topografia delle strade
intersecantisi ad angolo retto (è questo un costante
luogo comune dei visitatori di fuori, divisi con eguale
passione nell’elogio e nel biasimo); l’architettura dei
palazzi dalle ricche facciate e dai miserevoli interni.
E, la vita interiore degli appartamenti, resa più
vacua, più arida dall’assenza «lei forestieri, che, in
altre città (leggi Parigi) sono la nota dominante,
mutevole e variamente interessante.
Nel febbraio del
1815
, la Contessa «li Boigne seguì
il padre a Genova, dove la Corte e il corpo diploma
tico si erano trasferiti, per ricevervi la Regina, reduce
«ialla Sardegna.
E fu durante tale, soggiorno ligure, che la placida
atmosfera «Iella corte piemontese, fu, come altre
corti grandi e piccole, scossa all’improvviso dalla
non supposta notizia della partenza di Napoleone
dall’isola d ’Elba per destinazione ignota.
A Vienna, se«le allora di congresso politico, sovrani,
principi e diplomatici radunati, seppero con stupore
la temibile novella e corsero tosto ai primi r ";
Per parte sua, il marchese di Osmond, ambasciatore
«li Francia a Torino e padre, come ho detto, della
nostra memorialista, si affrettò a spedire una staf
fetta al ministro francese degli esteri Talleyrand che
si trovava appunto a Vienna per il Congresso.
Nell’ambiente «Iella Corte sarda, si riteneva che
Napoleone intendesse sbarcare in qualche punto delle
coste italiane per unirsi alle truppe napoletane di
Murat, suo cognato, che da qualche tempo si riar
mava. Gli austriaci, tramite il generale Bubna, chie-»
«levano senz'altro al governo sardo di entrare in
Piemonte per «misura di difesa», ma il governo stesso,
anticipatore di ben altri rifiuti all’Austria, non diede
consenso alla proposta e neppure modificò il proprio
punto di vista, quando l’Austria minacciò di trince
rarsi dietro al Po, lasciando scoperte le terre pie
montesi. E, si aggiunga subito a questo proposito
che, pure in seguito, quando gli ambasciatori delle
varie potenze si trasferirono a Gand al seguito del
profugo re Luigi X V i l i, il solo a mancare, fu l’am ba
sciatore sardo, (s’intende che la di Boigne, francese,
dà torto a quella condotta « neutrale » di fronte a
Napoleone ed a Murat).
Frattanto, all’infuori delle più lente comunicazioni
delle Cancellerie, su l’ali del vento e per virtù d ’ignoti
giungevano in Piemonte, come in altre parti d’E u
ropa, le notizie della rapida marcia di Napoleone e,
ciò che più conta, i suoi successi continui ed immediati.
I l panico, del resto, non colpiva tanto le popola
zioni di loro natura pacifiche o almeno indifferenti,
ma
i sovrani ed i principi.
Il
Re
di Sardegna era rientrato a Torino.
E, quivi, da varie parti, incominciavano a giun
gere
illustri profughi, primo tra essi, fl Papa (Pio V II
Chiaramonti).


















