
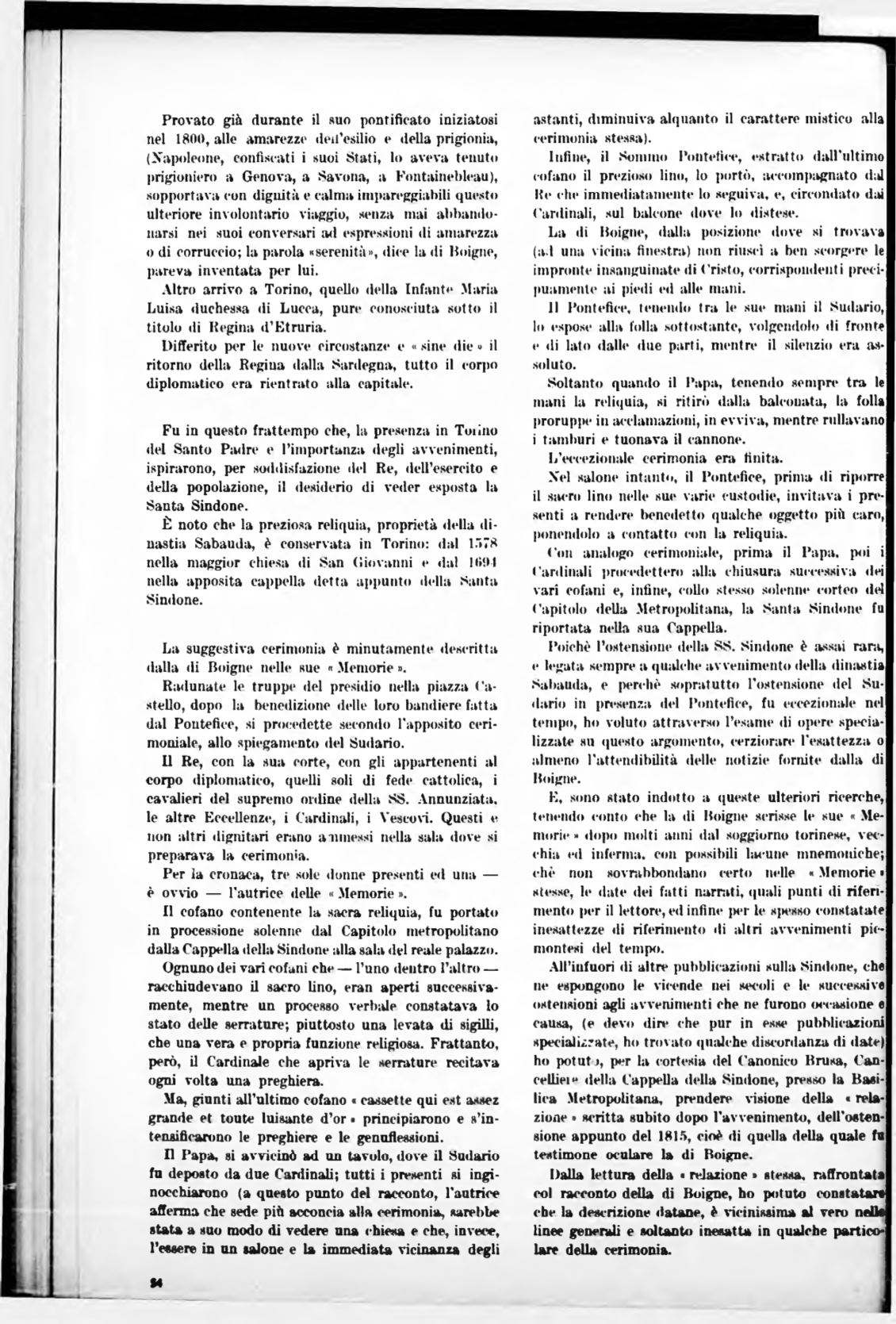
Provato già durante il suo pontificato iniziatosi
nel
1800
, alle amarezze deil’esilio e della prigionia,
(Napoleone, confiscati i suoi Stati, lo aveva tenuto
prigioniero a Genova, a Savona, a Fontainebleau),
sopportava con dignità e calma impareggiabili questo
ulteriore involontario viaggio, senza mai abbando
narsi nei suoi conversari ad espressioni di amarezza
o di corruccio; la parola «serenità», dice la di Boigne,
pareva inventata per lui.
Altro arrivo a Torino, quello della Infante Maria
Luisa duchessa di Lucca, pure conosciuta sotto il
titolo di Regina d ’Etruria.
Differito per le nuove circostanze e « sine die » il
ritorno della Regina dalla Sardegna, tutto il corpo
diplomatico era rientrato alla capitale.
Fu in questo frattempo che, la presenza in Toiino
del Santo Padre e l’importanza degli avvenimenti,
ispirarono, per soddisfazione del Re, dell’esercito e
della popolazione, il desiderio di veder esposta la
Santa Sindone.
È noto che la preziosa reliquia, proprietà della d i
nastia Sabauda, è conservata in Torino: dal
1578
nella maggior chiesa di San Giovanni e dal
169-1
nella apposita cappella detta appunto della Santa
Sindone.
La suggestiva cerimonia è minutamente descritta
dalla di Boigne nelle sue « Memorie ».
Radunate le truppe del presidio nella piazza f a
stello, dopo la benedizione delle loro bandiere fatta
dal Pontefice, si procedette secondo l'apposito ceri
moniale, allo spiegamento del Sudario.
Il Re, con la sua corte, con gli appartenenti al
corpo diplomatico, quelli soli di fede cattolica, i
cavalieri del supremo online della SS. Annunziata,
le altre Eccellenze, i Cardinali, i Vescovi. Questi e.
non altri dignitari erano ammessi nella sala dove si
preparava la cerimonia.
Per la cronaca, tre sole donne presenti ed uua —
è ovvio — l'autrice delle « Memorie ».
Il cofano contenente la sacra reliquia, fu portato
in processione solenne dal Capitolo metropolitano
dalla Cappella della Sindone alla sala del reale palazzo.
Ognuno dei vari cofani che — l’uno dentro l’altro —
racchiudevano il sacro Uno, eran aperti successiva
mente, mentre un processo verbale constatava lo
stato delle serrature; piuttosto una levata di sigilli,
che una vera e propria funzione religiosa. Frattanto,
però, il Cardinale che apriva le serrature recitava
ogni volta una preghiera.
Ma, giunti all’ultimo cofano « cassette qui est assez
grande et toute luisante d ’or » principiarono e s’in
tensificarono le preghiere e le genuflessioni.
Il Papa, si avvicinò ad un tavolo, dove il Sudario
fu deposto da due Cardinali; tu tti i presenti si ingi
nocchiarono (a questo punto del racconto, l’autrice
afferma che sede più acconcia alla cerimonia, sarebbe
stata a suo modo di vedere una chiesa e che, invece,
l’essere in un salone e la immediata vicinanza degli
astanti, dim inuiva alquanto il carattere mistico alla
cerimonia stessa).
Infine, il Sommo Pontefice, estratto dall'ultimo
cofano il prezioso lino, lo portò, accompagnato dal
Re che immediatamente lo seguiva, e, circondato dai
Cardinali, sul balcone dove lo distese.
L a di Boigne, dalla posizione «love si trovava
(ad una vicina finestra) non riuscì a ben scorgere le
impronte insanguinate di ('risto, corrispondenti preci
puamente ai piedi ed alle mani.
1
Pontefice, tenendo tra le sue mani il Sudario,
10 espose alla folla sottostante, volgendolo di fronte
e di lato dalle due parti, mentre il silenzio era as-
soluto.
Soltanto quando il Papa, tenendo sempre tra le
mani la reliquia, si ritirò dalla balconata, la folla
proruppe in acclamazioni, in evviva, mentre rullavano
i tamburi e tuonava il cannone.
L ’eccezionale cerimonia era finita.
Nel salone intanto, il Pontefice, prima di riporre
11 sacro lino nelle sue varie custodie, invitava i pre
senti a rendere benedetto qualche oggetto più caro,
ponendolo a contatto con la reliquia.
Con analogo cerimoniale, prima il Papa, poi i
Cardinali procedettero alla chiusura successiva dei
vari cofani e, infine, collo stesso solenne corteo del
Capitolo della Metropolitana, la Santa Sindone fu
riportata nella sua Cappella.
Poiché l’ostensioue della SS. Sindone è assai rara,
e legata sempre a qualche avvenimento della dinastia
Sabauda, e perchè sopratutto l’ostensione del S u
dario in presenza del Pontefice, fu eccezionale nel
tempo, ho voluto attraverso l’esame di opere specia
lizzate su questo argomento, cerziorare l'esattezza o
almeno l’attendibilità delle notizie fornite dalla di
Boigne.
E, sono stato indotto a queste ulteriori ricerche,
tenendo conto che la di Boigne scrisse le sue « Me
morie » dopo molti anni dal soggiorno torinese, vec
chia ed inferma, con possibili lacune mnemoniche;
che non sovrabbondano certo nelle « Memorie »
stesse, le date dei fatti narrati, «mali punti di riferi
mento per il lettore, ed infine per le spesso constatate
inesattezze di riferimento di altri avvenimenti pie
montesi del tempo.
All’infuori di altre pubblicazioni sulla Sindone, che
ne espongono le vicende nei secoli e le successive
ostensioni agli avvenimenti che ne furono occasione e
causa, (e devo dire che pur in esse pubblicazioni
specializzate, ho trovato qualche discordanza di date)
ho potuto, per la cortesia del Canonico Brasa, Can
cellici •* della Cappella della Sindone, presso la Basi
lica Metropolitana, prendere visione della « rela
zione » scritta subito dopo l’avvenimento, dell'osten-
sione appunto del
1815,
cioè di quella della quale
fu
testimone oculare la di Boigne.
Dalla lettura della « relazione * stessa, raffrontata
col racconto della di Boigne, ho potuto constatare
che la descrizione datane, è vicinissima al vero nelle
linee generali e soltanto inesatta in qualche partico
lare della cerimonia.
M


















