
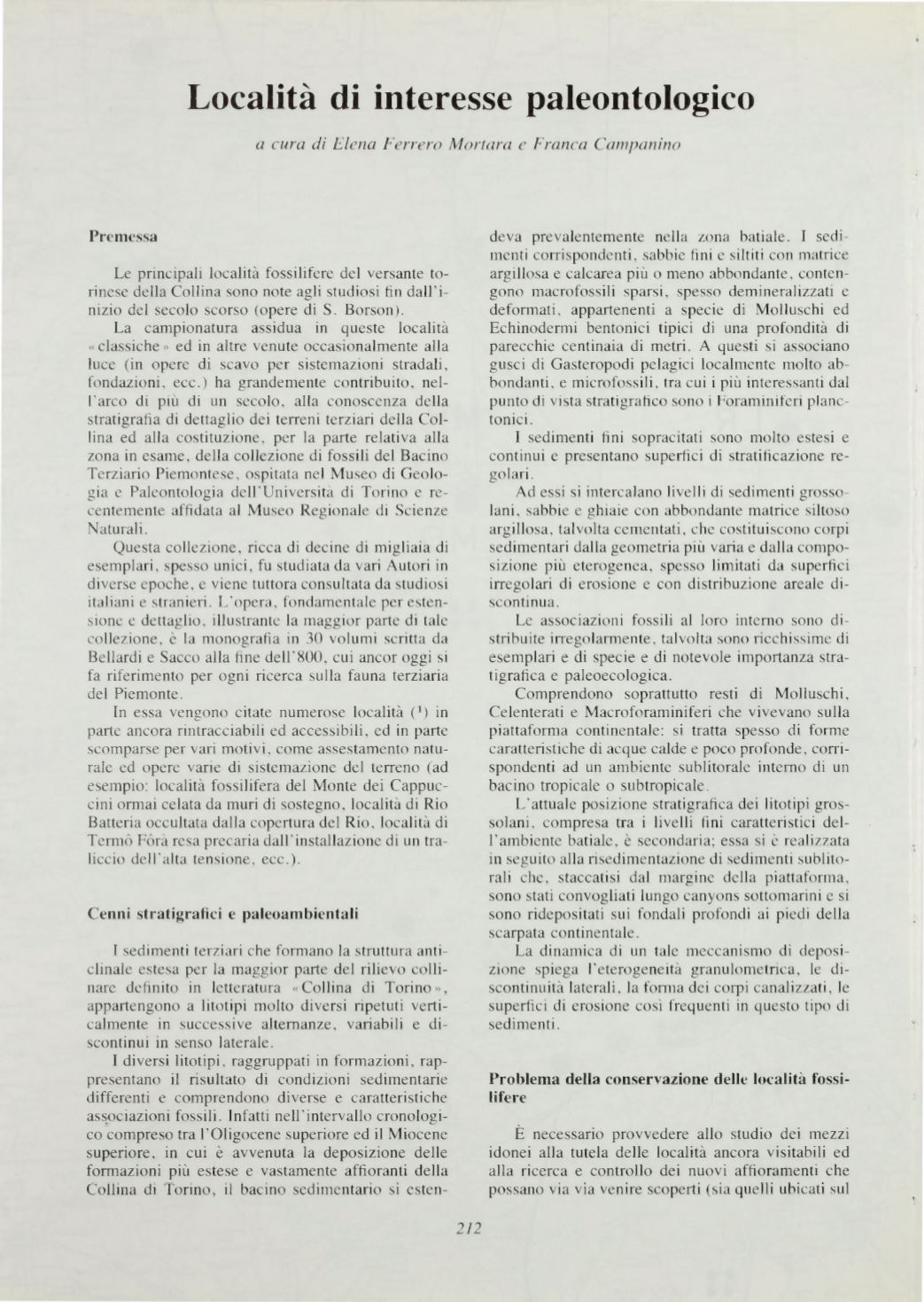
Località di interesse paleontologico
a cura
di Elena Ferrero Mortara e Franca Campanino
Premessa
Le principali località fossilifere del versante to-
rinese della Collina sono note agli studiosi fin dall'i-
nizio del secolo scorso (opere di S. Borson).
La campionatura assidua in queste località
« classiche » ed in altre venute occasionalmente alla
luce (in opere di scavo per sistemazioni stradali,
fondazioni, ecc.) ha grandemente contribuito, nel-
l'arco di più di un secolo, alla conoscenza della
stratigrafia di dettaglio dei terreni terziari della Col-
lina ed alla costituzione, per la parte relativa alla
zona in esame, della collezione di fossili del Bacino
Terziario Piemontese, ospitata nel Museo di Geolo-
gia e Paleontologia dell'Università di Torino e re-
centemente affidata al Museo Regionale di Scienze
Naturali.
Questa collezione, ricca di decine di migliaia di
esemplari, spesso unici, fu studiata da vari Autori in
diverse epoche, e viene tuttora consultata da studiosi
italiani e stranieri. L'opera, fondamentale per esten-
sione e dettaglio, illustrante la maggior parte di tale
collezione,
è
la monografia in 30 volumi scritta da
Bellardi e Sacco alla fine dell'800, cui ancor oggi si
fa riferimento per ogni ricerca sulla fauna terziaria
del Piemonte.
In essa vengono citate numerose località (
1
) in
parte ancora rintracciabili ed accessibili, ed in parte
scomparse per vari motivi, come assestamento natu-
rale ed opere varie di sistemazione del terreno (ad
esempio: località fossilifera del Monte dei Cappuc-
cini ormai celata da muri di sostegno, località di Rio
Batteria occultata dalla copertura del Rio, località di
Termó Fórà resa precaria dall'installazione di un tra-
liccio dell'alta tensione, ecc.).
Cenni stratigrafici e paleoambientali
I sedimenti terziari che formano la struttura anti-
clinale estesa per la maggior parte del rilievo colli-
nare definito in letteratura « Collina di Torino »,
appartengono a litotipi molto diversi ripetuti verti-
calmente in successive alternanze, variabili e di-
scontinui in senso laterale.
I diversi litotipi, raggruppati in formazioni, rap-
presentano il risultato di condizioni sedimentarie
differenti e comprendono diverse e caratteristiche
associazioni fossili. Infatti nell'intervallo cronologi-
co compreso tra l'Oligocene superiore ed il Miocene
superiore, in cui
è
avvenuta la deposizione delle
formazioni più estese e vastamente affioranti della
Collina di Torino, il bacino sedimentario si esten-
deva prevalentemente nella zona batiale. I sedi-
menti corrispondenti, sabbie fini e siltiti con matrice
argillosa e calcarea più o meno abbondante, conten-
gono macrofossili sparsi, spesso demineralizzati e
deformati, appartenenti a specie di Molluschi ed
Echinodermi bentonici tipici di una profondità di
parecchie centinaia di metri. A questi si associano
gusci di Gasteropodi pelagici localmente molto ab-
bondanti, e microfossili, tra cui i più interessanti dal
punto di vista stratigrafico sono i Foraminiferi planc-
tonici.
I sedimenti fini sopracitati sono molto estesi e
continui e presentano superfici di stratificazione re-
golari.
Ad essi si intercalano livelli di sedimenti grosso-
lani, sabbie e ghiaie con abbondante matrice siltoso
argillosa, talvolta cementati, che costituiscono corpi
sedimentari dalla geometria più varia e dalla compo-
sizione più eterogenea, spesso limitati da superfici
irregolari di erosione e con distribuzione areale di-
scontinua.
Le associazioni fossili al loro interno sono di-
stribuite irregolarmente, talvolta sono ricchissime di
esemplari e di specie e di notevole importanza stra-
tigrafica e paleoecologica.
Comprendono soprattutto resti di Molluschi,
Celenterati e Macroforaminiferi che vivevano sulla
piattaforma continentale: si tratta spesso di forme
caratteristiche di acque calde e poco profonde, corri-
spondenti ad un ambiente sublitorale interno
di
un
bacino tropicale o subtropicale.
L'attuale posizione stratigrafica dei litotipi gros-
solani, compresa tra i livelli fini caratteristici del-
l'ambiente batiale, è secondaria; essa si è realizzata
in seguito alla risedimentazione di sedimenti sublito-
rali che, staccatisi dal margine della piattaforma,
sono stati convogliati lungo canyons sottomarini e si
sono ridepositati sui fondali profondi ai piedi della
scarpata continentale.
La dinamica di un tale meccanismo di deposi-
zione spiega l'eterogeneità granulometrica, le di-
scontinuità laterali, la forma dei corpi canalizzati, le
superfici di erosione
così
frequenti in questo tipo di
sedimenti.
Problema della conservazione delle località fossi-
lifere
È necessario provvedere allo studio dei mezzi
idonei alla tutela delle località ancora visitabili ed
alla ricerca e controllo dei nuovi affioramenti che
possano via via venire scoperti (sia quelli ubicati sul
212


















