
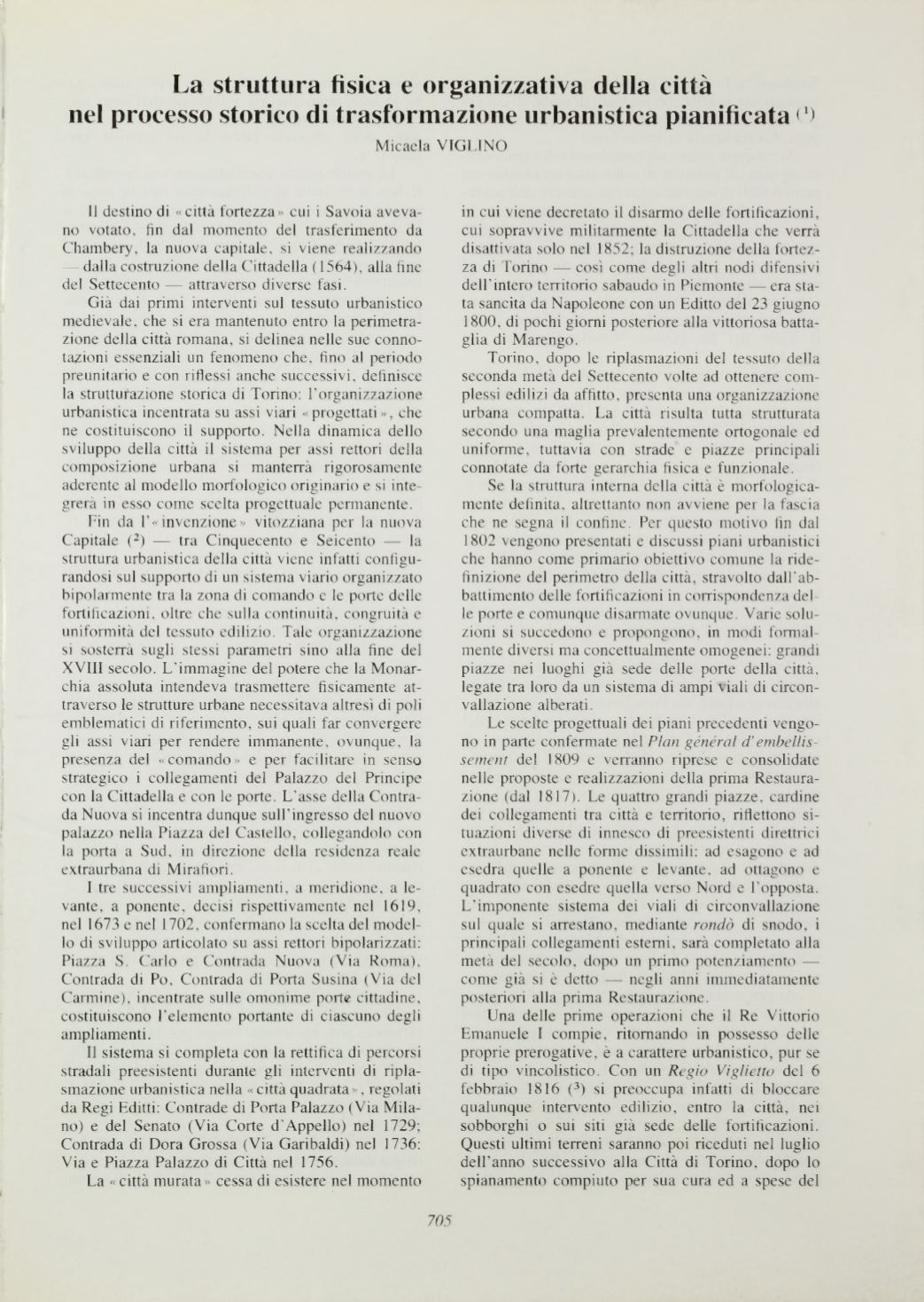
La struttura fisica e organizzativa della città
nel processo storico di trasformazione urbanistica pianificata
(
1
)
Micaela VIGLINO
Il destino di « città fortezza» cui i Savoia aveva-
no votato, fin dal momento del trasferimento da
Chambery, la nuova capitale, si viene realizzando
— dalla costruzione della Cittadella (1564), alla fine
del Settecento attraverso diverse fasi.
Già dai primi interventi sul tessuto urbanistico
medievale, che si era mantenuto entro la perimetra-
zione della città romana, si delinea nelle sue conno-
tazioni essenziali un fenomeno che, fino al periodo
preunitario e con riflessi anche successivi, definisce
la strutturazione storica di Torino: l'organizzazione
urbanistica incentrata su assi viari « progettati », che
ne costituiscono il supporto. Nella dinamica dello
sviluppo della città il sistema per assi rettori della
composizione urbana si manterrà rigorosamente
aderente al modello morfologico originario e si inte-
grerà in esso come scelta progettuale permanente.
Fin da
l' «
invenzione » vitozziana per la nuova
Capitale (
2
) tra Cinquecento e Seicento la
struttura urbanistica della città viene infatti configu-
randosi sul supporto di un sistema viario organizzato
bipolarmente tra la zona di comando e le porte delle
fortificazioni, oltre che sulla continuità, congruità e
uniformità del tessuto edilizio. Tale organizzazione
si sosterrà sugli stessi parametri sino alla fine del
XVIII secolo. L'immagine del potere che la Monar-
chia assoluta intendeva trasmettere fisicamente at-
traverso le strutture urbane necessitava altresì di poli
emblematici di riferimento, sui quali far convergere
gli assi viari per rendere immanente, ovunque, la
presenza del «comando» e per facilitare in senso
strategico i collegamenti del Palazzo del Principe
con la Cittadella e con le porte. L'asse della Contra-
da Nuova si incentra dunque sull'ingresso del nuovo
palazzo nella Piazza del Castello, collegandolo con
la porta a Sud, in direzione della residenza reale
extraurbana di Mirafiori.
I tre successivi ampliamenti, a meridione, a le-
vante, a ponente, decisi rispettivamente nel 1619,
nel 1673 e nel
1
702, confermano la scelta del model-
lo di sviluppo articolato su assi rettori bipolarizzati:
Piazza S. Carlo e Contrada Nuova (Via Roma),
Contrada di Po, Contrada di Porta Susina (Via del
Carmine), incentrate sulle omonime porte cittadine,
costituiscono l'elemento portante di ciascuno degli
ampliamenti.
Il sistema si completa con la rettifica di percorsi
stradali preesistenti durante gli interventi di ripla-
smazione urbanistica nella «città quadrata», regolati
da Regi Editti: Contrade di Porta Palazzo (Via Mila-
no) e del Senato (Via Corte d'Appello) nel 1729;
Contrada di Dora Grossa (Via Garibaldi) nel 1736:
Via e Piazza Palazzo di Città nel 1756.
La «città murata» cessa di esistere nel momento
in cui viene decretato il disarmo delle fortificazioni,
cui sopravvive militarmente la Cittadella che verrà
disattivata solo nel 1852; la distruzione della fortez-
za di Torino così come degli altri nodi difensivi
dell'intero territorio sabaudo in Piemonte era sta-
ta sancita da Napoleone con un Editto del 23 giugno
1800, di pochi giorni posteriore alla vittoriosa batta-
glia di Marengo.
Torino, dopo le riplasmazioni del tessuto della
seconda metà del Settecento volte ad ottenere com-
plessi edilizi da affitto, presenta una organizzazione
urbana compatta. La città risulta tutta strutturata
secondo una maglia prevalentemente ortogonale ed
uniforme, tuttavia con strade e piazze principali
connotate da forte gerarchia fisica e funzionale.
Se la struttura interna della città è morfologica-
mente definita, altrettanto non avviene per la fascia
che ne segna il confine. Per questo motivo fin dal
1802 vengono presentati e discussi piani urbanistici
che hanno come primario obiettivo comune la ride-
finizione del perimetro della città, stravolto dall'ab-
battimento delle fortificazioni in corrispondenza del-
le porte e comunque disarmate ovunque. Varie solu-
zioni si succedono e propongono,
in
modi formal-
mente diversi ma concettualmente omogenei: grandi
piazze nei luoghi già sede delle porte della città,
legate tra loro da un sistema di ampi viali di circon-
vallazione alberati.
Le scelte progettuali dei piani precedenti vengo-
no in parte confermate nel
Ptan générat d' embeltis-
sement
del 1809 e verranno riprese e consolidate
nelle proposte e realizzazioni della prima Restaura-
zione (dal 1817). Le quattro grandi piazze, cardine
dei collegamenti tra città e territorio, riflettono si-
tuazioni diverse di innesco di preesistenti direttrici
extraurbane nelle forme dissimili: ad esagono e ad
esedra quelle a ponente e levante, ad ottagono e
quadrato con esedre quella verso Nord e l'opposta.
L'imponente sistema dei viali di circonvallazione
sul quale si arrestano, mediante
rondò
di snodo, i
principali collegamenti esterni, sarà completato alla
metà del secolo, dopo un primo potenziamento
come già si è detto — negli anni immediatamente
posteriori alla prima Restaurazione.
Una delle prime operazioni che il Re Vittorio
Emanuele I compie, ritornando in possesso delle
proprie prerogative, è a carattere urbanistico, pur se
di tipo vincolistico. Con un
Regio Vigtietto
del 6
febbraio 1816 (
3
) si preoccupa infatti di bloccare
qualunque intervento edilizio, entro la città, nei
sobborghi o sui siti già sede delle fortificazioni.
Questi ultimi terreni saranno poi riceduti nel luglio
dell'anno successivo alla Città di Torino, dopo lo
spianamento compiuto per sua cura ed a spese del
705


















