
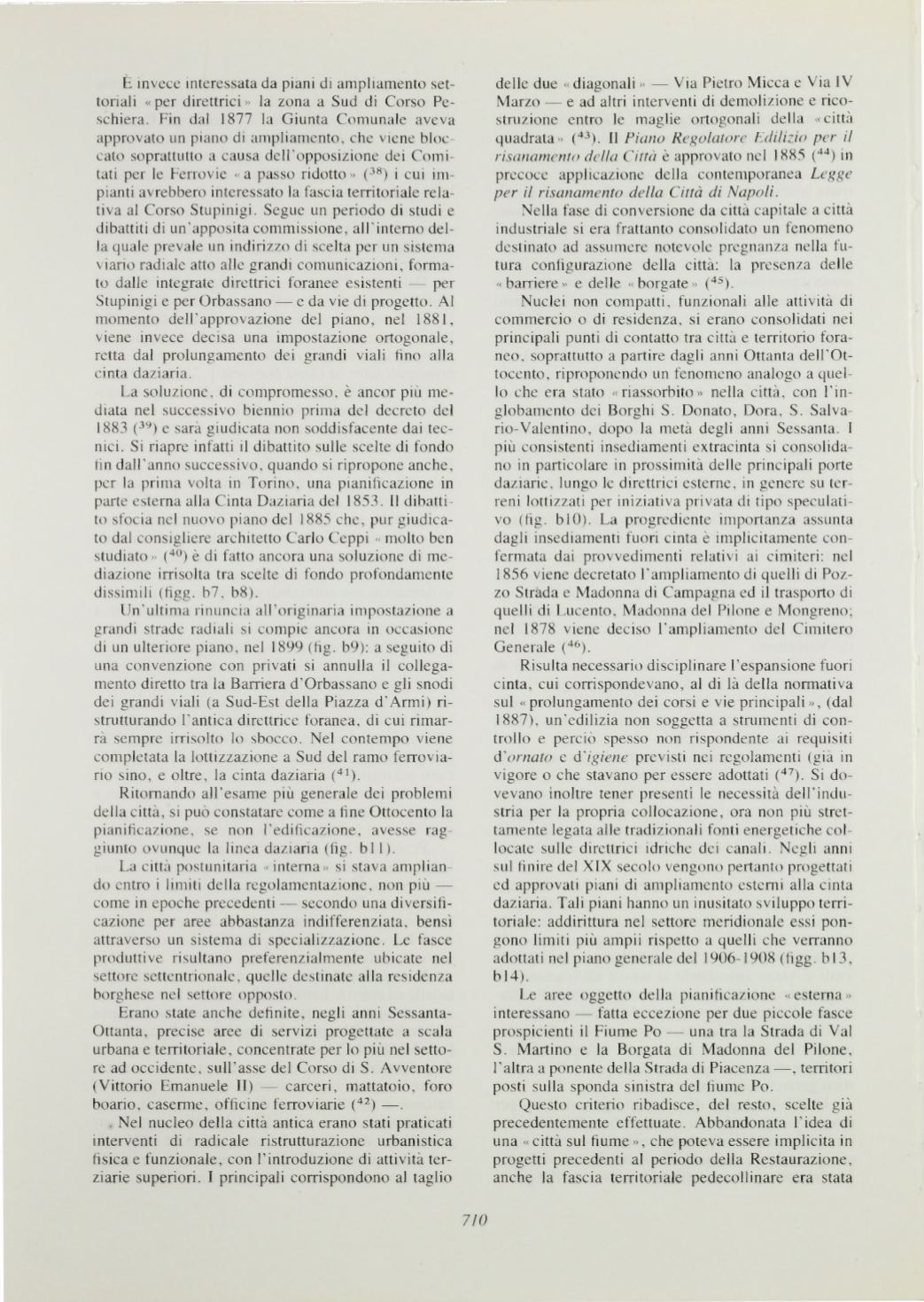
È invece interessata da piani di ampliamento set-
toriali « per direttrici » la zona a Sud di Corso Pe-
schiera. Fin dal 1877 la Giunta Comunale aveva
approvato un piano di ampliamento, che viene bloc-
cato soprattutto a causa dell'opposizione dei Comi-
tati per le Ferrovie « a passo ridotto » (
38
) i cui im-
pianti avrebbero interessato la fascia territoriale rela-
tiva al Corso Stupinigi. Segue un periodo di studi e
dibattiti di un'apposita commissione, all'interno del-
la quale prevale un indirizzo di scelta per un sistema
viario radiale atto alle grandi comunicazioni, forma-
to dalle integrate direttrici foranee esistenti — per
Stupinigi e per Orbassano e da vie di progetto. Al
momento dell'approvazione del piano, nel 1881,
viene invece decisa una impostazione ortogonale,
retta dal prolungamento dei grandi viali fino alla
cinta daziaria.
La soluzione, di compromesso, è ancor più me-
diata nel successivo biennio prima del decreto del
1883 (
39
) e sarà giudicata non soddisfacente dai tec-
nici. Si riapre infatti il dibattito sulle scelte di fondo
fin dall'anno successivo, quando si ripropone anche,
per la prima volta in Torino, una pianificazione in
parte esterna alla Cinta Daziaria del 1853. II dibatti-
to sfocia nel nuovo piano del 1885 che, pur giudica-
to dal consigliere architetto Carlo Ceppi « molto ben
studiato » (
40
) è di fatto ancora una soluzione di me-
diazione irrisolta tra scelte di fondo profondamente
dissimili (figg. b7, b8).
Un'ultima rinuncia all'originaria impostazione a
grandi strade radiali si compie ancora in occasione
di un ulteriore piano, nel 1899 (fig. b9): a seguito di
una convenzione con privati si annulla il collega-
mento diretto tra la Barriera d'Orbassano e gli snodi
dei grandi viali (a Sud-Est della Piazza d'Armi) ri-
strutturando l'antica direttrice foranea, di cui rimar-
rà sempre irrisolto lo sbocco. Nel contempo viene
completata la lottizzazione a Sud del ramo ferrovia-
rio sino, e oltre, la cinta daziaria (
41
).
Ritornando all'esame più generale dei problemi
della città, si può constatare come a fine Ottocento la
pianificazione, se non l'edificazione, avesse rag-
giunto ovunque la linea daziaria (fig. bl1).
La città postunitaria « interna» si stava amplian-
do entro i limiti della regolamentazione, non più —
come in epoche precedenti — secondo una diversifi-
cazione per aree abbastanza indifferenziata, bensì
attraverso un sistema di specializzazione. Le fasce
produttive risultano preferenzialmente ubicate nel
settore settentrionale, quelle destinate alla residenza
borghese nel settore opposto.
Erano state anche definite, negli anni Sessanta-
Ottanta, precise aree di servizi progettate a scala
urbana e territoriale, concentrate per lo più nel setto-
re ad occidente, sull'asse del Corso di S. Avventore
(Vittorio Emanuele II) carceri, mattatoio, foro
boario, caserme, officine ferroviarie (42) —.
» Nel nucleo della città antica erano stati praticati
interventi di radicale ristrutturazione urbanistica
fisica e funzionale, con l'introduzione di attività ter-
ziarie superiori. I principali corrispondono al taglio
delle due «diagonali» Via Pietro Micca e Via IV
Marzo e ad altri interventi di demolizione e rico-
struzione entro le maglie ortogonali della «città
quadrata» (
43
). Il
Piano Regolatore Editizio per it
risanamento detta Città è
approvato nel I885 (
44
) in
precoce applicazione della contemporanea
Legge
per il risanamento della Città di Napoti.
Nella fase di conversione da città capitale a città
industriale si era frattanto consolidato un fenomeno
destinato ad assumere notevole pregnanza nella fu-
tura configurazione della città: la presenza delle
barriere » e delle « borgate » (
45
).
Nuclei non compatti, funzionali alle attività di
commercio o di residenza, si erano consolidati nei
principali punti di contatto tra città e territorio fora-
neo, soprattutto a partire dagli anni Ottanta dell'Ot-
tocento, riproponendo un fenomeno analogo a quel-
lo che era stato «riassorbito » nella città, con l'in-
globamento dei Borghi S. Donato, Dora, S. Salva-
rio-Valentino, dopo la metà degli anni Sessanta. I
più consistenti insediamenti extracinta si consolida-
no in particolare in prossimità delle principali porte
daziarie, lungo le direttrici esterne, in genere su ter-
reni lottizzati per iniziativa privata di tipo speculati-
vo (fig. b10). La progrediente importanza assunta
dagli insediamenti fuori cinta è implicitamente con-
fermata dai provvedimenti relativi ai cimiteri: nel
1856 viene decretato l'ampliamento di quelli di Poz-
zo Strada e Madonna di Campagna ed il trasporto di
quelli di Lucento, Madonna del Pilone e Mongreno;
nel 1878 viene deciso l'ampliamento del Cimitero
Generale (
46
)
Risulta necessario disciplinare l'espansione fuori
cinta, cui corrispondevano, al di là della normativa
sul «prolungamento dei corsi e vie principali», (dal
1887), un'edilizia non soggetta a strumenti di con-
trollo e perciò spesso non rispondente ai requisiti
d'ornato
e
d'igiene
previsti nei regolamenti
(già
in
vigore o che stavano per essere adottati (
47
). Si do-
vevano inoltre tener presenti le necessità dell'indu-
stria per la propria collocazione, ora non più stret-
tamente legata alle tradizionali fonti energetiche col-
locate sulle direttrici idriche dei canali. Negli anni
sul finire del XIX secolo vengono pertanto progettati
ed approvati piani di ampliamento esterni alla cinta
daziaria. Tali piani hanno un inusitato sviluppo terri-
toriale: addirittura nel settore meridionale essi pon-
gono limiti più ampii rispetto a quelli che verranno
adottati nel piano generale del 1906-1908 (figg. b13,
b14).
Le aree oggetto della pianificazione « esterna »
interessano — fatta eccezione per due piccole fasce
prospicienti il Fiume Po — una tra la Strada di Val
S. Martino e la Borgata di Madonna del Pilone,
l'altra a ponente della Strada di Piacenza —, territori
posti sulla sponda sinistra del fiume Po.
Questo criterio ribadisce, del resto, scelte già
precedentemente effettuate. Abbandonata l'idea di
una «città sul fiume», che poteva essere implicita in
progetti precedenti al periodo della Restaurazione,
anche la fascia territoriale pedecollinare era stata
710


















