
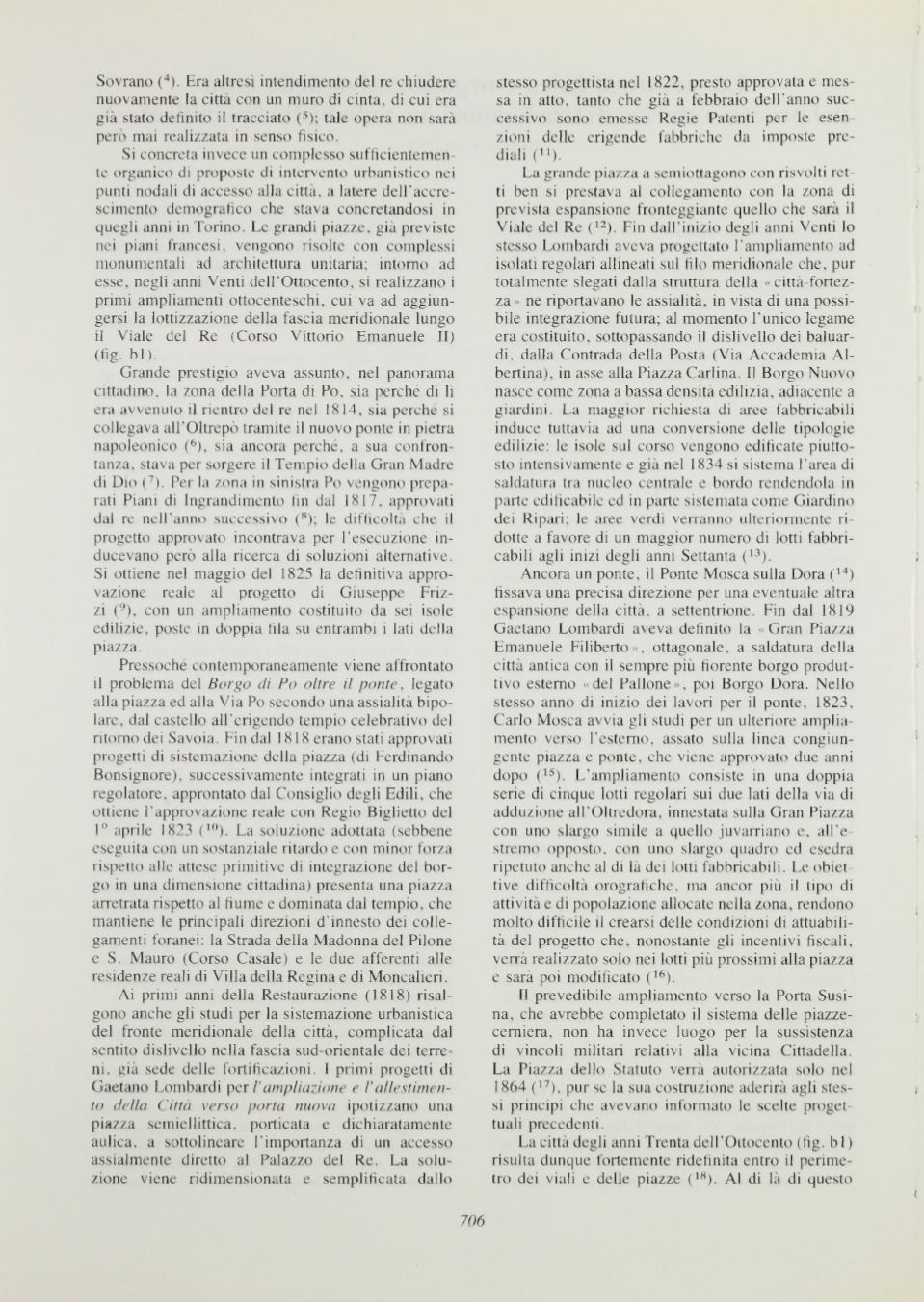
Sovrano (
4
). Era altresì intendimento del re chiudere
nuovamente la città con un muro di cinta, di cui era
già stato definito il tracciato (
5
); tale opera non sarà
però mai realizzata in senso fisico.
Si concreta invece un complesso sufficientemen-
te organico di proposte di intervento urbanistico nei
punti nodali di accesso alla città, a latere dell'accre-
scimento demografico che stava concretandosi in
quegli anni in Torino. Le grandi piazze, già previste
nei piani francesi, vengono risolte con complessi
monumentali ad architettura unitaria; intorno ad
esse, negli anni Venti dell'Ottocento, si realizzano i
primi ampliamenti ottocenteschi, cui va ad aggiun-
gersi la lottizzazione della fascia meridionale lungo
íl Viale del Re (Corso Vittorio Emanuele II)
(fig. b1).
Grande prestigio aveva assunto, nel panorama
cittadino, la zona della Porta di Po, sia perché di lì
era avvenuto il rientro del re nel 1814, sia perché si
collegava all'Oltrepò tramite il nuovo ponte in pietra
napoleonico (
6
), sia ancora perché, a sua confron-
tanza, stava per sorgere il Tempio della Gran Madre
di Dio (
7
). Per la zona in sinistra Po vengono prepa-
rati Piani di Ingrandimento fin dal 1817, approvati
dal re nell'anno successivo (
8
); le difficoltà che il
progetto approvato incontrava per l'esecuzione in-
ducevano però alla ricerca di soluzioni alternative.
Si ottiene nel maggio del 1825 la definitiva appro-
vazione reale al progetto di Giuseppe Friz-
zi (
9
), con un ampliamento costituito da sei isole
edilizie, poste in doppia fila su entrambi i lati della
piazza.
Pressoché contemporaneamente viene affrontato
il problema del
Borgo di Po ottre il ponte,
legato
alla piazza ed alla Via Po secondo una assialità bipo-
lare, dal castello all'erigendo tempio celebrativo del
ritorno dei Savoia. Fin dal 1 818 erano stati approvati
progetti di sistemazione della piazza (di Ferdinando
Bonsignore), successivamente integrati in un piano
regolatore, approntato dal Consiglio degli Edili, che
ottiene l'approvazione reale con Regio Biglietto del
1° aprile 1823 (
10
). La soluzione adottata (sebbene
eseguita con un sostanziale ritardo e con minor forza
rispetto alle attese primitive di integrazione del bor-
go in una dimensione cittadina) presenta una piazza
arretrata rispetto al fiume e dominata dal tempio, che
mantiene le principali direzioni d'innesto dei colle-
gamenti foranei: la Strada della Madonna del Pilone
e S. Mauro (Corso Casale) e le due afferenti alle
residenze reali di Villa della Regina e di Moncalieri.
Ai primi anni della Restaurazione (1818) risal-
gono anche gli studi per la sistemazione urbanistica
del fronte meridionale della città, complicata dal
sentito dislivello nella fascia sud-orientale dei terre-
ni, già sede delle fortificazioni. I primi progetti di
Gaetano Lombardi per
l'amptiazione e l'attestimen-
to detla Città verso porta nuova
ipotizzano una
piazza semiellittica, porticata e dichiaratamente
aulica, a sottolineare l'importanza di un accesso
assialmente diretto al Palazzo del Re. La solu-
zione viene ridimensionata e semplificata dallo
stesso progettista nel 1822, presto approvata e mes-
sa in atto, tanto che già a febbraio dell'anno suc-
cessivo sono emesse Regie Patenti per le esen-
zioni delle erigende fabbriche da imposte pre-
diali (
11
).
La grande piazza a semiottagono con risvolti ret-
ti ben si prestava al collegamento con la zona di
prevista espansione fronteggiante quello che sarà il
Viale del Re (
12
). Fin dall'inizio degli anni Venti lo
stesso Lombardi aveva progettato l'ampliamento ad
isolati regolari allineati sul filo meridionale che, pur
totalmente slegati dalla struttura della « città-fortez-
za» ne riportavano le assialità, in vista di una possi-
bile integrazione futura; al momento l'unico legame
era costituito, sottopassando il dislivello dei baluar-
di, dalla Contrada della Posta (Via Accademia Al-
bertina), in asse alla Piazza Carlina. I1 Borgo Nuovo
nasce come zona a bassa densità edilizia, adiacente a
giardini. La maggior richiesta di aree fabbricabili
induce tuttavia ad una conversione delle tipologie
edilizie: le isole sul corso vengono edificate piutto-
sto intensivamente e già nel 1834 si sistema l'area di
saldatura tra nucleo centrale e bordo rendendola in
parte edificabile ed in parte sistemata come Giardino
dei Ripari; le aree verdi verranno ulteriormente ri-
dotte a favore di un maggior numero di lotti fabbri-
cabili agli inizi degli anni Settanta (
13
).
Ancora un ponte, il Ponte Mosca sulla Dora (14)
fissava una precisa direzione per una eventuale altra
espansione della città, a settentrione. Fin dal 1819
Gaetano Lombardi aveva definito la « Gran Piazza
Emanuele Filiberto » , ottagonale, a saldatura della
città antica con il sempre più fiorente borgo produt-
tivo esterno « del Pallone», poi Borgo Dora. Nello
stesso anno di inizio dei lavori per il ponte, 1823,
Carlo Mosca avvia gli studi per un ulteriore amplia-
mento verso l'esterno, assato sulla linea congiun-
gente piazza e ponte, che viene approvato due anni
dopo (
15
). L'ampliamento consiste in una doppia
serie di cinque lotti regolari sui due lati della via di
adduzione all'Oltredora, innestata sulla Gran Piazza
con uno slargo simile a quello juvarriano e, all'e-
stremo opposto, con uno slargo quadro ed esedra
ripetuto anche al di là dei lotti fabbricabili. Le obiet-
tive difficoltà orografiche, ma ancor più il tipo di
attività e di popolazione allocate nella zona, rendono
molto difficile il crearsi delle condizioni di attuabili-
tà del progetto che, nonostante gli incentivi fiscali,
verrà realizzato solo nei lotti più prossimi alla piazza
e sarà poi modificato (16)
Il prevedibile ampliamento verso la Porta Susi-
na, che avrebbe completato il sistema delle piazze-
cerniera, non ha invece luogo per la sussistenza
di vincoli militari relativi alla vicina Cittadella.
La Piazza dello Statuto verrà autorizzata solo nel
1864 (
17
), pur se la sua costruzione aderirà agli stes-
si principi che avevano informato le scelte proget-
tuali precedenti.
La città degli anni Trenta dell'Ottocento (fig. bi)
risulta dunque fortemente ridefinita entro il perime-
tro dei viali e delle piazze (
18
). Al di là di questo
706


















