
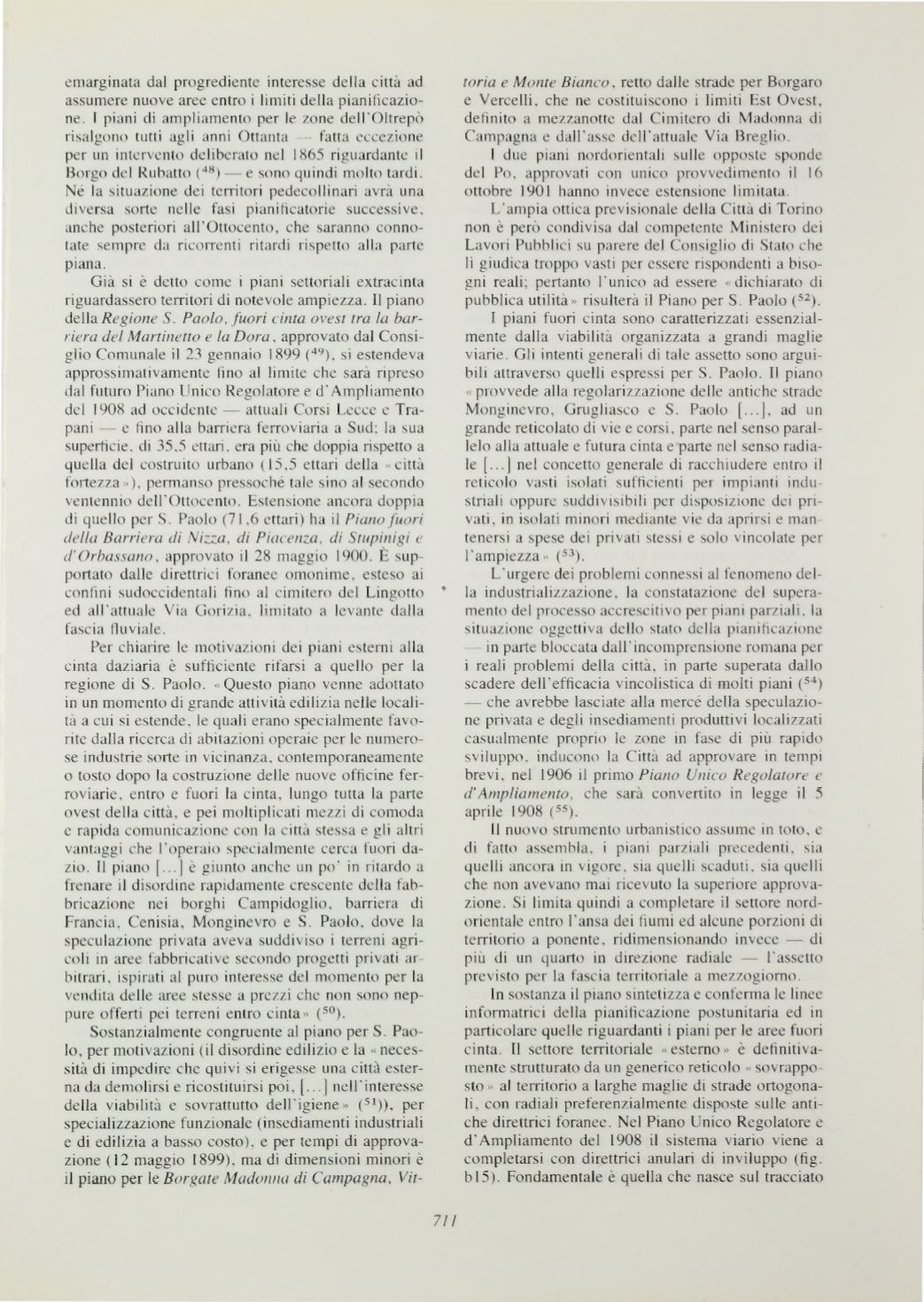
emarginata dal progrediente interesse della città ad
assumere nuove aree entro i limiti della pianificazio-
ne. I piani di ampliamento per le zone dell'Oltrepò
risalgono tutti agli anni Ottanta fatta eccezione
per un intervento deliberato nel 1865 riguardante il
Borgo del Rubatto (
48
) e sono quindi molto tardi.
Né la situazione dei territori pedecollinari avrà una
diversa sorte nelle fasi pianificatorie successive,
anche posteriori all'Ottocento, che saranno conno-
tate sempre da ricorrenti ritardi rispetto alla parte
piana.
Già si è detto come i piani settoriali extracinta
riguardassero territori di notevole ampiezza. Il piano
della
Regione S. Paolo, fuori cinta ovest tra ta bar-
riera det Martinetto e ta Dora,
approvato dal Consi-
glio Comunale il 23 gennaio 1899 (
49
), si estendeva
approssimativamente fino al limite che sarà ripreso
dal futuro Piano Unico Regolatore e d'Ampliamento
del 1908 ad occidente attuali Corsi Lecce e Tra-
pani e fino alla barriera ferroviaria a Sud; la sua
superficie, di 35,5 ettari, era più che doppia rispetto a
quella del costruito urbano (15,5 ettari della « città
fortezza»), permanso pressoché tale sino al secondo
ventennio dell'Ottocento. Estensione ancora doppia
di quello per S. Paolo (7I,6 ettari) ha il
Piano fuori
detta Barriera di Nizza, di Piacenza, di Stupinigi e
d'Orbassano,
approvato il 28 maggio 1900. È sup-
portato dalle direttrici foranee omonime, esteso ai
confini sudoccidentali fino al cimitero del Lingotto
ed all'attuale Via Gorizia, limitato a levante dalla
fascia fluviale.
Per chiarire le motivazioni dei piani esterni alla
cinta daziaria è sufficiente rifarsi a quello per la
regione di S. Paolo. « Questo piano venne adottato
in un momento di grande attività edilizia nelle locali-
tà a cui si estende, le quali erano specialmente favo-
rite dalla ricerca di abitazioni operaie per le numero-
se industrie sorte in vicinanza, contemporaneamente
o tosto dopo la costruzione delle nuove officine fer-
roviarie, entro e fuori la cinta, lungo tutta la parte
ovest della città, e pei moltiplicati mezzi di comoda
e rapida comunicazione con la città stessa e gli altri
vantaggi che l'operaio specialmente cerca fuori da-
zio. Il piano [...1 è giunto anche un po' in ritardo a
frenare il disordine rapidamente crescente della fab-
bricazione nei borghi Campidoglio, barriera di
Francia, Cenisia, Monginevro e S. Paolo, dove la
speculazione privata aveva suddiviso i terreni agri-
coli in aree fabbricative secondo progetti privati ar-
bitrari, ispirati al puro interesse del momento per la
vendita delle aree stesse a prezzi che non sono nep-
pure offerti pei terreni entro cinta» (50)
Sostanzialmente congruente al piano per S. Pao-
lo, per motivazioni (il disordine edilizio e la «neces-
sità di impedire che quivi si erigesse una città ester-
na da demolirsi e ricostituirsi poi, [...I nell'interesse
della viabilità e sovrattutto dell'igiene» (S
1
)), per
specializzazione funzionale (insediamenti industriali
e di edilizia a basso costo), e per tempi di approva-
zione (12 maggio 1899), ma di dimensioni minori è
il piano per le
Borgate Madonna di Campagna, Vit-
toria e Monte Bianco,
retto dalle strade per Borgaro
e Vercelli, che ne costituiscono i limiti Est Ovest,
definito a mezzanotte dal Cimitero di Madonna di
Campagna e dall'asse dell'attuale Via Breglio.
I due piani nordorientali sulle opposte sponde
del Po, approvati con unico provvedimento il 16
ottobre 1901 hanno invece estensione limitata.
L'ampia ottica previsionale della Città di Torino
non è però condivisa dal competente Ministero dei
Lavori Pubblici su parere del Consiglio di Stato che
li giudica troppo vasti per essere rispondenti a biso-
gni reali; pertanto l'unico ad essere «dichiarato di
pubblica utilità» risulterà il Piano per S. Paolo (52).
I piani fuori cinta sono caratterizzati essenzial-
mente dalla viabilità organizzata a grandi maglie
viarie. Gli intenti generali di tale assetto sono argui-
bili attraverso quelli espressi per S. Paolo. Il piano
« provvede alla regolarizzazione delle antiche strade
Monginevro, Grugliasco e S. Paolo [...], ad un
grande reticolato di vie e corsi, parte nel senso paral-
lelo alla attuale e futura cinta e parte nel senso radia-
le [...] nel concetto generale di racchiudere entro il
reticolo vasti isolati sufficienti per impianti indu-
striali oppure suddivisibili per disposizione dei pri-
vati, in isolati minori mediante vie da aprirsi e man-
tenersi a spese dei privati stessi e solo vincolate per
l'ampiezza» (
53
).
L'urgere dei problemi connessi al fenomeno del-
'
la industrializzazione, la constatazione del supera-
mento del processo accrescitivo per piani parziali, la
situazione oggettiva dello stato della pianificazione
— in parte bloccata dall'incomprensione romana per
i reali problemi della città, in parte superata dallo
scadere dell'efficacia vincolistica di molti piani (54)
— che avrebbe lasciate alla mercé della speculazio-
ne privata e degli insediamenti produttivi localizzati
casualmente proprio le zone in fase di più rapido
sviluppo, inducono la Città ad approvare in tempi
brevi, nel 1906 il primo
Piano Unico Regotatore e
d'Amptiamento,
che sarà convertito in legge il 5
aprile 1908 (55)
Il nuovo strumento urbanistico assume in toto, e
di fatto assembla, i piani parziali precedenti, sia
quelli ancora in vigore, sia quelli scaduti, sia quelli
che non avevano mai ricevuto la superiore approva-
zione. Si limita quindi a completare il settore nord-
orientale entro l'ansa dei fiumi ed alcune porzioni di
territorio a ponente, ridimensionando invece — di
più di un quarto in direzione radiale l'assetto
previsto per la fascia territoriale a mezzogiorno.
In sostanza il piano sintetizza e conferma le linee
informatrici della pianificazione postunitaria ed in
particolare quelle riguardanti i piani per le aree fuori
cinta. Il settore territoriale « esterno » è definitiva-
mente strutturato da un generico reticolo « sovrappo-
sto » al territorio a larghe maglie di strade ortogona-
li, con radiali preferenzialmente disposte sulle anti-
che direttrici foranee. Nel Piano Unico Regolatore e
d'Ampliamento del 1908 il sistema viario viene a
completarsi con direttrici anulari di inviluppo (fig.
b15). Fondamentale
è
quella che nasce sul tracciato
711


















