
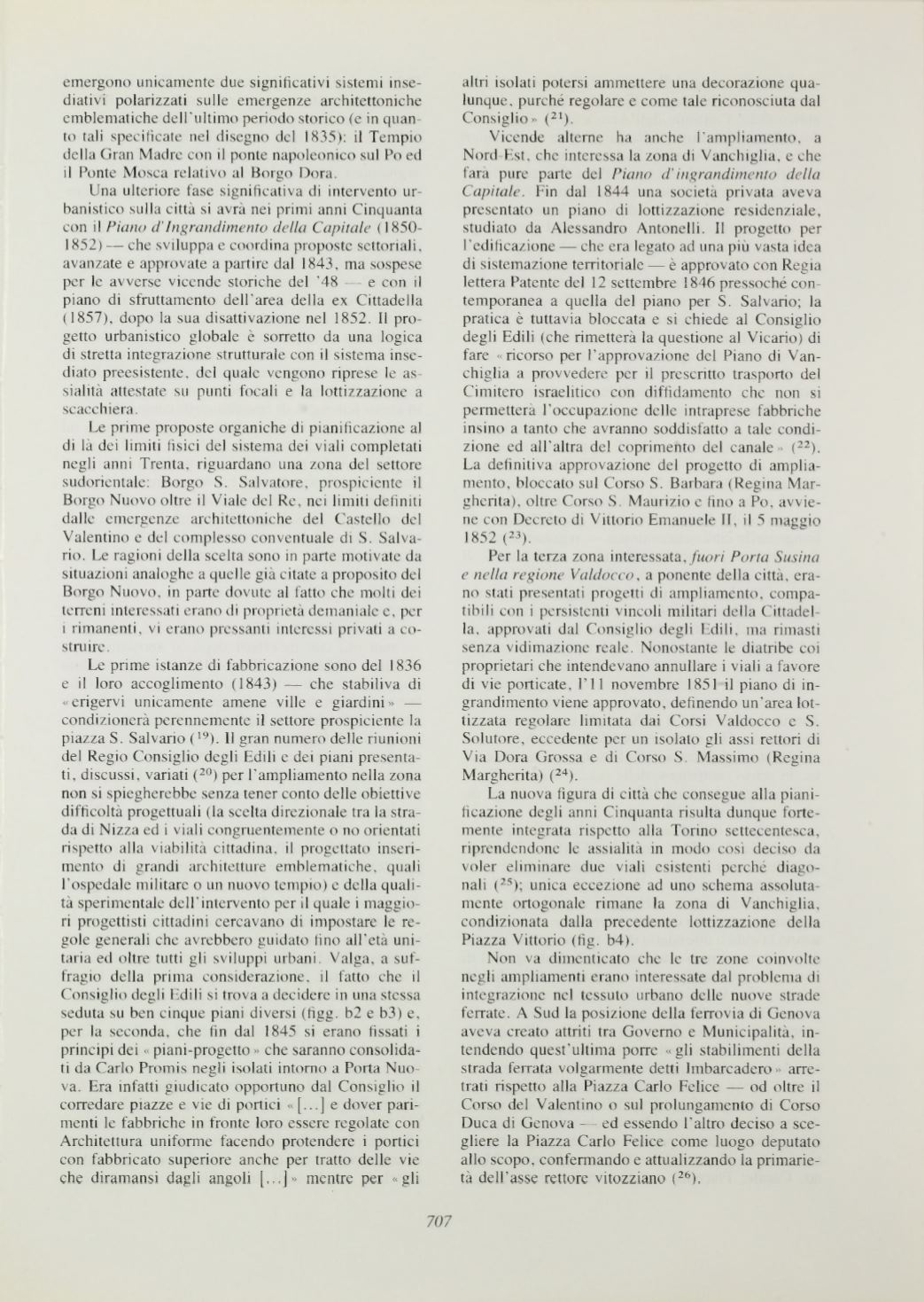
emergono unicamente due significativi sistemi inse-
diativi polarizzati sulle emergenze architettoniche
emblematiche dell'ultimo periodo storico (e in quan-
to tali specificate nel disegno del 1835): il Tempio
della Gran Madre con il ponte napoleonico sul Po ed
il Ponte Mosca relativo al Borgo Dora.
Una ulteriore fase significativa di intervento ur-
banistico sulla città si avrà nei primi anni Cinquanta
con il
Piano d'Ingrandimento detta Capitate (1850-
1852) — che sviluppa e coordina proposte settoriali,
avanzate e approvate a partire dal 1843, ma sospese
per le avverse vicende storiche del '48 — e con il
piano di sfruttamento dell'area della ex Cittadella
(1857), dopo la sua disattivazione nel 1852. I1 pro-
getto urbanistico globale è sorretto da una logica
di stretta integrazione strutturale con il sistema inse-
diato preesistente, del quale vengono riprese le as-
sialità attestate su punti focali e la lottizzazione a
scacchiera.
Le prime proposte organiche di pianificazione al
di là dei limiti fisici del sistema dei viali completati
negli anni Trenta, riguardano una zona del settore
sudorientale: Borgo S. Salvatore, prospiciente il
Borgo Nuovo oltre il Viale del Re, nei limiti definiti
dalle emergenze architettoniche del Castello del
Valentino e del complesso conventuale di S. Salva-
no. Le ragioni della scelta sono in parte motivate da
situazioni analoghe a quelle già citate a proposito del
Borgo Nuovo, in parte dovute al fatto che molti dei
terreni interessati erano di proprietà demaniale e, per
i rimanenti, vi erano pressanti interessi privati a co-
struire.
Le prime istanze di fabbricazione sono del 1836
e il loro accoglimento (1843) — che stabiliva di
erigervi unicamente amene ville e giardini »
condizionerà perennemente il settore prospiciente la
piazza S. Salvano (
19
). Il gran numero delle riunioni
del Regio Consiglio degli Edili e dei piani presenta-
ti, discussi, variati (
20
) per l'ampliamento nella zona
non si spiegherebbe senza tener conto delle obiettive
difficoltà progettuali (la scelta direzionale tra la stra-
da di Nizza ed i viali congruentemente o no orientati
rispetto alla viabilità cittadina, il progettato inseri-
mento di grandi architetture emblematiche, quali
l'ospedale militare o un nuovo tempio) e della quali-
tà sperimentale dell'intervento per il quale i maggio-
ri progettisti cittadini cercavano di impostare le re-
gole generali che avrebbero guidato fino all'età uni-
taria ed oltre tutti gli sviluppi urbani. Valga, a suf-
fragio della prima considerazione, il fatto che il
Consiglio degli Edili si trova a decidere in una stessa
seduta su ben cinque piani diversi (figg. b2 e b3) e,
per la seconda, che fin dal 1845 si erano fissati i
principi dei « piani-progetto » che saranno consolida-
ti da Carlo Promis negli isolati intorno a Porta Nuo-
va. Era infatti giudicato opportuno dal Consiglio il
corredare piazze e vie di portici .1...] e dover pari-
menti le fabbriche in fronte loro essere regolate con
Architettura uniforme facendo protendere i portici
con fabbricato superiore anche per tratto delle vie
che diramansi dagli angoli [... ] » mentre per « gli
altri isolati potersi ammettere una decorazione qua-
lunque, purché regolare e come tale riconosciuta dal
Consiglio» (21).
Vicende alterne ha anche l'ampliamento, a
Nord-Est, che interessa la zona di Vanchiglia, e che
farà pure parte del
Piano d'ingrandimento detta
Capitale.
Fin dal 1844 una società privata aveva
presentato un piano di lottizzazione residenziale,
studiato da Alessandro Antonelli. Il progetto per
l'edificazione che era legato ad una più vasta idea
di sistemazione territoriale è approvato con Regia
lettera Patente del 12 settembre 1846 pressoché con-
temporanea a quella del piano per S. Salvario; la
pratica è tuttavia bloccata e si chiede al Consiglio
degli Edili (che rimetterà la questione al Vicario) di
fare «ricorso per l'approvazione del Piano di Van-
chiglia a provvedere per il prescritto trasporto del
Cimitero israelitico con diffidamento che non si
permetterà l'occupazione delle intraprese fabbriche
insino a tanto che avranno soddisfatto a tale condi-
zione ed all'altra del coprimento del canale» (22).
La definitiva approvazione del progetto di amplia-
mento, bloccato sul Corso S. Barbara (Regina Mar-
gherita), oltre Corso S. Maurizio e fino a Po, avvie-
ne con Decreto di Vittorio Emanuele II, il 5 maggio
1852 (23).
Per la terza zona interessata,
fuori Porta Susina
e netta regione Vatdocco,
a ponente della città, era-
no stati presentati progetti di ampliamento, compa-
tibili con i persistenti vincoli militari della Cittadel-
la, approvati dal Consiglio degli Edili, ma rimasti
senza vidimazione reale. Nonostante le diat
ri
be coi
proprietari che intendevano annullare i viali a favore
di vie porticate, l' 11 novembre 1851 il piano di in-
grandimento viene approvato, definendo un'area lot-
tizzata regolare limitata dai Corsi Valdocco e S.
Solutore, eccedente per un isolato gli assi rettori di
Via Dora Grossa e di Corso S. Massimo (Regina
Margherita) (24).
La nuova figura di città che consegue alla piani-
ficazione degli anni Cinquanta risulta dunque forte-
mente integrata rispetto alla Torino settecentesca,
riprendendone le assialità in modo così deciso da
voler eliminare due viali esistenti perché diago-
nali (
25
); unica eccezione ad uno schema assoluta-
mente ortogonale rimane la zona di Vanchiglia,
condizionata dalla precedente lottizzazione della
Piazza Vittorio (fig. b4).
Non va dimenticato che le tre zone coinvolte
negli ampliamenti erano interessate dal problema di
integrazione nel tessuto urbano delle nuove strade
ferrate. A Sud la posizione della ferrovia di Genova
aveva creato attriti tra Governo e Municipalità, in-
tendendo quest'ultima porre « gli stabilimenti della
strada ferrata volgarmente detti Imbarcadero » arre-
trati rispetto alla Piazza Carlo Felice — od oltre il
Corso del Valentino o sul prolungamento di Corso
Duca di Genova — ed essendo l'altro deciso a sce-
gliere la Piazza Carlo Felice come luogo deputato
allo scopo, confermando e attualizzando la primarie-
tà dell'asse rettore vitozziano (26).
707


















