
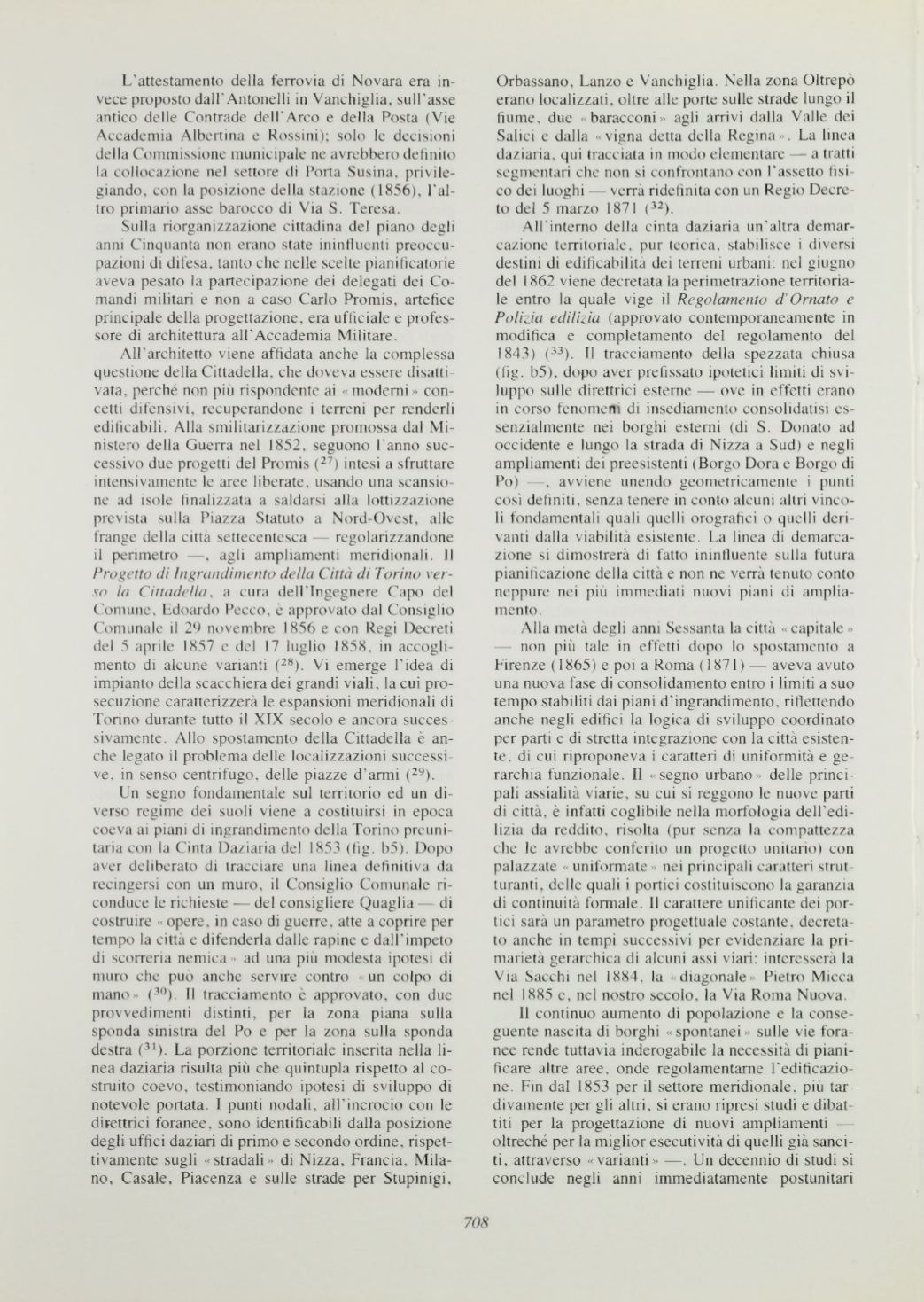
L'attestamento della ferrovia di Novara era in-
vece proposto dall'Antonelli in Vanchiglia, sull'asse
antico delle Contrade dell'Arco e della Posta (Vie
Accademia Albertina e Rossini); solo le decisioni
della Commissione municipale ne avrebbero definito
la collocazione nel settore di Porta Susina, privile-
giando, con la posizione della stazione (1856), l'al-
tro primario asse barocco di Via S. Teresa.
Sulla riorganizzazione cittadina del piano degli
anni Cinquanta non erano state ininfluenti preoccu-
pazioni di difesa, tanto che nelle scelte pianificatorie
aveva pesato la partecipazione dei delegati dei Co-
mandi militari e non a caso Carlo Promis, artefice
principale della progettazione, era ufficiale e profes-
sore di architettura all'Accademia Militare.
All'architetto viene affidata anche la complessa
questione della Cittadella, che doveva essere disatti-
vata, perché non più rispondente ai «moderni» con-
cetti difensivi, recuperandone i terreni per renderli
edificabili. Alla smilitarizzazione promossa dal Mi-
nistero della Guerra nel 1852, seguono l'anno suc-
cessivo due progetti del Promis (
27
) intesi a sfruttare
intensivamente le aree liberate, usando una scansio-
ne ad isole finalizzata a saldarsi alla lottizzazione
prevista sulla Piazza Statuto a Nord-Ovest, alle
frange della città settecentesca regolarizzandone
il perimetro , agli ampliamenti meridionali. Il
Progetto di Ingrandimento della Città di Torino ver-
so ta Cittadelta,
a cura dell'Ingegnere Capo del
Comune, Edoardo Pecco, è approvato dal Consiglio
Comunale il 29 novembre 1856 e con Regi Decreti
del 5 aprile 1857 e del 17 luglio 1858, in accogli-
mento di alcune varianti (
28
). Vi emerge l'idea di
impianto della scacchiera dei grandi viali, la cui pro-
secuzione caratterizzerà le espansioni meridionali di
Torino durante tutto il XIX secolo e ancora succes-
sivamente. Allo spostamento della Cittadella è an-
che legato il problema delle localizzazioni successi-
ve, in senso centrifugo, delle piazze d'anni (29).
Un segno fondamentale sul territorio ed un di-
verso regime dei suoli viene a costituirsi in epoca
coeva ai piani di ingrandimento della Torino preuni-
ta
ri
a con la Cinta Daziaria del 1853 (fig. b5). Dopo
aver deliberato di tracciare una linea definitiva da
recingersi con un muro, il Consiglio Comunale ri-
conduce le richieste — del consigliere Quaglia di
costruire « opere, in caso di guerre, atte a coprire per
tempo la città e difenderla dalle rapine e dall'impeto
di scorreria nemica » ad una più modesta ipotesi di
muro che può anche servire contro « un colpo di
mano» (
30
). Il tracciamento è approvato, con due
provvedimenti distinti, per la zona piana sulla
sponda sinistra del Po e per la zona sulla sponda
destra (
31
). La porzione territoriale inserita nella li-
nea daziaria risulta più che quintupla rispetto al co-
struito coevo, testimoniando ipotesi di sviluppo di
notevole portata. I punti nodali, all'incrocio con le
direttrici foranee, sono identificabili dalla posizione
degli uffici daziari di primo e secondo ordine, rispet-
tivamente sugli « stradali » di Nizza, Francia, Mila-
no, Casale, Piacenza e sulle strade per Stupinigi,
Orbassano, Lanzo e Vanchiglia. Nella zona Oltrepò
erano localizzati, oltre alle porte sulle strade lungo il
fiume, due «baracconi» agli arrivi dalla Valle dei
Salici e dalla « vigna detta della Regina >>. La linea
daziaria, qui tracciata in modo elementare — a tratti
segmentari che non si confrontano con l'assetto fisi-
co dei luoghi verrà ridefinita con un Regio Decre-
to del 5 marzo 1871 (
32
).
All'interno della cinta daziaria un'altra demar-
cazione territoriale, pur teorica, stabilisce i diversi
destini di edificabilità dei terreni urbani: nel giugno
del 1862 viene decretata la perimetrazione territoria-
le entro la quale vige il
Regotamento d'Ornato e
Potizia edilizia
(approvato contemporaneamente in
modifica e completamento del regolamento del
1843) (
33
). Il tracciamento della spezzata chiusa
(fig. b5), dopo aver prefissato ipotetici limiti di svi-
luppo sulle direttrici esterne — ove in effetti erano
in corso fenomeni di insediamento consolidatisi es-
senzialmente nei borghi esterni (di S. Donato ad
occidente e lungo la strada di Nizza a Sud) e negli
ampliamenti dei preesistenti (Borgo Dora e Borgo di
Po) —, avviene unendo geometricamente i punti
così definiti, senza tenere in conto alcuni altri vinco-
li fondamentali quali quelli orografici o quelli deri-
vanti dalla viabilità esistente. La linea di demarca-
zione si dimostrerà di fatto ininfluente sulla futura
pianificazione della città e non ne verrà tenuto conto
neppure nei più immediati nuovi piani di amplia-
mento.
Alla metà degli anni Sessanta la città « capitale »
non più tale in effetti dopo lo spostamento a
Firenze (1865) e poi a Roma (1871) — aveva avuto
una nuova fase di consolidamento entro i limiti a suo
tempo stabiliti dai piani d'ingrandimento, riflettendo
anche negli edifici la logica di sviluppo coordinato
per parti e di stretta integrazione con la città esisten-
te, di cui riproponeva i caratteri di uniformità e ge-
rarchia funzionale. Il «segno urbano» delle princi-
pali assialità viarie, su cui si reggono le nuove parti
di città, è infatti coglibile nella morfologia dell'edi-
lizia da reddito, risolta (pur senza la compattezza
che le avrebbe conferito un progetto unitario) con
palazzate «uniformate» nei principali caratteri strut-
turanti, delle quali i portici costituiscono la garanzia
di continuità formale. Il carattere unificante dei por-
tici sarà un parametro progettuale costante, decreta-
to anche in tempi successivi per evidenziare la pri-
marietà gerarchica di alcuni assi viari: interesserà la
Via Sacchi nel 1884, la «diagonale» Pietro Micca
nel 1885 e, nel nostro secolo, la Via Roma Nuova.
Il continuo aumento di popolazione e la conse-
guente nascita di borghi « spontanei » sulle vie fora-
nee rende tuttavia inderogabile la necessità di piani-
ficare altre aree, onde regolamentarne l'edificazio-
ne. Fin dal 1853 per il settore meridionale, più tar-
divamente per gli altri, si erano ripresi studi e dibat-
titi per la progettazione di nuovi ampliamenti
—
oltreché per la miglior esecutività di quelli già sanci-
ti, attraverso « varianti » —. Un decennio di studi si
conclude negli anni immediatamente postunitari
708


















