
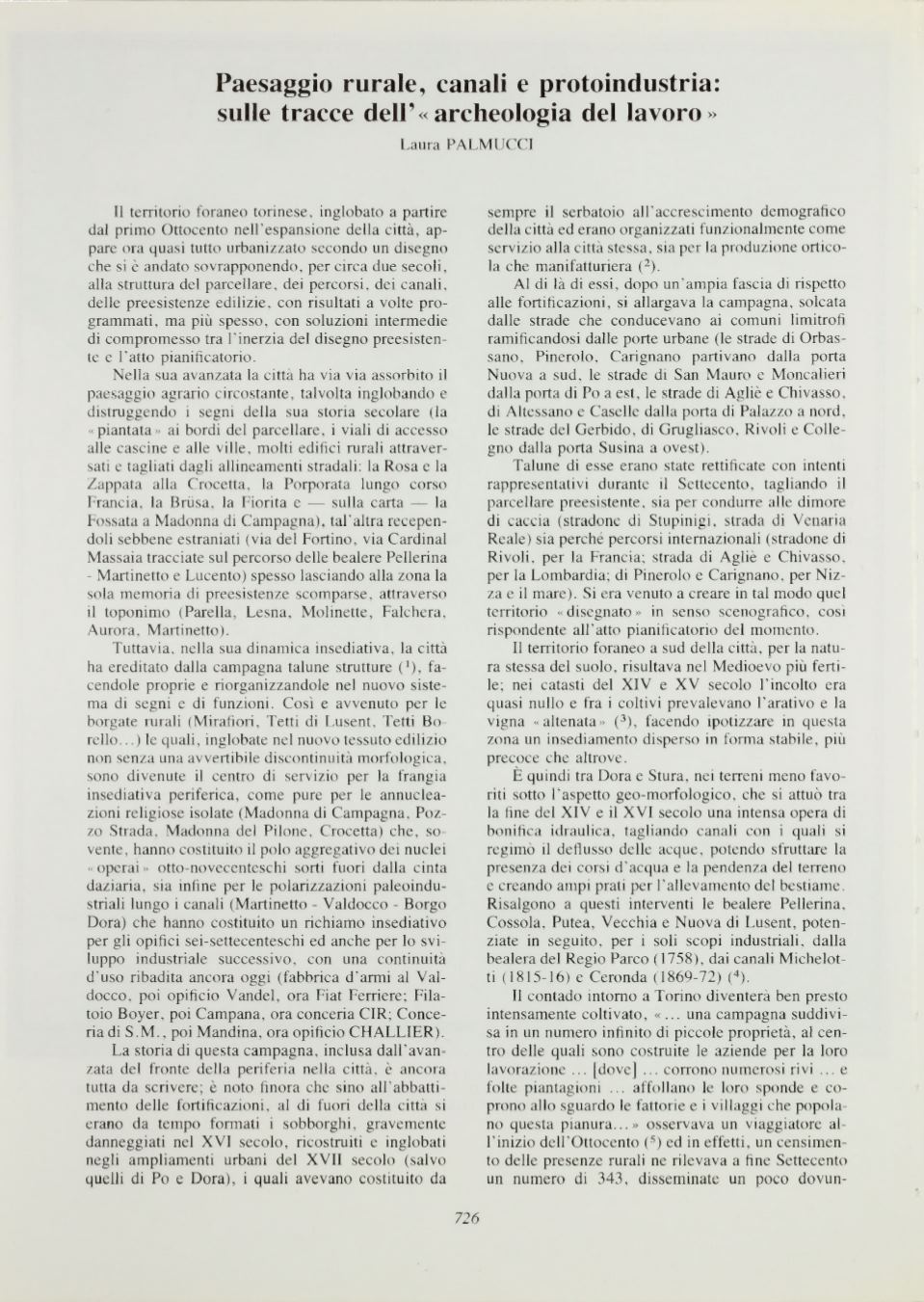
Paesaggio rurale, canali e protoindustria:
sulle tracce dell' « archeologia del lavoro »
Laura PALMUCCI
Il territorio foraneo torinese, inglobato a partire
dal primo Ottocento nell'espansione della città, ap-
pare ora quasi tutto urbanizzato secondo un disegno
che si è andato sovrapponendo, per circa due secoli,
alla struttura del parcellare, dei percorsi, dei canali,
delle preesistenze edilizie, con risultati a volte pro-
grammati, ma più spesso, con soluzioni intermedie
di compromesso tra l'inerzia del disegno preesisten-
te e l'atto pianificatorio.
Nella sua avanzata la città ha via via assorbito il
paesaggio agrario circostante, talvolta inglobando e
distruggendo i segni della sua storia secolare (la
«piantata» ai bordi del parcellare, i viali di accesso
alle cascine e alle ville, molti edifici rurali attraver-
sati e tagliati dagli allineamenti stradali: la Rosa e la
Zappata alla Crocetta, la Porporata lungo corso
Francia, la Brnsa, la Fiorita e — sulla carta la
Fossata a Madonna di Campagna), talaltra recepen-
doli sebbene estraniati (via del Fo
rt
ino, via Cardinal
Massaia tracciate sul percorso delle bealere Pellerina
- Martinetto e Lucento) spesso lasciando alla zona la
sola memoria di preesistenze scomparse, attraverso
il toponimo (Parella, Lesna, Molinette, Falchera,
Aurora, Martinetto).
Tuttavia, nella sua dinamica insediativa, la città
ha ereditato dalla campagna talune strutture (
1
), fa-
cendole proprie e riorganizzandole nel nuovo siste-
ma di segni e di funzioni. Così
e
avvenuto per le
borgate rurali (Mirafiori, Tetti di Lusent, Tetti Bo-
rello...) le quali, inglobate nel nuovo tessuto edilizio
non senza una avvertibile discontinuità morfologica,
sono divenute il centro di servizio per la frangia
insediativa periferica, come pure per le annuclea-
zioni religiose isolate (Madonna di Campagna, Poz-
zo Strada, Madonna del Pilone, Crocetta) che, so-
vente, hanno costituito il polo aggregativo dei nuclei
« operai » otto-novecenteschi sorti fuori dalla cinta
daziaria, sia infine per le polarizzazioni paleoindu-
striali lungo i canali (Martinetto - Valdocco - Borgo
Dora) che hanno costituito un richiamo insediativo
per gli opifici sei-settecenteschi ed anche per lo svi-
luppo industriale successivo, con una continuità
d'uso ribadita ancora oggi (fabbrica d'armi al Val-
docco, poi opificio Vandel, ora Fiat Ferriere; Fila-
toio Boyer, poi Campana, ora conceria CIR; Conce-
ria di S.M., poi Mandina, ora opificio CHALLIER).
La storia di questa campagna, inclusa dall'avan-
zata del fronte della periferia nella città, è ancora
tutta da scrivere; è noto finora che sino all'abbatti-
mento delle fortificazioni, al di fuori della città si
erano da tempo formati i sobborghi, gravemente
danneggiati nel XVI secolo, ricostruiti e inglobati
negli ampliamenti urbani del XVII secolo (salvo
quelli di Po e Dora), i quali avevano costituito da
sempre
il
serbatoio all'accrescimento demografico
della città ed erano organizzati funzionalmente come
servizio alla città stessa, sia per la produzione ortico-
la che manifatturiera (
2
).
Al di là di essi, dopo un'ampia fascia di rispetto
alle fortificazioni, si allargava la campagna, solcata
dalle strade che conducevano ai comuni limitrofi
ramificandosi dalle porte urbane (le strade di Orbas-
sano, Pinerolo, Carignano partivano dalla porta
Nuova a sud, le strade di San Mauro e Moncalieri
dalla porta di Po a est, le strade di Agliè e Chivasso,
di Altessano e Caselle dalla porta di Palazzo a nord,
le strade del Gerbido, di Grugliasco, Rivoli e Colle-
gno dalla porta Susina a ovest).
Talune di esse erano state rettificate con intenti
rappresentativi durante il Settecento, tagliando il
parcellare preesistente, sia per condurre alle dimore
di caccia (stradone di Stupinigi, strada di Venaria
Reale) sia perché percorsi internazionali (stradone di
Rivoli, per la Francia; strada di Agliè e Chivasso,
per la Lombardia; di Pinerolo e Carignano, per Niz-
za e il mare). Si era venuto a creare in tal modo quel
territorio « disegnato » in senso scenografico, così
rispondente all'atto pianificatorio del momento.
Il territorio foraneo a sud della città, per la natu-
ra stessa del suolo, risultava nel Medioevo più ferti-
le; nei catasti del XIV e XV secolo l'incolto era
quasi nullo e fra i coltivi prevalevano l'arativo e la
vigna « altenata » (
3
), facendo ipotizzare in questa
zona un insediamento disperso in forma stabile, più
precoce che altrove.
È quindi tra Dora e Stura, nei terreni meno favo-
riti sotto l'aspetto geo-morfologico, che si attuò tra
la fine del XIV e il XVI secolo una intensa opera di
bonifica idraulica, tagliando canali con i quali si
regimò il deflusso delle acque, potendo sfruttare la
presenza dei corsi d'acqua e la pendenza del terreno
e creando ampi prati per l'allevamento del bestiame.
Risalgono a questi interventi le bealere Pellerina,
Cossola, Putea, Vecchia e Nuova di Lusent, poten-
ziate in seguito, per i soli scopi industriali, dalla
bealera del Regio Parco (1758), dai canali Michelot-
ti
(1815-16) e Ceronda (1869-72) (
4
).
Il contado intorno a Torino diventerà ben presto
intensamente coltivato, « ... una campagna suddivi-
sa in un numero infinito di piccole proprietà, al cen-
tro delle quali sono costruite le aziende per la loro
lavorazione ... [dove] ... corrono numerosi rivi ... e
folte piantagioni ... affollano le loro sponde e co-
prono allo sguardo le fattorie e i villaggi che popola-
no questa pianura.... osservava un viaggiatore al-
l'inizio dell'Ottocento (
5
) ed in effetti, un censimen-
to delle presenze rurali ne rilevava a fine Settecento
un numero di 343, disseminate un poco dovun-
726


















