
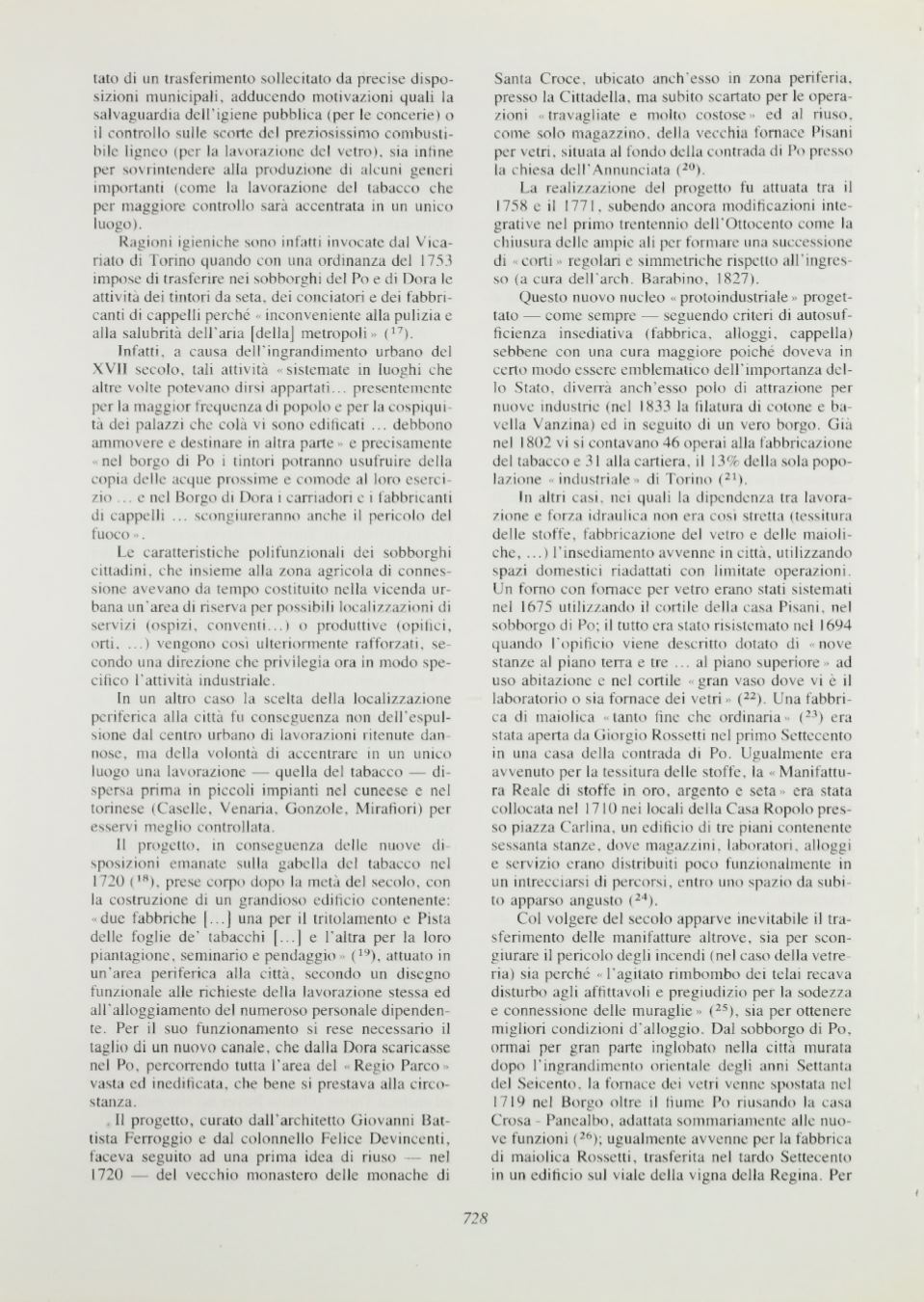
tato di un trasferimento sollecitato da precise dispo-
sizioni municipali, adducendo motivazioni quali la
salvaguardia dell'igiene pubblica (per le concerie) o
il controllo sulle scorte del preziosissimo combusti-
bile ligneo (per la lavorazione del vetro), sia infine
per sovrintendere alla produzione di alcuni generi
importanti (come la lavorazione del tabacco che
per maggiore controllo sarà accentrata in un unico
luogo).
Ragioni igieniche sono infatti invocate dal Vica-
riato di Torino quando con una ordinanza del 1753
impose di trasferire nei sobborghi del Po e di Dora le
attività dei tintori da seta, dei conciatori e dei fabbri-
canti di cappelli perché « inconveniente alla pulizia e
alla salubrità dell'aria [della] metropoli» (
17
).
Infatti, a causa dell'ingrandimento urbano del
XVII secolo, tali attività «sistemate in luoghi che
altre volte potevano dirsi appartati... presentemente
per la maggior frequenza di popolo e per la cospiqui-
tà dei palazzi che colà vi sono edificati ... debbono
ammovere e destinare in altra parte » e precisamente
« nel borgo di Po i tintori potranno usufruire della
copia delle acque prossime e comode al loro eserci-
zio ... e nel Borgo di Dora i carriadori e i fabbricanti
di cappelli ... scongiureranno anche il pericolo del
fuoco».
Le caratteristiche polifunzionali dei sobborghi
cittadini, che insieme alla zona agricola di connes-
sione avevano da tempo costituito nella vicenda ur-
bana un'area di riserva per possibili localizzazioni di
servizi (ospizi, conventi...) o produttive (opifici,
orti, ...) vengono così ulteriormente rafforzati, se-
condo una direzione che privilegia ora in modo spe-
cifico l'attività industriale.
In un altro caso la scelta della localizzazione
periferica alla città fu conseguenza non dell'espul-
sione dal centro urbano di lavorazioni ritenute dan-
nose, ma della volontà di accentrare in un unico
luogo una lavorazione — quella del tabacco di-
spersa prima in piccoli impianti nel cuneese e nel
torinese (Caselle, Venaria, Gonzole, Mirafiori) per
esservi meglio controllata.
Il progetto, in conseguenza delle nuove di-
sposizioni emanate sulla gabella del tabacco nel
1720 (i
8
), prese corpo dopo la metà del secolo, con
la costruzione di un grandioso edificio contenente:
«due fabbriche [...] una per il tritolamento e Pista
delle foglie de' tabacchi [...] e l'altra per la loro
piantagione, seminario e pendaggio» (
19
), attuato in
un'area periferica alla città, secondo un disegno
funzionale alle richieste della lavorazione stessa ed
all'alloggiamento del numeroso personale dipenden-
te. Per il suo funzionamento si rese necessario il
taglio di un nuovo canale, che dalla Dora scaricasse
nel Po, percorrendo tutta l'area del « Regio Parco »
vasta ed inedificata, che bene si prestava alla circo-
stanza.
. Il progetto, curato dall'architetto Giovanni Bat-
tista Ferroggio e dal colonnello Felice Devincenti,
faceva seguito ad una prima idea di riuso nel
1720 del vecchio monastero delle monache di
Santa Croce, ubicato anch'esso in zona periferia,
presso la Cittadella, ma subito scartato per le opera-
zioni «travagliate e molto costose» ed al riuso,
come solo magazzino, della vecchia fornace Pisani
per vetri, situata al fondo della contrada di Po presso
la chiesa dell'Annunciata (
20
).
La realizzazione del progetto fu attuata tra il
1758 e il 1771, subendo ancora modificazioni inte-
grative nel primo trentennio dell'Ottocento come la
chiusura delle ampie ali per formare una successione
di «corti» regolari e simmetriche rispetto all'ingres-
so (a cura dell'arch. Barabino, 1827).
Questo nuovo nucleo « protoindustriale » proget-
tato come sempre — seguendo criteri di autosuf-
ficienza insediativa (fabbrica, alloggi, cappella)
sebbene con una cura maggiore poiché doveva in
certo modo essere emblematico dell'importanza del-
lo Stato, diverrà anch'esso polo di attrazione per
nuove industrie (nel 1833 la filatura di cotone e ba-
vella Vanzina) ed in seguito di un vero borgo. Già
nel 1802 vi si contavano 46 operai alla fabbricazione
del tabacco e 31 alla cartiera, il 13% della sola popo-
lazione «industriale» di Torino (
21
).
In altri casi, nei quali la dipendenza tra lavora-
zione e forza idraulica non era così stretta (tessitura
delle stoffe, fabbricazione del vetro e delle maioli-
che, ...) l'insediamento avvenne in città, utilizzando
spazi domestici riadattati con limitate operazioni.
Un forno con fornace per vetro erano stati sistemati
nel 1675 utilizzando il cortile della casa Pisani, nel
sobborgo di Po; il tutto era stato risistemato nel 1694
quando l'opificio viene descritto dotato di «nove
stanze al piano terra e tre ... al piano superiore » ad
uso abitazione e nel cortile « gran vaso dove vi è il
laboratorio o sia fornace dei vetri» (
22
). Una fabbri-
ca di maiolica «tanto fine che ordinaria » (
23
) era
stata aperta da Giorgio Rossetti nel primo Settecento
in una casa della contrada di Po. Ugualmente era
avvenuto per la tessitura delle stoffe, la « Manifattu-
ra Reale di stoffe in oro, argento e seta» era stata
collocata nel 1710 nei locali della Casa Ropolo pres-
so piazza Carlina, un edificio di tre piani contenente
sessanta stanze, dove magazzini, laboratori, alloggi
e servizio erano distribuiti poco funzionalmente in
un intrecciarsi di percorsi, entro uno spazio da subi-
to apparso angusto (24).
Col volgere del secolo apparve inevitabile il tra-
sferimento delle manifatture altrove, sia per scon-
giurare il pericolo degli incendi (nel caso della vetre-
ria) sia perché « l'agitato rimbombo dei telai recava
disturbo agli affittavoli e pregiudizio per la sodezza
e connessione delle muraglie » (
25
), sia per ottenere
migliori condizioni d'alloggio. Dal sobborgo di Po,
ormai per gran parte inglobato nella città murata
dopo l'ingrandimento orientale degli anni Settanta
del Seicento, la fornace dei vetri venne spostata nel
1719 nel Borgo oltre il fiume Po riusando la casa
Crosa - Panealbo, adattata sommariamente alle nuo-
ve funzioni (
26
); ugualmente avvenne per la fabbrica
di maiolica Rossetti, trasferita nel tardo Settecento
in un edificio sul viale della vigna della Regina. Per
728


















