
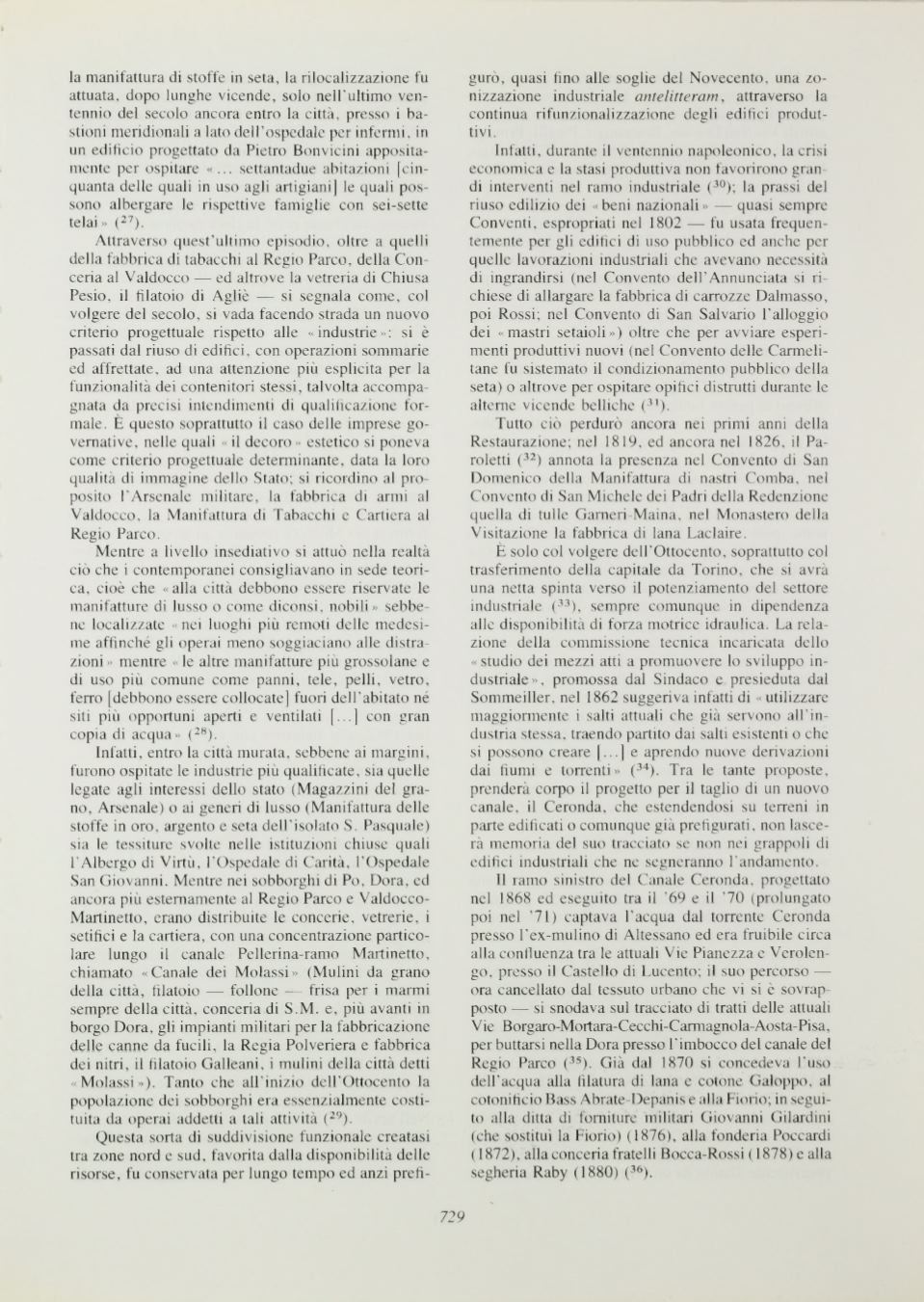
la manifattura di stoffe in seta, la rilocalizzazione fu
attuata, dopo lunghe vicende, solo nell'ultimo ven-
tennio del secolo ancora entro la città, presso i ba-
stioni meridionali a lato dell'ospedale per infermi, in
un edificio progettato da Pietro Bonvicini apposita-
mente per ospitare « ... settantadue abitazioni [cin-
quanta delle quali in uso agli artigiani] le quali pos-
sono albergare le rispettive famiglie con sei-sette
telai» (
27
).
Attraverso quest'ultimo episodio, oltre a quelli
della fabbrica di tabacchi al Regio Parco, della Con-
ceria al Valdocco ed altrove la vetreria di Chiusa
Pesio, il filatoio di Agliè — si segnala come, col
volgere del secolo, si vada facendo strada un nuovo
criterio progettuale rispetto alle «industrie»: si è
passati dal riuso di edifici, con operazioni sommarie
ed affrettate, ad una attenzione più esplicita per la
funzionalità dei contenitori stessi, talvolta accompa-
gnata da precisi intendimenti di qualificazione for-
male. È questo soprattutto il caso delle imprese go-
vernative, nelle quali « il decoro » estetico si poneva
come criterio progettuale determinante, data la loro
qualità di immagine dello Stato; si ricordino al pro-
posito l'Arsenale militare, la fabbrica di armi al
Valdocco, la Manifattura di Tabacchi e Cartiera al
Regio Parco.
Mentre a livello insediativo si attuò nella realtà
ciò che i contemporanei consigliavano in sede teori-
ca, cioè che « alla città debbono essere riservate le
manifatture di lusso o come diconsi, nobili» sebbe-
ne localizzate «nei luoghi più remoti delle medesi-
me affinché gli operai meno soggiaciano alle distra-
zioni » mentre « le altre manifatture più grossolane e
di uso più comune come panni, tele, pelli, vetro,
ferro [debbono essere collocate] fuori dell'abitato né
siti più opportuni aperti e ventilati [...] con gran
copia di acqua» (
28
).
Infatti, entro la città murata, sebbene ai margini,
furono ospitate le industrie più qualificate, sia quelle
legate agli interessi dello stato (Magazzini del gra-
no, Arsenale) o ai generi di lusso (Manifattura delle
stoffe in oro, argento e seta dell'isolato S. Pasquale)
sia le tessiture svolte nelle istituzioni chiuse quali
l'Albergo di Virtù, l'Ospedale di Carità, l'Ospedale
San Giovanni. Mentre nei sobborghi di Po, Dora, ed
ancora più esternamente al Regio Parco e Valdocco-
Martinetto, erano distribuite le concerie, vetrerie, i
setifici e la cartiera, con una concentrazione partico-
lare lungo il canale Pellerina-ramo Martinetto,
chiamato «Canale dei Molassi » (Mulini da grano
della città, filatoio follone — frisa per i marmi
sempre della città, conceria di S.M. e, più avanti in
borgo Dora, gli impianti militari per la fabbricazione
delle canne da fucili, la Regia Polveriera e fabbrica
dei nitri, il filatoio Galleani, i mulini della città detti
«Molassi »). Tanto che all'inizio dell'Ottocento la
popolazione dei sobborghi era essenzialmente costi-
tuita da operai addetti a tali attività (
29
).
Questa sorta di suddivisione funzionale creatasi
tra zone nord e sud, favorita dalla disponibilità delle
risorse, fu conservata per lungo tempo ed anzi prefi-
gurò, quasi fino alle soglie del Novecento, una zo-
nizzazione industriale
antelitteram,
attraverso la
continua rifunzionalizzazione degli edifici produt-
tivi
Infatti, durante il ventennio napoleonico, la crisi
economica e la stasi produttiva non favorirono gran-
di interventi nel ramo industriale (
30
); la prassi del
riuso edilizio dei « beni nazionali » quasi sempre
Conventi, espropriati nel 1802 fu usata frequen-
temente per gli edifici di uso pubblico ed anche per
quelle lavorazioni industriali che avevano necessità
di ingrandirsi (nel Convento dell'Annunciata si ri-
chiese di allargare la fabbrica di carrozze Dalmasso,
poi Rossi; nel Convento di San Salvario l'alloggio
dei «mastri setaioli») oltre che per avviare esperi-
menti produttivi nuovi (nel Convento delle Carmeli-
tane fu sistemato il condizionamento pubblico della
seta) o altrove per ospitare opifici distrutti durante le
alterne vicende belliche (
31
).
Tutto ciò perdurò ancora nei primi anni della
Restaurazione; nel 1819, ed ancora nel 1826, il Pa-
roletti (
32
) annota la presenza nel Convento di San
Domenico della Manifattura di nastri Comba, nel
Convento di San Michele dei Padri della Redenzione
quella di tulle Garneri-Maina, nel Monastero della
Visitazione la fabbrica di lana Laclaire.
È solo col volgere dell'Ottocento, soprattutto col
trasferimento della capitale da Torino, che si avrà
una netta spinta verso il potenziamento del settore
industriale (
33
), sempre comunque in dipendenza
alle disponibilità di forza motrice idraulica. La rela-
zione della commissione tecnica incaricata dello
studio dei mezzi atti a promuovere lo sviluppo in-
dustriale », promossa dal Sindaco e presieduta dal
Sommeiller, nel 1862 suggeriva infatti di « utilizzare
maggiormente i salti attuali che già servono all'in-
dustria stessa, traendo partito dai salti esistenti o che
si possono creare [...] e aprendo nuove derivazioni
dai fiumi e torrenti» (
34
). Tra le tante proposte,
prenderà corpo il progetto per il taglio di un nuovo
canale, il Ceronda, che estendendosi su terreni in
parte edificati o comunque già prefigurati, non lasce-
rà memoria del suo tracciato se non nei grappoli di
edifici industriali che ne segneranno l'andamento.
Il ramo sinistro del Canale Ceronda, progettato
nel 1868 ed eseguito tra il '69 e il '70 (prolungato
poi nel '71) captava l'acqua dal torrente Ceronda
presso l'ex-mulino di Altessano ed era fruibile circa
alla confluenza tra le attuali Vie Pianezza e Verolen-
go, presso il Castello di Lucento; il suo percorso —
ora cancellato dal tessuto urbano che vi si è sovrap-
posto si snodava sul tracciato di tratti delle attuali
Vie Borgaro-Mortara-Cecchi-Carmagnola-Aosta-Pisa,
per buttarsi nella Dora presso l'imbocco del canale del
Regio Parco (
35
). Già dal 1870 si concedeva l'uso
dell'acqua alla filatura di lana e cotone Galoppo, al
cotonificio Bass Abrate-Depanis e alla Fiorio; in segui-
to alla ditta di forniture militari Giovanni Gilardini
(che sostituì la Fiorio) (1876), alla fonderia Poccardi
(1872), alla conceria fratelli Bocca-Rossi (1878) e alla
segheria Raby (1880) (36).
729


















