
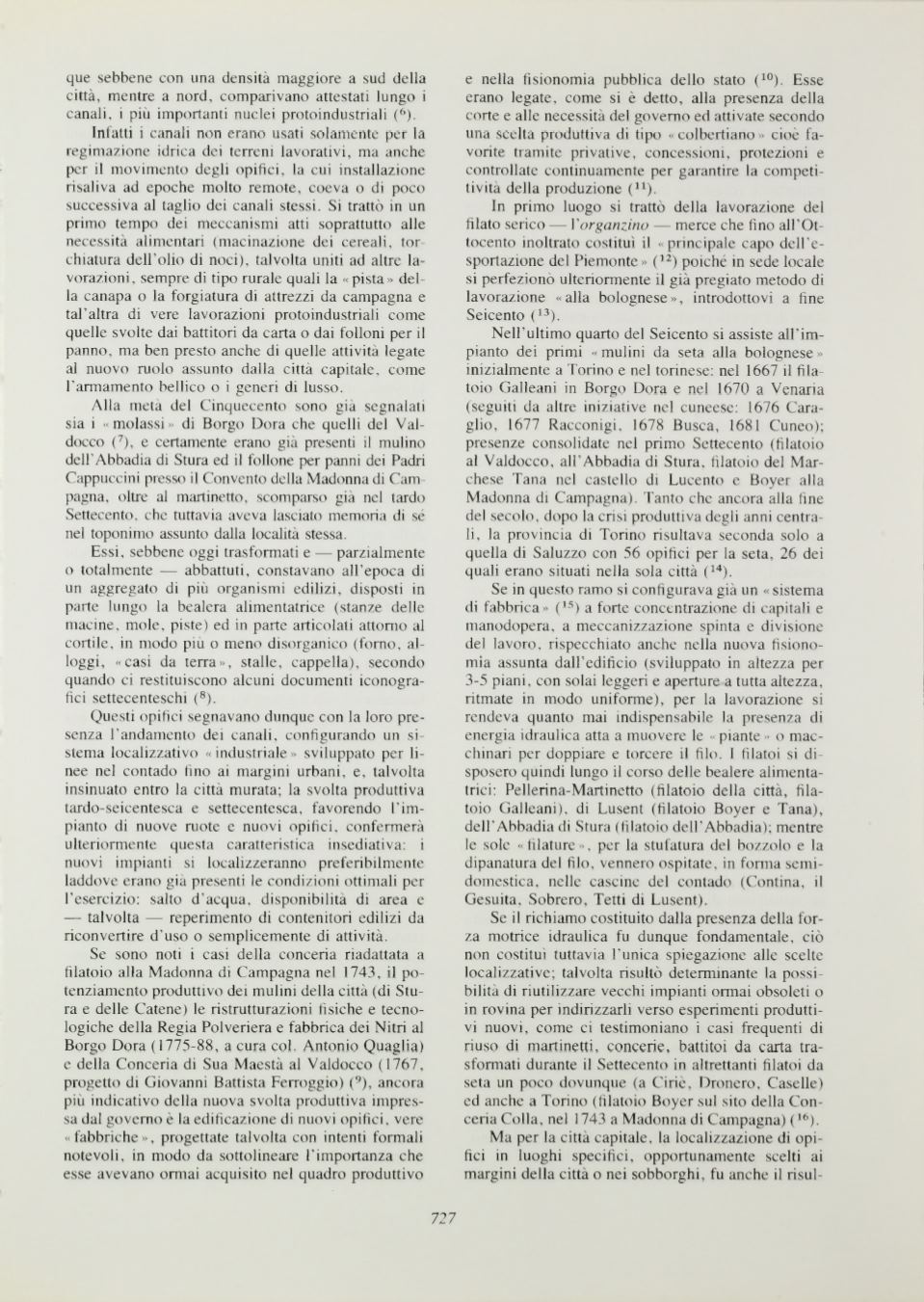
que sebbene con una densità maggiore a sud della
città, mentre a nord, comparivano attestati lungo i
canali, i più importanti nuclei protoindustriali (
6
).
Infatti i canali non erano usati solamente per la
regimazione idrica dei terreni lavorativi, ma anche
per il movimento degli opifici, la cui installazione
risaliva ad epoche molto remote, coeva o di poco
successiva al taglio dei canali stessi. Si trattò in un
primo tempo dei meccanismi atti soprattutto alle
necessità alimentari (macinazione dei cereali, tor-
chiatura dell'olio di noci), talvolta uniti ad altre la-
vorazioni, sempre di tipo rurale quali la «pista» del-
la canapa o la forgiatura di attrezzi da campagna e
tal'altra di vere lavorazioni protoindustriali come
quelle svolte dai battitori da carta o dai folloni per il
panno, ma ben presto anche di quelle attività legate
al nuovo ruolo assunto dalla città capitale, come
l'armamento bellico o i generi di lusso.
Alla metà del Cinquecento sono già segnalati
sia i « molassi » di Borgo Dora che quelli del Val-
docco (
7
), e certamente erano già presenti il mulino
dell'Abbadia di Stura ed il follone per panni dei Padri
Cappuccini presso il Convento della Madonna di Cam-
pagna, oltre al martinetto, scomparso già nel tardo
Settecento, che tuttavia aveva lasciato memoria di sé
nel toponimo assunto dalla località stessa.
Essi, sebbene oggi trasformati e parzialmente
o totalmente — abbattuti, constavano all'epoca di
un aggregato di più organismi edilizi, disposti in
parte lungo la bealera alimentatrice (stanze delle
macine, mole, piste) ed in parte articolati attorno al
cortile, in modo più o meno disorganico (forno, al-
loggi, «casi da terra», stalle, cappella), secondo
quando ci restituiscono alcuni documenti iconogra-
fici settecenteschi (
8
).
Questi opifici segnavano dunque con la loro pre-
senza l'andamento dei canali, configurando un si-
stema localizzativo « industriale » sviluppato per li-
nee nel contado fino ai margini urbani, e, talvolta
insinuato entro la città murata; la svolta produttiva
tardo-seicentesca e settecentesca, favorendo l'im-
pianto di nuove ruote e nuovi opifici, confermerà
ulteriormente questa caratteristica insediativa: i
nuovi impianti si localizzeranno preferibilmente
laddove erano già presenti le condizioni ottimali per
l'esercizio: salto d'acqua, disponibilità di area e
— talvolta reperimento di contenitori edilizi da
riconvertire d'uso o semplicemente di attività.
Se sono noti i casi della conceria riadattata a
filatoio alla Madonna di Campagna nel 1743, il po-
tenziamento produttivo dei mulini della città (di Stu-
ra e delle Catene) le ristrutturazioni fisiche e tecno-
logiche della Regia Polveriera e fabbrica dei Nitri al
Borgo Dora (1775-88, a cura col. Antonio Quaglia)
e della Conceria di Sua Maestà al Valdocco (1767,
progetto di Giovanni Battista Ferroggio) (
9
), ancora
più indicativo della nuova svolta produttiva impres-
sa dal governo è la edificazione di nuovi opifici, vere
« fabbriche » , progettate talvolta con intenti formali
notevoli, in modo da sottolineare l'importanza che
esse avevano ormai acquisito nel quadro produttivo
e nella fisionomia pubblica dello stato (
10
). Esse
erano legate, come si
è
detto, alla presenza della
corte e alle necessità del governo ed attivate secondo
una scelta produttiva di tipo « colbertiano » cioè fa-
vorite tramite privative, concessioni, protezioni e
controllate continuamente per garantire la competi-
tività della produzione (
11
).
In primo luogo si trattò della lavorazione del
filato serico
l'organzino
merce che fino all'Ot-
tocento inoltrato costituì il «principale capo dell'e-
sportazione del Piemonte» (
12
)poiché in sede locale
si perfezionò ulteriormente il già pregiato metodo di
lavorazione « alla bolognese »
,
introdottovi a fine
Seicento (
13
)
Nell'ultimo quarto del Seicento si assiste all'im-
pianto dei primi « mulini da seta alla bolognese
inizialmente a Torino e nel torinese: nel 1667 il fila-
toio Galleani in Borgo Dora e nel 1670 a Venaria
(seguiti da altre iniziative nel cuneese: 1676 Cara-
glio, 1677 Racconigi, 1678 Busca, 1681 Cuneo);
presenze consolidate nel primo Settecento (filatoio
al Valdocco, all'Abbadia di Stura, filatoio del Mar-
chese Tana nel castello di Lucento e Boyer alla
Madonna di Campagna). Tanto che ancora alla fine
del secolo, dopo la crisi produttiva degli anni centra-
li, la provincia di Torino risultava seconda solo a
quella di Saluzzo con 56 opifici per la seta, 26 dei
quali erano situati nella sola città (
14
).
Se in questo ramo si configurava già un « sistema
di fabbrica»(
15
)a forte concentrazione di capitali e
manodopera, a meccanizzazione spinta e divisione
del lavoro, rispecchiato anche nella nuova fisiono-
mia assunta dall'edificio (sviluppato in altezza per
3-5 piani, con solai leggeri e aperture a tutta altezza,
ritmate in modo uniforme), per la lavorazione si
rendeva quanto mai indispensabile la presenza di
energia idraulica atta a muovere le « piante » o mac-
chinari per doppiare e torcere il filo. I filatoi si di-
sposero quindi lungo il corso delle bealere alimenta-
trici: Pellerina-Martinetto (filatoio della città, fila-
toio Galleani), di Lusent (filatoio Boyer e Tana),
dell'Abbadia di Stura (filatoio dell'Abbadia); mentre
le sole « filature » , per la stufatura del bozzolo e la
dipanatura del filo, vennero ospitate, in forma semi-
domestica, nelle cascine del contado (Contina, il
Gesuita, Sobrero, Tetti di Lusent).
Se il richiamo costituito dalla presenza della for-
za motrice idraulica fu dunque fondamentale, ciò
non costituì tuttavia l'unica spiegazione alle scelte
localizzative; talvolta risultò determinante la possi-
bilità di riutilizzare vecchi impianti ormai obsoleti o
in rovina per indirizzarli verso esperimenti produtti-
vi nuovi, come ci testimoniano i casi frequenti di
riuso di martinetti, concerie, battitoi da carta tra-
sformati durante il Settecento in altrettanti filatoi da
seta un poco dovunque (a Ciriè, Dronero, Caselle)
ed anche a Torino (filatoio Boyer sul sito della Con-
ceria Colla, nel 1743 a Madonna di Campagna) (
16
).
Ma per la città capitale, la localizzazione di opi-
fici in luoghi specifici, opportunamente scelti ai
margini della città o nei sobborghi, fu anche il risul-
727


















