
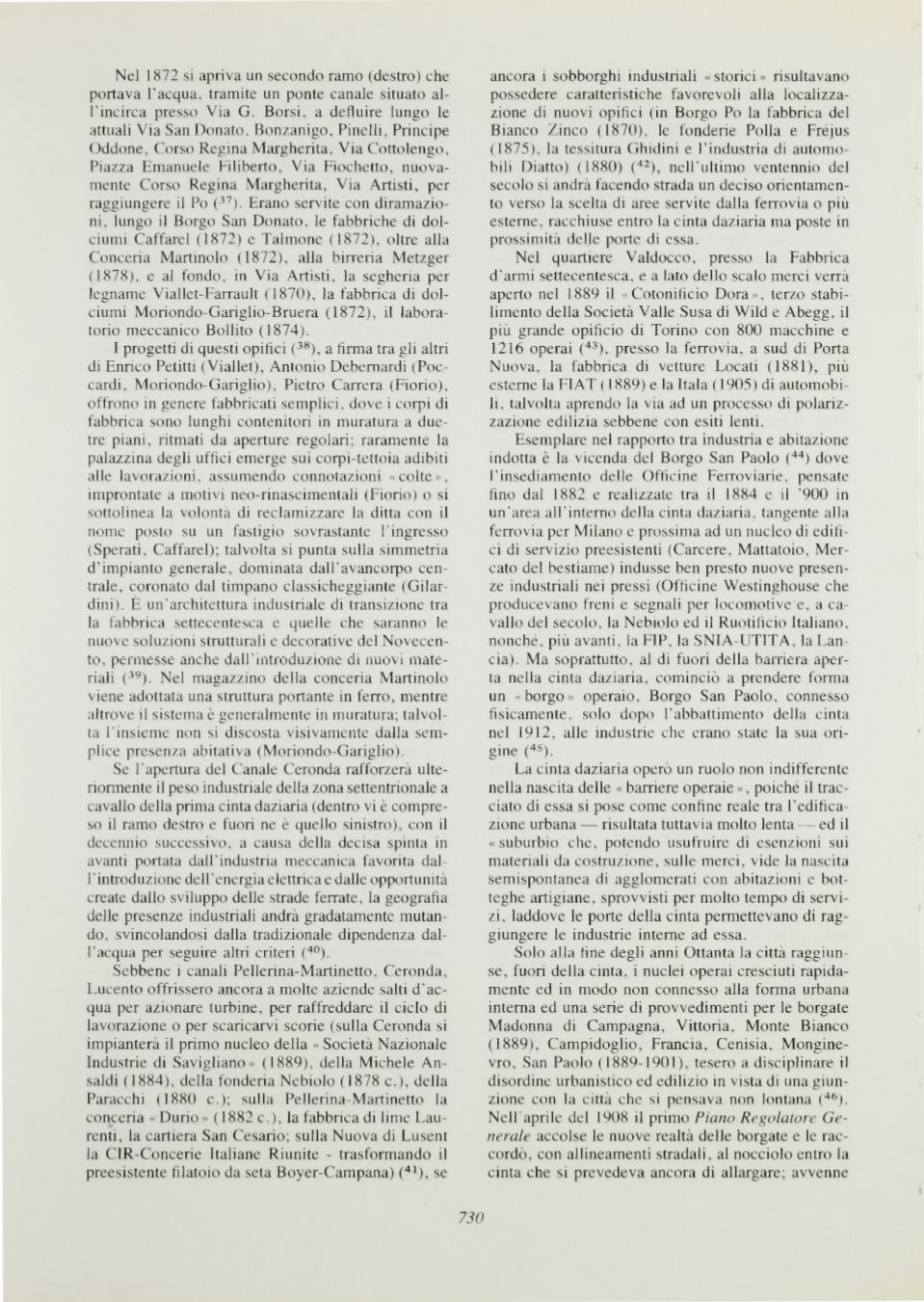
Nel 1872 si apriva un secondo ramo (destro) che
portava l'acqua, tramite un ponte canale situato al-
l'incirca presso Via G. Borsi, a defluire lungo le
attuali Via San Donato, Bonzanigo, Pinelli, Principe
Oddone, Corso Regina Margherita, Via Cottolengo,
Piazza Emanuele Filiberto, Via Fiochetto, nuova-
mente Corso Regina Margherita, Via Artisti, per
raggiungere il Po (
37
). Erano servite con diramazio-
ni, lungo il Borgo San Donato, le fabbriche di dol-
ciumi Caffarel (1872) e Talmone (1872), oltre alla
Conceria Martinolo (1872), alla birreria Metzger
(1878), e al fondo, in Via Artisti, la segheria per
legname Viallet-Farrault (1870), la fabbrica di dol-
ciumi Moriondo-Gariglio-Bruera (1872), il labora-
torio meccanico Bollito (1874).
I progetti di questi opifici (
38
), a firma tra gli altri
di Enrico Petitti (Viallet), Antonio Debernardi (Poc-
cardi, Moriondo-Gariglio), Pietro Carrera (Fiorio),
offrono in genere fabbricati semplici, dove i corpi di
fabbrica sono lunghi contenitori in muratura a due-
tre piani, ritmati da aperture regolari; raramente la
palazzina degli uffici emerge sui corpi-tettoia adibiti
alle lavorazioni, assumendo connotazioni «colte»,
improntate a motivi neo-rinascimentali (Fiorio) o si
sottolinea la volontà di reclamizzare la ditta con il
nome posto su un fastigio sovrastante l'ingresso
(Sperati, Caffarel); talvolta si punta sulla simmetria
d'impianto generale, dominata dall'avancorpo cen-
trale, coronato dal timpano classicheggiante (Gilar-
dini). È un'architettura industriale di transizione tra
la fabbrica settecentesca e quelle che saranno le
nuove soluzioni strutturali e decorative del Novecen-
to, permesse anche dall'introduzione di nuovi mate-
riali (
39
). Nel magazzino della conceria Martinolo
viene adottata una struttura portante in ferro, mentre
altrove il sistema è generalmente in muratura; talvol-
ta l'insieme non si discosta visivamente dalla sem-
plice presenza abitativa (Moriondo-Gariglio).
Se l'apertura del Canale Ceronda rafforzerà ulte-
riormente il peso industriale della zona settentrionale a
cavallo della prima cinta daziaria (dentro vi è compre-
so il ramo destro e fuori ne è quello sinistro), con il
decennio successivo, a causa della decisa spinta in
avanti portata dall'industria meccanica favorita dal-
l'introduzione dell'energia elettrica e dalle opportunità
create dallo sviluppo delle strade ferrate, la geografia
delle presenze industriali andrà gradatamente mutan-
do, svincolandosi dalla tradizionale dipendenza dal-
l'acqua per seguire altri criteri (40)
Sebbene i canali Pellerina-Martinetto, Ceronda,
Lucento offrissero ancora a molte aziende salti d'ac-
qua per azionare turbine, per raffreddare il ciclo di
lavorazione o per scaricarvi scorie (sulla Ceronda si
impianterà il primo nucleo della « Società Nazionale
Industrie di Savigliano» (1889), della Michele An-
saldi (1884), della fonderia Nebiolo (1878 c.), della
Paracchi (1880 c.); sulla Pellerina-Martinetto la
conceria «Durio» (1882 c.), la fabbrica di lime Lau-
renti, la cartiera San Cesario; sulla Nuova di Lusent
la CIR-Concerie Italiane Riunite - trasformando il
preesistente filatoio da seta Boyer-Campana) (
41
), se
ancora i sobborghi industriali « storici » risultavano
possedere caratteristiche favorevoli alla localizza-
zione di nuovi opifici (in Borgo Po la fabbrica del
Bianco Zinco (1870), le fonderie Polla e Fréjus
(1875), la tessitura Ghidini e l'industria di automo-
bili Diatto) (1880) (
42
)
,
nell'ultimo ventennio del
secolo si andrà facendo strada un deciso orientamen-
to verso la scelta di aree servite dalla ferrovia o più
esterne, racchiuse entro la cinta daziaria ma poste in
prossimità delle porte di essa.
Nel quartiere Valdocco, presso la Fabbrica
d'armi settecentesca, e a lato dello scalo merci verrà
aperto nel 1889 il « Cotonificio
Dora»,
terzo stabi-
limento della Società Valle Susa di Wild e Abegg, il
più grande opificio di Torino con 800 macchine e
1216 operai (
43
), presso la ferrovia, a sud di Porta
Nuova, la fabbrica di vetture Locati (1881), più
esterne la FIAT (1889) e la Itala (1905) di automobi-
li, talvolta aprendo la via ad un processo di polariz-
zazione edilizia sebbene con esiti lenti.
Esemplare nel rapporto tra industria e abitazione
indotta è la vicenda del Borgo San Paolo
(
44
)
dove
l'insediamento delle Officine Ferroviarie, pensate
fino dal 1882 e realizzate tra il 1884 e il '900 in
un'area all'interno della cinta daziaria, tangente alla
ferrovia per Milano e prossima ad un nucleo di edifi-
ci di servizio preesistenti (Carcere, Mattatoio, Mer-
cato del bestiame) indusse ben presto nuove presen-
ze industriali nei pressi (Officine Westinghouse che
producevano freni e segnali per locomotive e, a ca-
vallo del secolo, la Nebiolo ed il Ruotificio Italiano,
nonché, più avanti, la
FIP,
la SNIA-UTITA, la Lan-
cia). Ma soprattutto, al di fuori della barriera aper-
ta nella cinta daziaria, cominciò a prendere forma
un «borgo» operaio, Borgo San Paolo, connesso
fisicamente, solo dopo l'abbattimento della cinta
nel 1912, alle industrie che erano state la sua ori-
gine (
45
).
La cinta daziaria operò un ruolo non indifferente
nella nascita delle « barriere operaie», poiché il trac-
ciato di essa si pose come confine reale tra l'edifica-
zione urbana — risultata tuttavia molto lenta — ed il
suburbio che, potendo usufruire di esenzioni sui
materiali da costruzione, sulle merci, vide la nascita
semispontanea di agglomerati con abitazioni e bot-
teghe artigiane, sprovvisti per molto tempo di servi-
zi, laddove le porte della cinta permettevano di rag-
giungere le industrie interne ad essa.
Solo alla fine degli anni Ottanta la città raggiun-
se, fuori della cinta, i nuclei operai cresciuti rapida-
mente ed in modo non connesso alla forma urbana
interna ed una serie di provvedimenti per le borgate
Madonna di Campagna, Vittoria, Monte Bianco
(1889), Campidoglio, Francia, Cenisia, Mongine-
vro, San Paolo (1889-1901), tesero a disciplinare il
disordine urbanistico ed edilizio in vista di una giun-
zione con la città che si pensava non lontana (
46
).
Nell'aprile del 1908 il primo
Piano Regotatore Ge-
nerale
accolse le nuove realtà delle borgate e le rac-
cordò, con allineamenti stradali, al nocciolo entro la
cinta che si prevedeva ancora di allargare; avvenne
730


















