
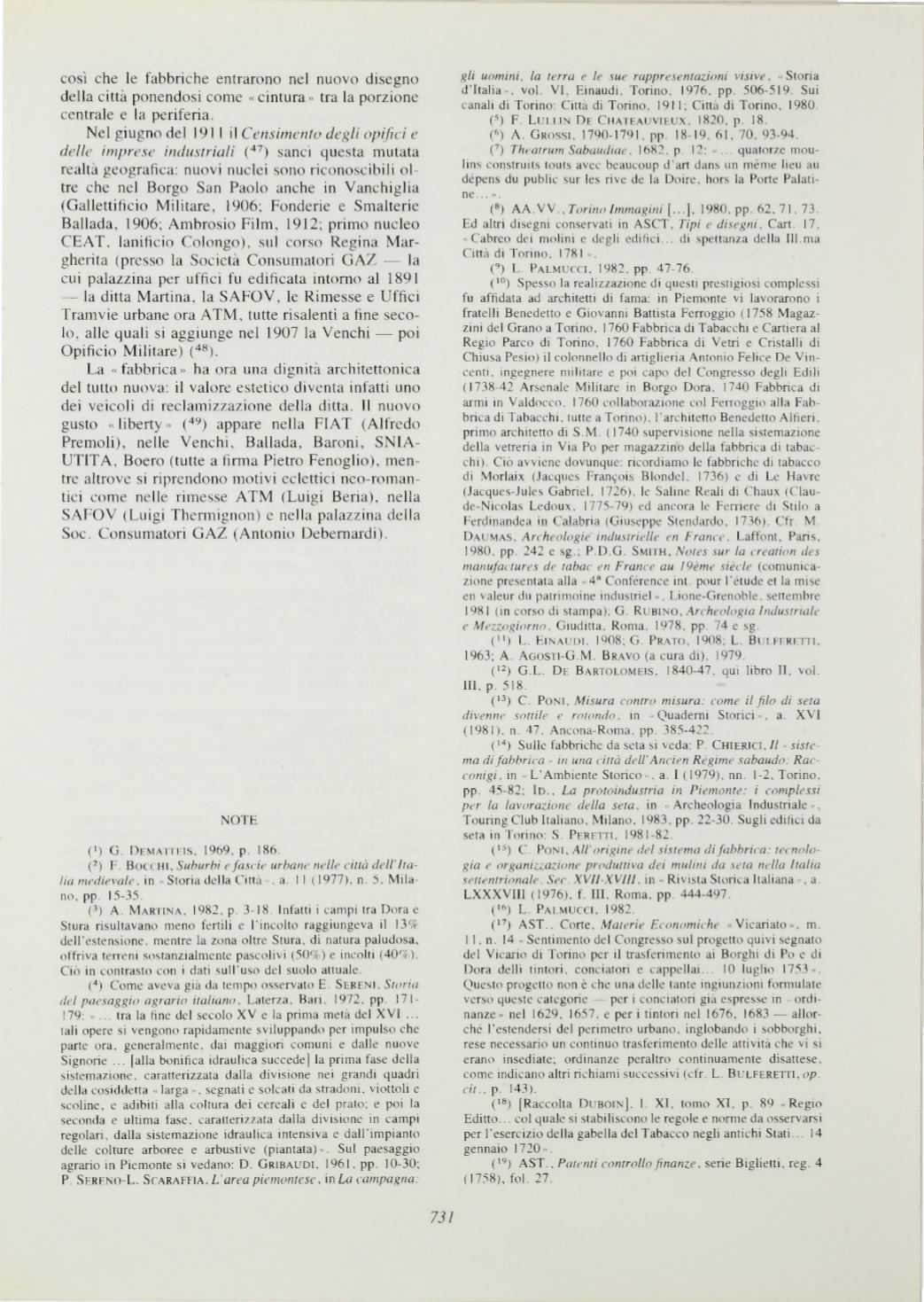
così che le fabbriche entrarono nel nuovo disegno
della città ponendosi come «cintura» tra la porzione
centrale e la periferia.
Nel giugno del 1911 il
Censimento degti opifici e
dette imprese industriati
(
47
) sancì questa mutata
realtà geografica: nuovi nuclei sono riconoscibili ol-
tre che nel Borgo San Paolo anche in Vanchiglia
(Gallettificio Militare, 1906; Fonderie e Smalterie
Ballada, 1906; Ambrosio Film, 1912; primo nucleo
CEAT, lanificio Colongo), sul corso Regina Mar-
gherita (presso la Società Consumatori GAZ la
cui palazzina per uffici fu edificata intorno al 1891
— la ditta Ma
rt
ina, la SAFOV, le Rimesse e Uffici
Tramvie urbane ora ATM, tutte risalenti a fine seco-
lo, alle quali si aggiunge nel 1907 la Venchi poi
Opificio Militare)
(
48
).
La « fabbrica. ha ora una dignità architettonica
del tutto nuova: il valore estetico diventa infatti uno
dei veicoli di reclamizzazione della ditta. Il nuovo
gusto « liberty
» (
49
)
appare nella FIAT (Alfredo
Premoli), nelle Venchi, Ballada, Baroni, SNIA-
UTITA, Boero (tutte a firma Pietro Fenoglio), men-
tre altrove si riprendono motivi eclettici neo-roman-
tici come nelle rimesse ATM (Luigi Beria), nella
SAFOV (Luigi Thermignon)
e
nella palazzina della
Soc. Consumatori GAZ (Antonio Debernardi).
NOTE
(1) G.
DEMATTEIS,
1969, p. 186.
(2) F. BoccHi,
Suburbi e fascie urbane nelle città delt'Ita-
lia medievale,
in ,. Storia della Città ,,, a. I I (1977), n. 5, Mila-
no, pp. 15-35.
(3) A.
MARTINA,
1982, p. 3-18. Infatti i campi tra Dora e
Stura risultavano meno fertili e l'incolto raggiungeva il 13%
dell'estensione, mentre la zona oltre Stura, di natura paludosa,
offriva terreni sostanzialmente pascolivi (50%) e incolti (40%).
Ciò in contrasto con i dati sull'uso del suolo attuale.
(4) Come aveva già da tempo osservato E.
SERENI,
Storia
del paesaggio agrario italiano,
Laterza, Bari, 1972, pp. 171-
179: « ... tra la fine del secolo XV e la prima metà del XVI ...
tali opere si vengono rapidamente sviluppando per impulso che
parte ora, generalmente, dai maggiori comuni e dalle nuove
Signorie ... [alla bonifica idraulica succede] la prima fase della
sistemazione, caratterizzata dalla divisione nei grandi quadri
della cosiddetta ., larga», segnati e solcati da stradoni, viottoli e
scoline, e adibiti alla coltura dei cereali e del prato; e poi la
seconda e ultima fase, caratterizzata dalla divisione in campi
regolari, dalla sistemazione idraulica intensiva e dall'impianto
delle colture arboree e arbustive (piantata)». Sul paesaggio
agrario in Piemonte si vedano: D.
GRIBAUDI,
1961, pp. 10-30;
P.
SERENO-L. SCARAFFIA,
L'area piemontese,
in
La campagna:
gli uomini, ta terra e le sue rappresentazioni visive, «
Storia
d'Italia»,
vol. VI. Einaudi, Torino, 1976, pp. 506-519.
Sui
canali
di Torino:
Città
di Torino, 1911;
Città
di Torino, 1980.
(5) F.
LULLIN DE CHATEAUVIEUX,
1820, p. 18.
(6) A.
GRossI,
1790-1791, pp. 18-19, 61, 70, 93-94.
(
7
)
Theatrum Sabaudiae,
1682, p. 12: « .., quatorze mou-
lins construits touts avec beaucoup d'art dans
un
méme lieu au
dépens du public sur les
ri
ve de la Doire, hors la Po
rt
e Palati-
(8)
AA.VV.,
Torino Immagini [...],
1980, pp. 62, 71, 73.
Ed altri disegni conservati in ASCT,
Tipi e disegni,
Cart. 17.
«Cabreo dei molini e degli edifici... di spettanza della
Ill.maCittà di Torino, 1781..
(9) L.
PALMUCcI,
1982, pp. 47-76.
(
1
o) Spesso la realizzazione di questi prestigiosi complessi
fu affidata ad architetti di fama: in Piemonte vi lavorarono i
fratelli Benedetto e Giovanni Battista Ferroggio (1758 Magaz-
zini del Grano a Torino, 1760 Fabbrica di Tabacchi e Cartiera al
Regio Parco di Torino, 1760 Fabbrica di Vetri e Cristalli di
Chiusa Pesio) il colonnello di artiglieria Antonio Felice De Vin-
centi, ingegnere militare e poi capo del Congresso degli Edili
(1738-42 Arsenale Militare in Borgo Dora, 1740 Fabbrica di
armi in Valdocco. 1760 collaborazione col Ferroggio alla Fab-
brica di Tabacchi, tutte a Torino), l'architetto Benedetto Alfieri,
primo architetto di S.M. (1740 supervisione nella sistemazione
della vetreria in Via Po per magazzino della fabbrica di tabac-
chi). Ciò avviene dovunque: ricordiamo le fabbriche di tabacco
di Morlaix (Jacques Frangois Blondel, 1736) e di Le Havre
(Jacques-Jules Gabriel, 1726), le Saline Reali di Chaux (Clau-
de-Nicolas Ledoux, 1775-79) ed ancora le Ferriere di Stilo a
Ferdinandea in Calabria (Giuseppe Stendardo, 1736). Cfr. M.
DAUMAS,
Archeologie industrielle en France,
Laffont, Paris,
1980, pp. 242 e sg.; P.D.G.
SMITH,
Notes sur ta creation des
manufactures de tabac en France au I9ème siècle
(comunica-
zione presentata alla
«4a
Conférence int. pour l'étude et la mise
en valeur du patrimoine industriel » , Lione-Grenoble. settembre
1981 (in corso di stampa); G.
RUBINO,
Archeologia Industriale
e Mezzogiorno,
Giuditta, Roma, 1978, pp. 74 e sg.
(11) L.
EINAUDI,
1908; G.
PRATO,
1908; L.
BULFERETTI,
1963; A. AGOSTI-G.M.
BRAVO
(a cura di), 1979.
(12) G.L.
DE BARTOLOMEIS,
1840-47. qui libro II, vol.
III, p. 518.
(13) C.
PONI,
Misura contro misura: come il filo di seta
divenne sottile e rotondo,
in «Quaderni Storici», a. XVI
(1981), n. 47, Ancona-Roma. pp. 385-422.
(14) Sulle fabbriche da seta si veda: P.
CHIERICI,
Il « siste-
ma di fabbrica ., in una città dell'Ancien Régime sabaudo: Rac-
conigi,
in «L'Ambiente Storico
,,
, a. I (1979), nn. 1-2, Torino.
pp. 45-82;
ID.,
La protoindustria in Piemonte: i comptessi
per ta lavorazione della seta,
in « Archeologia Industriale
» ,
Tou
ri
ng Club Italiano, Milano. 1983, pp. 22-30. Sugli edifici da
seta in Torino: S.
PERETTI,
1981-82.
(15) C.
PONI,
All'origine det sistema di fabbrica: tecnolo-
gia e organizzazione produttiva dei mulini da seta nella Itatia
settentrionale. Sec. XVII-XVIII,
in « Rivista Storica Italiana»
,
a.
LXXXVIII (1976), f. III, Roma, pp. 444-497.
(16) L.
PALMUCCI,
1982.
(17) AST., Corte,
Materie Economiche «Vicariato»,
m.
I l , n. 14 « Sentimento del Congresso sul progetto quivi segnato
del Vicario di Torino per il trasferimento ai Borghi di Po e di
Dora delli tintori, conciatori e cappellai... 10 luglio 1753
».
Questo progetto non è che una delle tante ingiunzioni formulate
verso queste categorie — per i conciatori già espresse in ., ordi-
nanze» nel 1629, 1657, e per i tintori nel 1676, 1683 — allor-
ché l'estendersi del perimetro urbano, inglobando i sobborghi,
rese necessario un continuo trasferimento delle attività che vi si
erano insediate; ordinanze peraltro continuamente disattese,
come indicano altri richiami successivi (cfr. L.
BULFERETTI,
op.
cit.,
p. 143).
(18) [Raccolta DusolN].
I.
XI, tomo XI, p. 89 «Regio
Editto... col quale si stabiliscono le regole e norme da osservarsi
per l'esercizio della gabella del Tabacco negli antichi Stati... 14
gennaio 1720
».
(
19
) AST.,
Patenti controllo finanze,
serie Biglietti, reg. 4
(1758), fol. 27.
731


















