
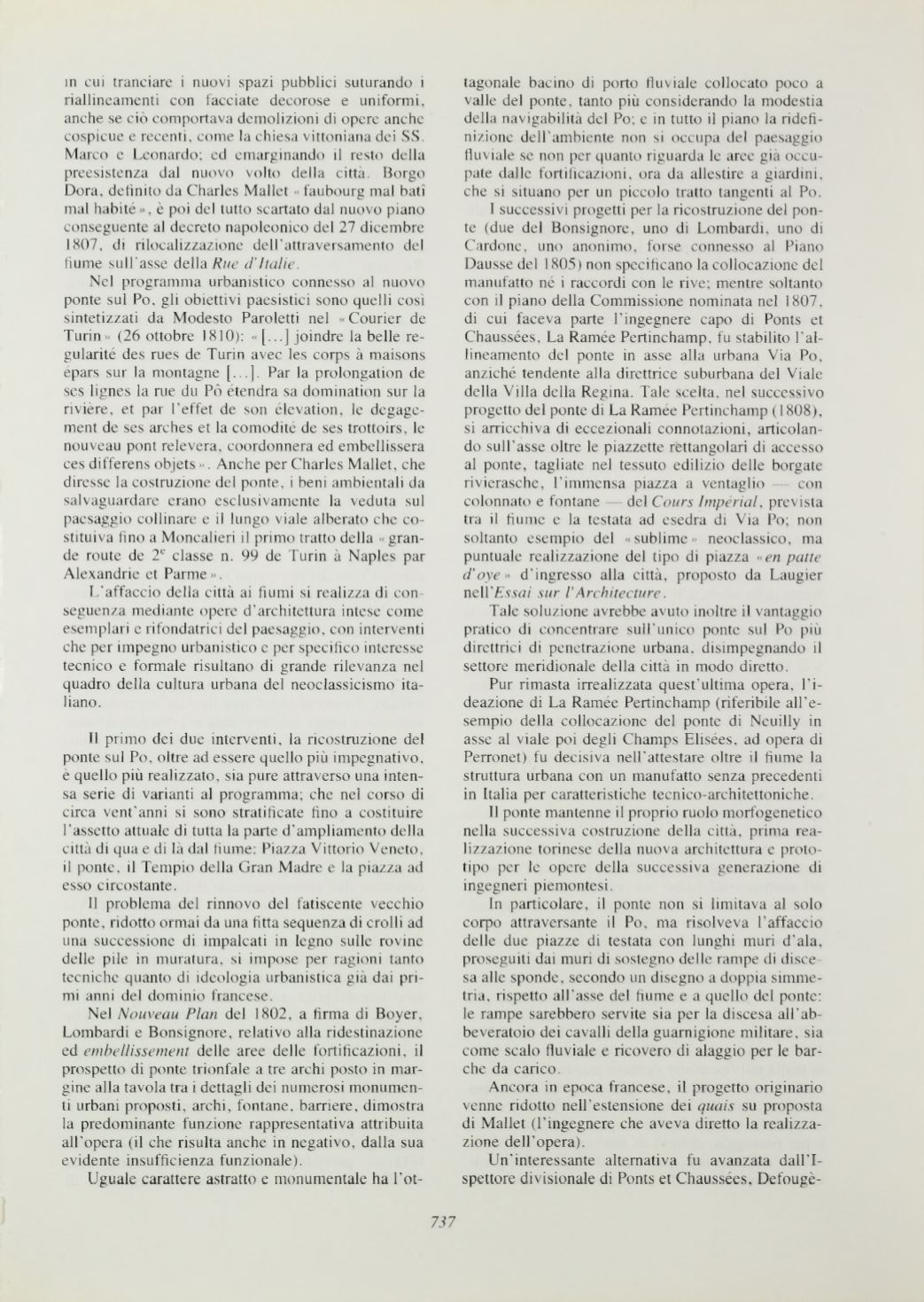
in cui tranciare i nuovi spazi pubblici suturando i
riallineamenti con facciate decorose e uniformi,
anche se ciò comportava demolizioni di opere anche
cospicue e recenti, come la chiesa vittoniana dei SS.
Marco e Leonardo; ed emarginando il resto della
preesistenza dal nuovo volto della città. Borgo
Dora, definito da Charles Mallet « faubourg mal batî
mal habité», è poi del tutto scartato dal nuovo piano
conseguente al decreto napoleonico del 27 dicembre
1807, di rilocalizzazione dell'attraversamento del
fiume sull'asse della
Rue d'Itatie.
Nel programma urbanistico connesso al nuovo
ponte sul Po, gli obiettivi paesistici sono quelli così
sintetizzati da Modesto Paroletti nel « Courier de
Turin» (26 ottobre 1810): « [...] joindre la belle re-
gularité des rues de Turin avec les corps à maisons
épars sur la montagne
[.1.
Par la prolongation de
ses lignes la rue du Pó étendra sa domination sur la
rivière, et par l'effet de son élevation, le degage-
ment de ses arches et la comodité de ses trottoirs, le
nouveau pont relevera, coordonnera ed embellissera
ces differens objets». Anche per Charles Mallet, che
diresse la costruzione del ponte, i beni ambientali da
salvaguardare erano esclusivamente la veduta sul
paesaggio collinare e il lungo viale alberato che co-
stituiva fino a Moncalieri il primo tratto della « gran-
de route de 2C classe n. 99 de Turin à Naples par
Alexandrie et Parme »
L'affaccio della città ai fiumi si realizza di con-
seguenza mediante opere d'architettura intese come
esemplari e rifondatrici del paesaggio, con interventi
che per impegno urbanistico e per specifico interesse
tecnico e formale risultano di grande rilevanza nel
quadro della cultura urbana del neoclassicismo ita-
liano.
Il primo dei due interventi, la ricostruzione del
ponte sul Po, oltre ad essere quello più impegnativo,
è quello più realizzato, sia pure attraverso una inten-
sa serie di varianti al programma; che nel corso di
circa vent'anni si sono stratificate fino a costituire
l'assetto attuale di tutta la parte d'ampliamento della
città di qua e di là dal fiume: Piazza Vittorio Veneto,
il ponte, il Tempio della Gran Madre e la piazza ad
esso circostante.
Il problema del rinnovo del fatiscente vecchio
ponte, ridotto ormai da una fitta sequenza di crolli ad
una successione di impalcati in legno sulle rovine
delle pile in muratura, si impose per ragioni tanto
tecniche quanto di ideologia urbanistica già dai pri-
mi anni del dominio francese.
Nel
Nouveau Ptan
del 1802, a firma di Boyer,
Lombardi e Bonsignore, relativo alla ridestinazione
ed
embettissernent
delle aree delle fortificazioni, il
prospetto di ponte trionfale a tre archi posto in mar-
gine alla tavola tra i dettagli dei numerosi monumen-
ti urbani proposti, archi, fontane, barriere, dimostra
la predominante funzione rappresentativa attribuita
all'opera (il che risulta anche in negativo, dalla sua
evidente insufficienza funzionale).
Uguale carattere astratto e monumentale ha l'ot-
tagonale bacino di porto fluviale collocato poco a
valle del ponte, tanto più considerando la modestia
della navigabilità del Po; e in tutto il piano la ridefi-
nizione dell'ambiente non si occupa del paesaggio
fluviale se non per quanto riguarda le aree già occu-
pate dalle fortificazioni, ora da allestire a giardini,
che si situano per un piccolo tratto tangenti al Po.
I successivi progetti per la ricostruzione del pon-
te (due del Bonsignore, uno di Lombardi, uno di
Cardone, uno anonimo, forse connesso al Piano
Dausse del 1805) non specificano la collocazione del
manufatto né i raccordi con le rive; mentre soltanto
con il piano della Commissione nominata nel 1807,
di cui faceva parte l'ingegnere capo di Ponts et
Chaussées, La Ramée Pertinchamp, fu stabilito l'al-
lineamento del ponte in asse alla urbana Via Po,
anziché tendente alla direttrice suburbana del Viale
della Villa della Regina. Tale scelta, nel successivo
progetto del ponte di La Ramée Pertinchamp (1808),
si arricchiva di eccezionali connotazioni, articolan-
do sull'asse oltre le piazzette rettangolari di accesso
al ponte, tagliate nel tessuto edilizio delle borgate
rivierasche, l'immensa piazza a ventaglio — con
colonnato e fontane del
Cours Impériat,
prevista
tra il fiume e la testata ad esedra di Via Po; non
soltanto esempio del « sublime » neoclassico, ma
puntuale realizzazione del tipo di piazza
«en patte
d' oye »
d'ingresso alla città, proposto da Laugier
nell'Essai sur t'Architecture.
Tale soluzione avrebbe avuto inoltre il vantaggio
pratico di concentrare sull'unico ponte sul Po più
direttrici di penetrazione urbana, disimpegnando il
settore meridionale della città in modo diretto.
Pur rimasta irrealizzata quest'ultima opera, l'i-
deazione di La Ramée Pertinchamp (riferibile all'e-
sempio della collocazione del ponte di Neuilly in
asse al viale poi degli Champs Elisées, ad opera di
Perronet) fu decisiva nell'attestare oltre il fiume la
struttura urbana con un manufatto senza precedenti
in Italia per caratteristiche tecnico-architettoniche.
Il ponte mantenne il proprio ruolo morfogenetico
nella successiva costruzione della città, prima rea-
lizzazione torinese della nuova architettura e proto-
tipo per le opere della successiva generazione di
ingegneri piemontesi.
In particolare, il ponte non si limitava al solo
corpo attraversante il Po, ma risolveva l'affaccio
delle due piazze di testata con lunghi muri d'ala,
proseguiti dai muri di sostegno delle rampe di disce-
sa alle sponde, secondo un disegno a doppia simme-
tria, rispetto all'asse del fiume e a quello del ponte:
le rampe sarebbero servite sia per la discesa all'ab-
beveratoio dei cavalli della guarnigione militare, sia
come scalo fluviale e ricovero
di
alaggio per le bar-
che da carico.
Ancora in epoca francese, il progetto originario
venne ridotto nell'estensione dei
quais
su proposta
di Mallet (l'ingegnere che aveva diretto la realizza-
zione dell'opera).
Un'interessante alternativa fu avanzata dall'I-
spettore divisionale di Ponts et Chaussées, Defougè-
737


















