
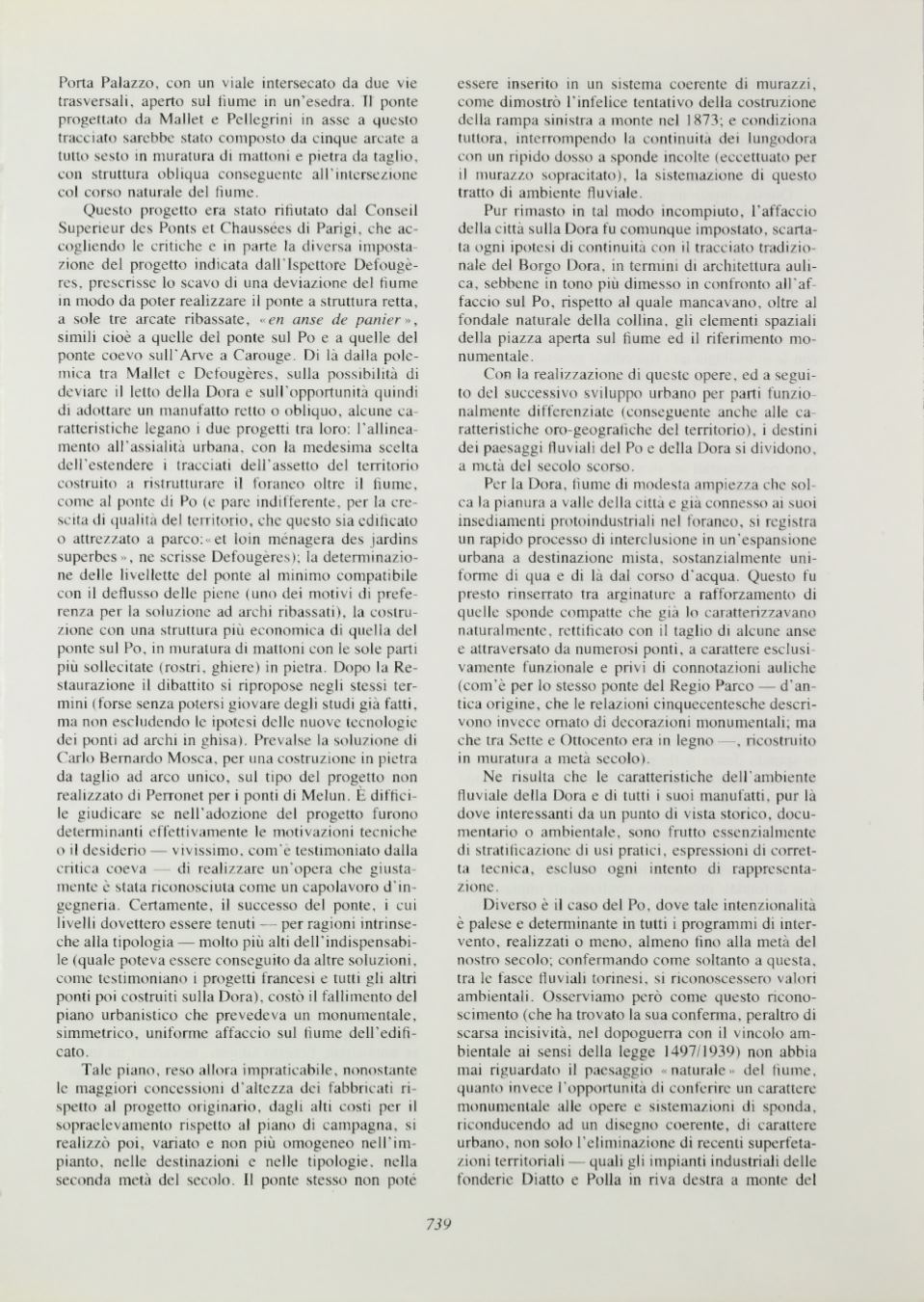
Porta Palazzo, con un viale intersecato da due vie
trasversali, aperto sul fiume in un'esedra. Il ponte
progettato da Mallet e Pellegrini in asse a questo
tracciato sarebbe stato composto da cinque arcate a
tutto sesto in muratura di mattoni e pietra da taglio,
con struttura obliqua conseguente all'intersezione
col corso naturale del fiume.
Questo progetto era stato rifiutato dal Conseil
Superieur des Ponts et Chaussées di Parigi, che ac-
cogliendo le critiche e in parte la diversa imposta-
zione del progetto indicata dall'Ispettore Defougè-
res, prescrisse lo scavo di una deviazione del fiume
in modo da poter realizzare il ponte a struttura retta,
a sole tre arcate ribassate,
«en
anse de papier» ,
simili cioè a quelle del ponte sul Po e a quelle del
ponte coevo sull'Arve a Carouge. Di là dalla pole-
mica tra Mallet e Defougères, sulla possibilità di
deviare il letto della Dora e sull'opportunità quindi
di adottare un manufatto retto o obliquo, alcune ca-
ratteristiche legano i due progetti tra loro: l'allinea-
mento all'assialità urbana, con la medesima scelta
dell'estendere i tracciati dell'assetto del territorio
costruito a ristrutturare il foraneo oltre il fiume,
come al ponte di Po (e pare indifferente, per la cre-
scita di qualità del territorio, che questo sia edificato
o attrezzato a parco:, et loin ménagera des jardins
superbes », ne scrisse Defougères); la determinazio-
ne delle livellette del ponte al minimo compatibile
con il deflusso delle piene (uno dei motivi di prefe-
renza per la soluzione ad archi ribassati), la costru-
zione con una struttura più economica di quella del
ponte sul Po, in muratura di mattoni con le sole parti
più sollecitate (rostri, ghiere) in pietra. Dopo la Re-
staurazione il dibattito si ripropose negli stessi ter-
mini (forse senza potersi giovare degli studi già fatti,
ma non escludendo le ipotesi delle nuove tecnologie
dei ponti ad archi in ghisa). Prevalse la soluzione di
Carlo Bernardo Mosca, per una costruzione in pietra
da taglio ad arco unico, sul tipo del progetto non
realizzato di Perronet per
i
ponti di Melun. È diffici-
le giudicare se nell'adozione del progetto furono
determinanti effettivamente le motivazioni tecniche
o il desiderio vivissimo, com'è testimoniato dalla
critica coeva di realizzare un'opera che giusta-
mente è stata riconosciuta come un capolavoro d'in-
gegneria. Certamente, il successo del ponte, i cui
livelli dovettero essere tenuti — per ragioni intrinse-
che alla tipologia molto più alti dell'indispensabi-
le (quale poteva essere conseguito da altre soluzioni,
come testimoniano i progetti francesi e tutti gli altri
ponti poi costruiti sulla Dora), costò il fallimento del
piano urbanistico che prevedeva un monumentale,
simmetrico, uniforme affaccio sul fiume dell'edifi-
cato.
Tale piano, reso allora impraticabile, nonostante
le maggiori concessioni d'altezza dei fabbricati ri-
spetto al progetto originario, dagli alti costi per
il
sopraelevamento rispetto al piano di campagna, si
realizzò poi, variato e non più omogeneo nell'im-
pianto, nelle destinazioni e nelle tipologie, nella
seconda metà del secolo. Il ponte stesso non poté
essere inserito in un sistema coerente di murazzi,
come dimostrò l'infelice tentativo della costruzione
della rampa sinistra a monte nel 1873; e condiziona
tuttora, interrompendo la continuità dei lungodora
con un ripido dosso a sponde incolte (eccettuato per
il murazzo sopracitato), la sistemazione di questo
tratto di ambiente fluviale.
Pur rimasto in tal modo incompiuto, l'affaccio
della città sulla Dora fu comunque impostato, scarta-
ta ogni ipotesi di continuità con il tracciato tradizio-
nale del Borgo Dora, in termini di architettura auli-
ca, sebbene in tono più dimesso in confronto all'af-
faccio sul Po, rispetto al quale mancavano, oltre al
fondale naturale della collina, gli elementi spaziali
della piazza aperta sul fiume ed il riferimento mo-
numentale.
Con la realizzazione di queste opere, ed a segui-
to del successivo sviluppo urbano per parti funzio-
nalmente differenziate (conseguente anche alle ca-
ratteristiche oro-geografiche del territorio), i destini
dei paesaggi fluviali del Po e della Dora si dividono,
a metà del secolo scorso.
Per la Dora, fiume di modesta ampiezza che sol-
ca la pianura a valle della città e già connesso ai suoi
insediamenti protoindustriali nel foraneo, si registra
un rapido processo di interclusione in un'espansione
urbana a destinazione mista, sostanzialmente uni-
forme di qua e di là dal corso d'acqua. Questo fu
presto rinserrato tra arginature a rafforzamento di
quelle sponde compatte che già lo caratterizzavano
naturalmente, rettificato con il taglio di alcune anse
e attraversato da numerosi ponti, a carattere esclusi-
vamente funzionale e privi di connotazioni auliche
(com'è per lo stesso ponte del Regio Parco — d'an-
tica origine, che le relazioni cinquecentesche descri-
vono invece ornato di decorazioni monumentali; ma
che tra Sette e Ottocento era in legno —, ricostruito
in muratura a metà secolo).
Ne risulta che le caratteristiche dell'ambiente
fluviale della Dora e di tutti i suoi manufatti, pur là
dove interessanti da un punto di vista storico, docu-
mentario o ambientale, sono frutto essenzialmente
di stratificazione di usi pratici, espressioni di corret-
ta tecnica, escluso ogni intento di rappresenta-
zione.
Diverso è il caso del Po, dove tale intenzionalità
è palese e determinante in
tutti
i programmi di inter-
vento, realizzati o meno, almeno fino alla metà del
nostro secolo; confermando come soltanto a questa,
tra le fasce fluviali torinesi, si riconoscessero valori
ambientali. Osserviamo però come questo ricono-
scimento (che ha trovato la sua conferma, peraltro
di
scarsa incisività, nel dopoguerra con il vincolo am-
bientale ai sensi della legge 1497/1939) non abbia
mai riguardato il paesaggio « naturale » del fiume,
quanto invece l'opportunità di conferire un carattere
monumentale alle opere e sistemazioni di sponda,
riconducendo ad un disegno coerente, di carattere
urbano, non solo l'eliminazione di recenti superfeta-
zioni territoriali — quali gli impianti industriali delle
fonderie Diatto e Polla in riva destra a monte del
739


















