
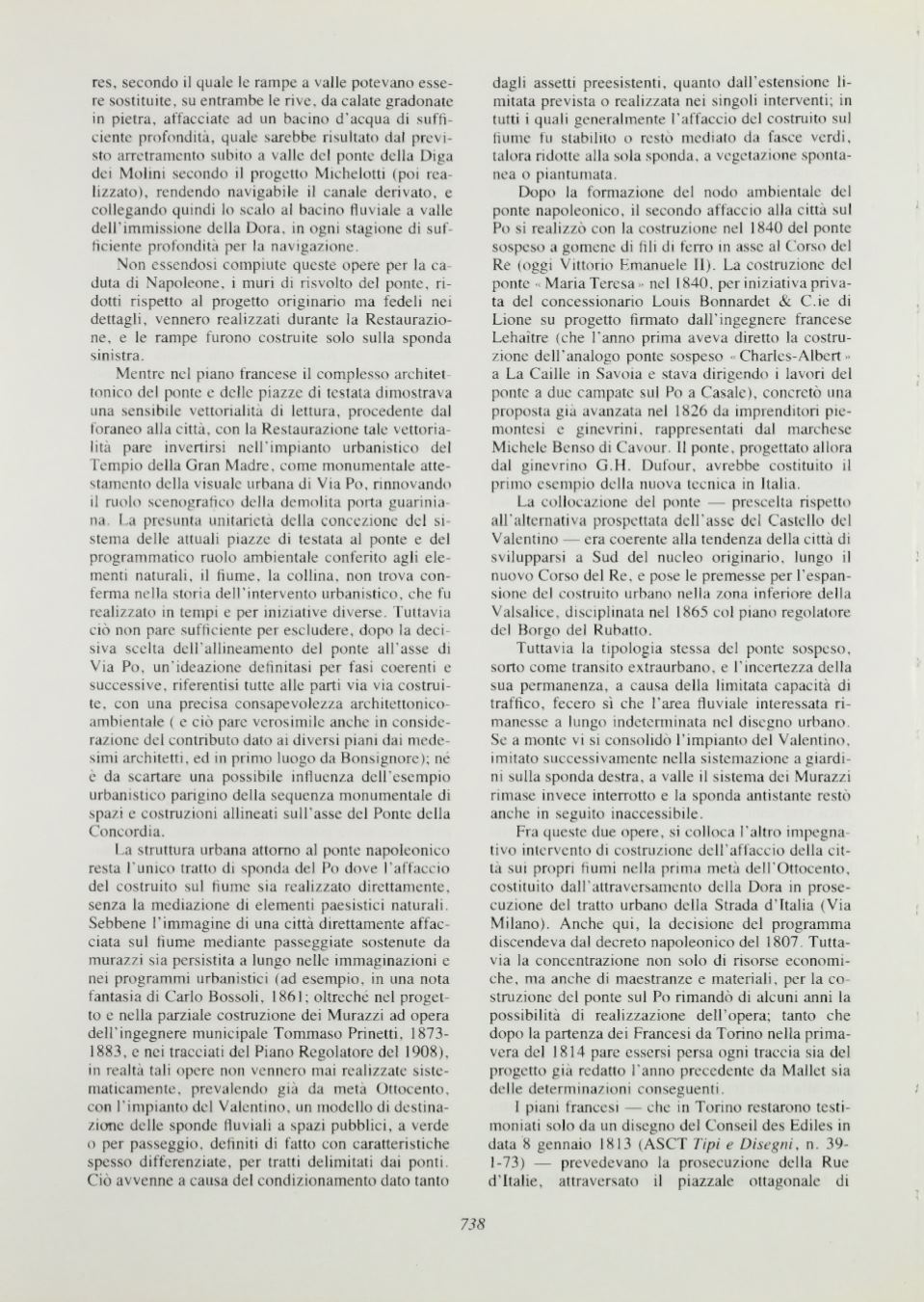
res, secondo il quale le rampe a valle potevano esse-
re sostituite, su entrambe le rive, da calate gradonate
in pietra, affacciate ad un bacino d'acqua di suffi-
ciente profondità, quale sarebbe risultato dal previ-
sto arretramento subito a valle del ponte della Diga
dei Molini secondo il progetto Michelotti (poi rea-
lizzato), rendendo navigabile il canale derivato, e
collegando quindi lo scalo al bacino fluviale a valle
dell'immissione della Dora, in ogni stagione di suf-
ficiente profondità per la navigazione.
Non essendosi compiute queste opere per la ca-
duta di Napoleone, i muri di risvolto del ponte, ri-
dotti rispetto al progetto originario ma fedeli nei
dettagli, vennero realizzati durante la Restaurazio-
ne, e le rampe furono costruite solo sulla sponda
sinistra.
Mentre nel piano francese il complesso architet-
tonico del ponte e delle piazze di testata dimostrava
una sensibile vettorialità di lettura, procedente dal
foraneo alla città, con la Restaurazione tale vettoria-
lità pare invertirsi nell'impianto urbanistico del
Tempio della Gran Madre, come monumentale atte-
stamento della visuale urbana di Via Po, rinnovando
il ruolo scenografico della demolita porta guarinia-
na. La presunta unitarietà della concezione del si-
stema delle attuali piazze di testata al ponte e del
programmatico ruolo ambientale conferito agli ele-
menti naturali, il fiume, la collina, non trova con-
ferma nella storia dell'intervento urbanistico, che fu
realizzato in tempi e per iniziative diverse. Tuttavia
ciò non pare sufficiente per escludere, dopo la deci-
siva scelta dell'allineamento del ponte all'asse di
Via Po, un'ideazione definitasi per fasi coerenti e
successive, riferentisi tutte alle parti via via costrui-
te, con una precisa consapevolezza architettonico-
ambientale (e ciò pare verosimile anche in conside-
razione del contributo dato ai diversi piani dai mede-
simi architetti, ed in primo luogo da Bonsignore); né
è da scartare una possibile influenza dell'esempio
urbanistico parigino della sequenza monumentale di
spazi e costruzioni allineati sull'asse del Ponte della
Concordia.
La struttura urbana attorno al ponte napoleonico
resta l'unico tratto di sponda del Po dove l'affaccio
del costruito sul fiume sia realizzato direttamente,
senza la mediazione di elementi paesistici naturali.
Sebbene l'immagine di una città direttamente affac-
ciata sul fiume mediante passeggiate sostenute da
murazzi sia persistita a lungo nelle immaginazioni e
nei programmi urbanistici (ad esempio, in una nota
fantasia di Carlo Bossoli, 1861; oltreché nel proget-
to e nella parziale costruzione dei Murazzi ad opera
dell'ingegnere municipale Tommaso Prinetti, 1873-
1883, e nei tracciati del Piano Regolatore del 1908),
in realtà tali opere non vennero mai realizzate siste-
maticamente, prevalendo già da metà Ottocento,
con l'impianto del Valentino, un modello di destina-
zione delle sponde fluviali a spazi pubblici, a verde
o
per passeggio, definiti di fatto con caratteristiche
spesso differenziate, per tratti delimitati dai ponti.
Ciò avvenne a causa del condizionamento dato tanto
dagli assetti preesistenti, quanto dall'estensione li-
mitata prevista o realizzata nei singoli interventi; in
tutti
i
quali generalmente l'affaccio del costruito sul
fiume fu stabilito o restò mediato da fasce verdi,
talora ridotte alla sola sponda, a vegetazione sponta-
nea o piantumata.
Dopo la formazione del nodo ambientale del
ponte napoleonico, il secondo affaccio alla città sul
Po si realizzò con la costruzione nel 1840 del ponte
sospeso a gomene di fili di ferro in asse al Corso del
Re (oggi Vittorio Emanuele II). La costruzione del
ponte « Maria Teresa» nel 1840, per iniziativa priva-
ta del concessionario Louis Bonnardet &
C.iedi
Lione su progetto firmato dall'ingegnere francese
Lehaitre (che l'anno prima aveva diretto la costru-
zione dell'analogo ponte sospeso « Charles-Albert »
a La Caille in Savoia e stava dirigendo i lavori del
ponte a due campate sul Po a Casale), concretò una
proposta già avanzata nel 1826 da imprenditori pie-
montesi e ginevrini, rappresentati dal marchese
Michele Benso di Cavour. Il ponte, progettato allora
dal ginevrino G.H. Dufour, avrebbe costituito il
primo esempio della nuova tecnica in Italia.
La collocazione del ponte prescelta rispetto
all'alternativa prospettata dell'asse del Castello del
Valentino era coerente alla tendenza della città di
svilupparsi a Sud del nucleo originario, lungo il
nuovo Corso del Re, e pose le premesse per l'espan-
sione del costruito urbano nella zona inferiore della
Valsalice, disciplinata nel 1865 col piano regolatore
del Borgo del Rubatto.
Tuttavia la tipologia stessa del ponte sospeso,
sorto come transito extraurbano, e l'incertezza della
sua permanenza, a causa della limitata capacità di
traffico, fecero sì che l'area fluviale interessata
ri-
manesse
a lungo indeterminata nel disegno urbano.
Se a monte vi si consolidò l'impianto del Valentino,
imitato successivamente nella sistemazione a giardi-
ni sulla sponda destra, a valle il sistema dei Murazzi
rimase invece interrotto e la sponda antistante restò
anche in seguito inaccessibile.
Fra queste due opere, si colloca l'altro impegna-
tivo intervento di costruzione dell'affaccio della cit-
tà sui propri fiumi nella prima metà dell'Ottocento,
costituito dall'attraversamento della Dora in prose-
cuzione del tratto urbano della Strada d'Italia (Via
Milano). Anche qui, la decisione del programma
discendeva dal decreto napoleonico del 1807. Tutta-
via la concentrazione non solo di risorse economi-
che, ma anche di maestranze e materiali, per la co-
struzione del ponte sul Po rimandò di alcuni anni la
possibilità di realizzazione dell'opera; tanto che
dopo la partenza dei Francesi da Torino nella prima-
vera del 1814 pare essersi persa ogni traccia sia del
progetto già redatto l'anno precedente da Mallet sia
delle determinazioni conseguenti.
I piani francesi che in Torino restarono testi-
moniati solo da un disegno del Conseil des Ediles in
data 8 gennaio 1813 (ASCT
Tipi e Disegni,
n. 39-
1-73) prevedevano la prosecuzione della Rue
d'Italie, attraversato il piazzale ottagonale di
738


















