
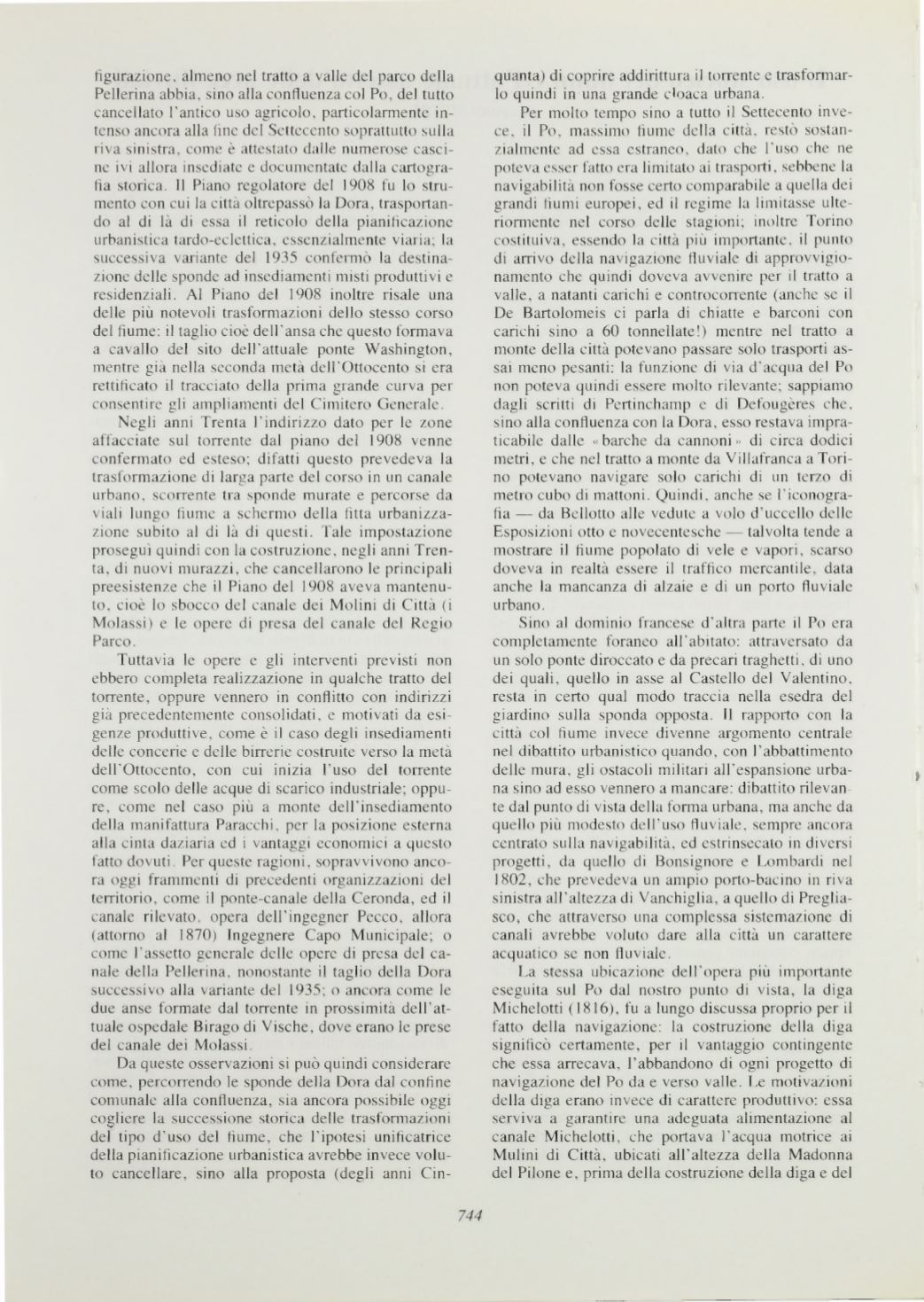
figurazione, almeno nel tratto a valle del parco della
Pellerina abbia, sino alla confluenza col Po, del tutto
cancellato l'antico uso agricolo, particolarmente in-
tenso ancora alla fine del Settecento soprattutto sulla
riva sinistra, come è attestato dalle numerose casci-
ne ivi allora insediate e documentate dalla cartogra-
fia storica. Il Piano regolatore del 1908 fu lo stru-
mento con cui la città oltrepassò la Dora, trasportan-
do al di là di essa il reticolo della pianificazione
urbanistica tardo-eclettica, essenzialmente viaria; la
successiva variante del 1935 confermò la destina-
zione delle sponde ad insediamenti misti produttivi e
residenziali. Al Piano del 1908 inoltre risale una
delle più notevoli trasformazioni dello stesso corso
del fiume: il taglio cioè dell'ansa che questo formava
a cavallo del sito dell'attuale ponte Washington,
mentre già nella seconda metà dell'Ottocento si era
rettificato il tracciato della prima grande curva per
consentire gli ampliamenti del Cimitero Generale.
Negli anni Trenta l'indirizzo dato per le zone
affacciate sul torrente dal piano del 1908 venne
confermato ed esteso; difatti questo prevedeva la
trasformazione di larga parte del corso in un canale
urbano, scorrente tra sponde murate e percorse da
viali lungo fiume a schermo della fitta urbanizza-
zione subito al di là di questi. Tale impostazione
proseguì quindi con la costruzione, negli anni Tren-
ta, di nuovi murazzi, che cancellarono le principali
preesistenze che il Piano del 1908 aveva mantenu-
to, cioè lo sbocco del canale dei Molini di Città (i
Molassi) e le opere di presa del canale del Regio
Parco.
Tuttavia le opere e gli interventi previsti non
ebbero completa realizzazione in qualche tratto del
torrente, oppure vennero in conflitto con indirizzi
già precedentemente consolidati, e motivati da esi-
genze produttive, come è il caso degli insediamenti
delle concerie e delle birrerie costruite verso la metà
dell'Ottocento, con cui inizia l'uso del torrente
come scolo delle acque di scarico industriale; oppu-
re, come nel caso più a monte dell'insediamento
della manifattura Paracchi, per la posizione esterna
alla cinta daziaria ed i vantaggi economici a questo
fatto dovuti. Per queste ragioni, sopravvivono anco-
ra oggi frammenti di precedenti organizzazioni del
territorio, come il ponte-canale della Ceronda, ed il
canale rilevato, opera dell'ingegner Pecco, allora
(attorno al I870) Ingegnere Capo Municipale; o
come l'assetto generale delle opere di presa del ca-
nale della Pellerina, nonostante il taglio della Dora
successivo alla variante del I935; o ancora come le
due anse formate dal torrente in prossimità dell'at-
tuale ospedale Birago di Vische, dove erano le prese
del canale dei Molassi.
Da queste osservazioni si può quindi considerare
come, percorrendo le sponde della Dora dal confine
comunale alla confluenza, sia ancora possibile oggi
cogliere la successione storica delle trasformazioni
del tipo d'uso del fiume, che l'ipotesi unificatrice
della pianificazione urbanistica avrebbe invece volu-
to cancellare, sino alla proposta (degli
anni Cin-
quanta) di coprire addirittura il torrente e trasformar-
lo quindi in una grande cloaca urbana.
Per molto tempo sino a tutto il Settecento inve-
ce, il Po, massimo fiume della città, restò sostan-
zialmente ad essa estraneo, dato che l'uso che ne
poteva esser fatto era limitato ai trasporti, sebbene la
navigabilità non fosse certo comparabile a quella dei
grandi fiumi europei, ed il regime la limitasse ulte-
riormente nel corso delle stagioni; inoltre Torino
costituiva, essendo la città più importante, il punto
di arrivo della navigazione fluviale di approvvigio-
namento che quindi doveva avvenire per il tratto a
valle, a natanti carichi e controcorrente (anche se il
De Bartolomeis ci parla di chiatte e barconi con
carichi sino a 60 tonnellate!) mentre nel tratto a
monte della città potevano passare solo trasporti as-
sai meno pesanti: la funzione di via d'acqua del Po
non poteva quindi essere molto rilevante; sappiamo
dagli scritti di Pertinchamp e di Defougères che,
sino alla confluenza con la Dora, esso restava impra-
ticabile dalle « barche da cannoni » di circa dodici
metri, e che nel tratto a monte da Villafranca a Tori-
no potevano navigare solo carichi di un terzo di
metro cubo di mattoni. Quindi, anche se l'iconogra-
fia — da Bellotto alle vedute a volo d'uccello delle
Esposizioni otto e novecentesche talvolta tende a
mostrare il fiume popolato di vele e vapori, scarso
doveva in realtà essere il traffico mercantile, data
anche la mancanza di alzaie e di un porto fluviale
urbano.
Sino al dominio francese d'altra parte il Po era
completamente foraneo all'abitato: attraversato da
un solo ponte diroccato e da precari traghetti, di uno
dei quali, quello in asse al Castello del Valentino,
resta in certo qual modo traccia nella esedra del
giardino sulla sponda opposta. Il rapporto con la
città col fiume invece divenne argomento centrale
nel dibattito urbanistico quando, con l'abbattimento
delle mura, gli ostacoli militari all'espansione urba-
na sino ad esso vennero a mancare: dibattito rilevan-
te dal punto di vista della forma urbana, ma anche da
quello più modesto dell'uso fluviale, sempre ancora
centrato sulla navigabilità, ed estrinsecato in diversi
progetti, da quello di Bonsignore e Lombardi nel
1802, che prevedeva un ampio porto-bacino in riva
sinistra all'altezza di Vanchiglia, a quello di Preglia-
sco, che attraverso una complessa sistemazione di
canali avrebbe voluto dare alla città un carattere
acquatico se non fluviale.
La stessa ubicazione dell'opera più importante
eseguita sul Po dal nostro punto di vista, la diga
Michelotti (18I6), fu a lungo discussa proprio per il
fatto della navigazione: la costruzione della diga
significò certamente, per il vantaggio contingente
che essa arrecava, l'abbandono di ogni progetto di
navigazione del Po da e verso valle. Le motivazioni
della diga erano invece di carattere produttivo: essa
serviva a garantire una adeguata alimentazione al
canale Michelotti, che portava l'acqua motrice ai
Mulini di Città, ubicati all'altezza della Madonna
del Pilone e, prima della costruzione della diga e del
744


















