
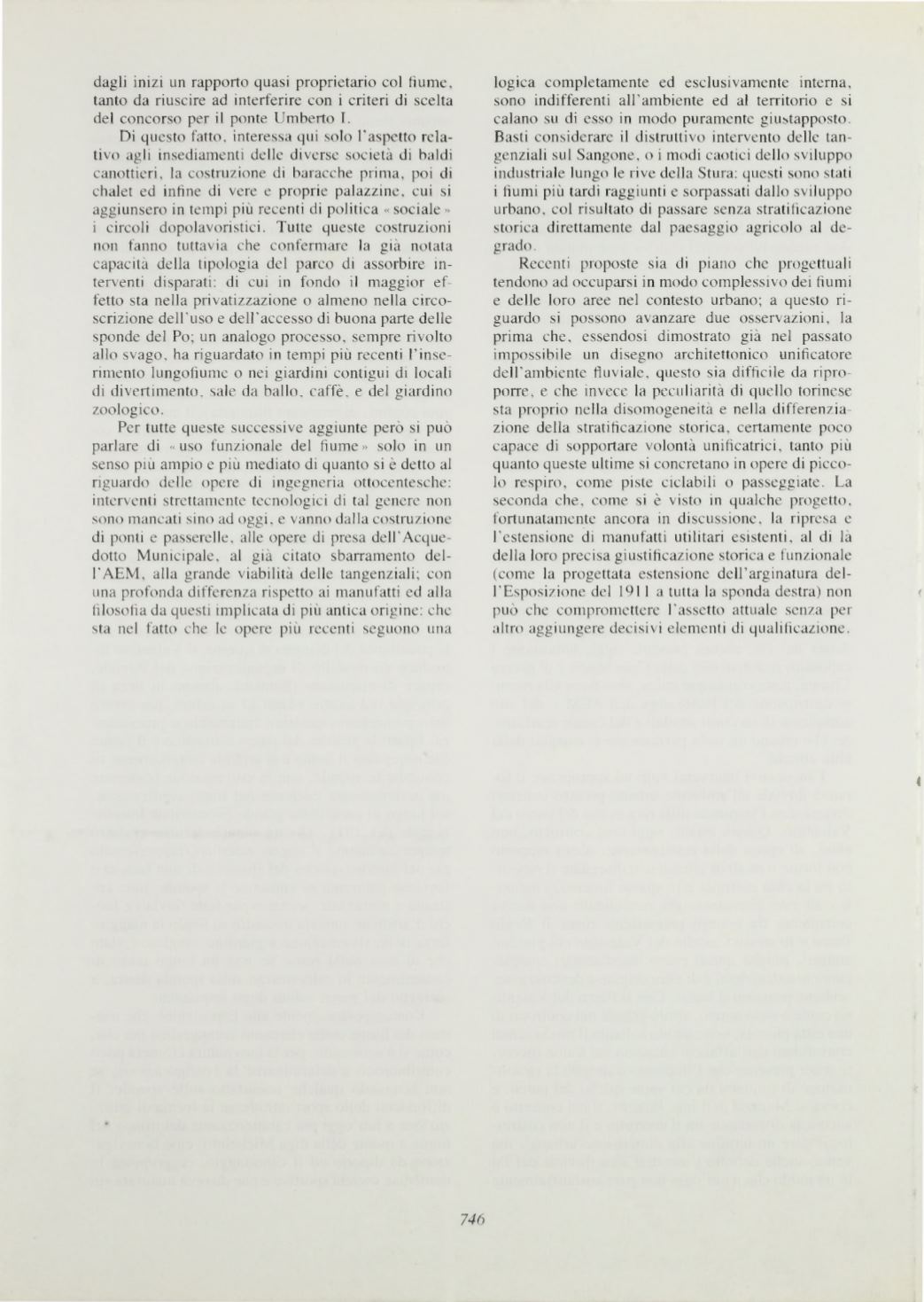
dagli inizi un rapporto quasi proprietario col fiume,
tanto da riuscire ad interferire con i criteri di scelta
del concorso per il ponte Umberto I.
Di questo fatto, interessa qui solo l'aspetto rela-
tivo agli insediamenti delle diverse società di baldi
canottieri, la costruzione di baracche prima, poi di
chalet ed infine di vere e proprie palazzine, cui si
aggiunsero in tempi più recenti di politica « sociale
i circoli dopolavoristici. Tutte queste costruzioni
non fanno tuttavia che confermare la già notata
capacità della tipologia del parco di assorbire in-
terventi disparati: di cui in fondo il maggior ef-
fetto sta nella privatizzazione o almeno nella circo-
scrizione dell'uso e dell'accesso di buona parte delle
sponde del Po; un analogo processo, sempre rivolto
allo svago, ha riguardato in tempi più recenti l'inse-
rimento lungofiume o nei giardini contigui di locali
di divertimento, sale da ballo, caffè, e del giardino
zoologico.
Per tutte queste successive aggiunte però si può
parlare di « uso funzionale del fiume » solo in un
senso più ampio e più mediato di quanto si è detto al
riguardo delle opere di ingegneria ottocentesche:
interventi strettamente tecnologici di tal genere non
sono mancati sino ad oggi, e vanno dalla costruzione
di ponti e passerelle, alle opere di presa dell'Acque-
dotto Municipale, al già citato sbarramento del-
l'AEM, alla grande viabilità delle tangenziali; con
una profonda differenza rispetto ai manufatti ed alla
filosofia da questi implicata di più antica origine: che
sta nel fatto che le opere più recenti seguono una
logica completamente ed esclusivamente interna,
sono indifferenti all'ambiente ed al territorio e si
calano su di esso in modo puramente giustapposto.
Basti considerare il distruttivo intervento delle tan-
genziali sul Sangone, o i modi caotici dello sviluppo
industriale lungo le rive della Stura: questi sono stati
i fiumi più tardi raggiunti e sorpassati dallo sviluppo
urbano, col risultato di passare senza stratificazione
storica direttamente dal paesaggio agricolo al de-
grado.
Recenti proposte sia di piano che progettuali
tendono ad occuparsi in modo complessivo dei fiumi
e delle loro aree nel contesto urbano; a questo ri-
guardo si possono avanzare due osservazioni, la
prima che, essendosi dimostrato già nel passato
impossibile un disegno architettonico unificatore
dell'ambiente fluviale, questo sia difficile da ripro-
porre, e che invece la peculiarità di quello torinese
sta proprio nella disomogeneità e nella differenzia-
zione della stratificazione storica, certamente poco
capace di sopportare volontà unificatrici, tanto più
quanto queste ultime si concretano in opere di picco-
lo respiro, come piste ciclabili o passeggiate. La
seconda che, come si
è
visto in qualche progetto,
fortunatamente ancora in discussione, la ripresa e
l'estensione di manufatti utilitari esistenti, al di là
della loro precisa giustificazione storica e funzionale
(come la progettata estensione dell'arginatura del-
l'Esposizione del 1911 a tutta la sponda destra) non
può che compromettere l'assetto attuale senza per
altro aggiungere decisivi elementi
di
qualificazione.
746


















