
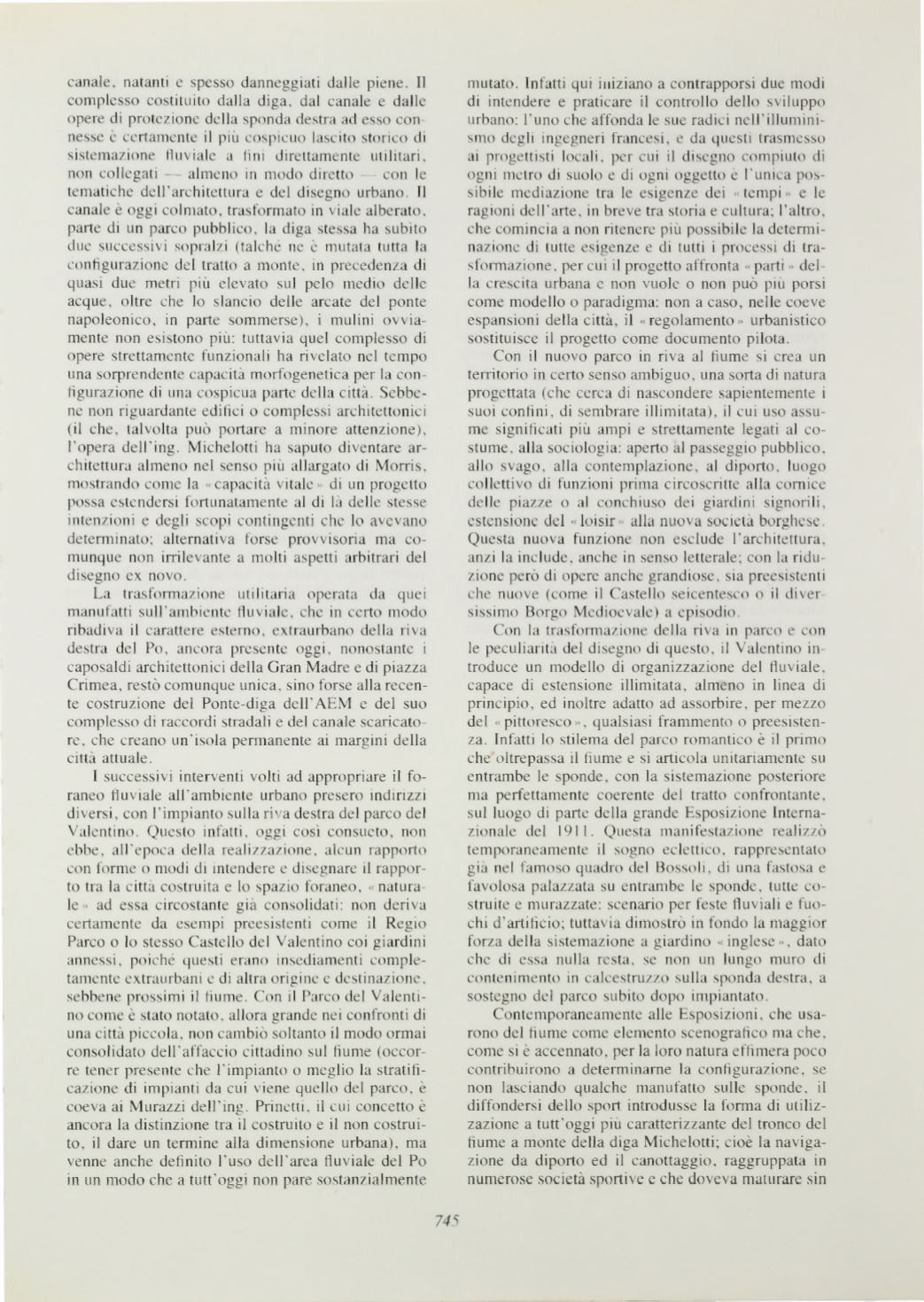
canale, natanti e spesso danneggiati dalle piene. Il
complesso costituito dalla diga, dal canale e dalle
opere di protezione della sponda destra ad esso con-
nesse è certamente il più cospicuo lascito storico di
sistemazione fluviale a fini direttamente utilitari,
non collegati — almeno in modo diretto — con le
tematiche dell'architettura e del disegno urbano. Il
canale è oggi colmato, trasformato in viale alberato,
parte di un parco pubblico, la diga stessa ha subìto
due successivi sopralzi (talché ne è mutata tutta la
configurazione del tratto a monte, in precedenza di
quasi due metri più elevato sul pelo medio delle
acque, oltre che lo slancio delle arcate del ponte
napoleonico, in parte sommerse),
i
mulini ovvia-
mente non esistono più: tuttavia quel complesso di
opere strettamente funzionali ha rivelato nel tempo
una sorprendente capacità morfogenetica per la con-
figurazione di una cospicua parte della città. Sebbe-
ne non riguardante edifici o complessi architettonici
(il che, talvolta può portare a minore attenzione),
l'opera dell'ing. Michelotti ha saputo diventare ar-
chitettura almeno nel senso più allargato di Morris,
mostrando come la « capacità vitale » di un progetto
possa estendersi fortunatamente al di là delle stesse
intenzioni e degli scopi contingenti che lo avevano
determinato; alternativa forse provvisoria ma co-
munque non irrilevante a molti aspetti arbitrari del
disegno ex novo.
La trasformazione utilitaria operata da quei
manufatti sull'ambiente fluviale, che in certo modo
ribadiva il carattere esterno, extraurbano della riva
destra del Po, ancora presente oggi, nonostante
i
caposaldi architettonici della Gran Madre e di piazza
Crimea, restò comunque unica, sino forse alla recen-
te costruzione del Ponte-diga dell'AEM e del suo
complesso di raccordi stradali e del canale scaricato-
re, che creano un'isola permanente ai margini della
città attuale.
I successivi interventi volti ad appropriare il fo-
raneo fluviale all'ambiente urbano presero indirizzi
diversi, con l'impianto sulla riva destra del parco del
Valentino. Questo infatti, oggi così consueto, non
ebbe, all'epoca della realizzazione, alcun rapporto
con forme o modi di intendere e disegnare il rappor-
to tra la città costruita e lo spazio foraneo, « natura-
le » ad essa circostante già consolidati: non deriva
certamente da esempi preesistenti come il Regio
Parco o lo stesso Castello del Valentino coi giardini
annessi, poiché questi erano insediamenti comple-
tamente extraurbani e di altra origine e destinazione,
sebbene prossimi il fiume. Con il Parco del Valenti-
no come è stato notato, allora grande nei confronti di
una città piccola, non cambiò soltanto il modo ormai
consolidato dell'affaccio cittadino sul fiume (occor-
re tener presente che l'impianto o meglio la stratifi-
cazione di impianti da cui viene quello del parco, è
coeva ai Murazzi dell'ing. Prinetti, il
cui
concetto è
ancora la distinzione tra il costruito e il non costrui-
to, il dare un termine alla dimensione urbana), ma
venne anche definito l'uso dell'area fluviale del Po
in un modo che a tutt'oggi non pare sostanzialmente
mutato. Infatti qui iniziano a contrapporsi due modi
di intendere e praticare il controllo dello sviluppo
urbano: l'uno che affonda le sue radici nell'illumini-
smo degli ingegneri francesi, e da questi trasmesso
ai progettisti locali, per cui il disegno compiuto di
ogni metro di suolo e di ogni oggetto è l'unica pos-
sibile mediazione tra le esigenze dei « tempi » e le
ragioni dell'arte, in breve tra storia e cultura; l'altro,
che comincia a non ritenere più possibile la determi-
nazione di tutte esigenze e di tutti i processi di tra-
sformazione, per cui il progetto affronta « parti » del-
la crescita urbana e non vuole o non può più porsi
come modello o paradigma: non a caso, nelle coeve
espansioni della città, il « regolamento » urbanistico
sostituisce il progetto come documento pilota.
Con il nuovo parco in riva al fiume si crea un
territorio in certo senso ambiguo, una sorta di natura
progettata (che cerca di nascondere sapientemente i
suoi confini, di sembrare illimitata), il cui uso assu-
me significati più ampi e strettamente legati al co-
stume, alla sociologia: aperto al passeggio pubblico,
allo svago, alla contemplazione, al diporto, luogo
collettivo di funzioni prima circoscritte alla cornice
delle piazze o al conchiuso dei giardini signorili,
estensione del « loisir» alla nuova società borghese.
Questa nuova funzione non esclude l'architettura,
anzi la include, anche in senso letterale; con la ridu-
zione però di opere anche grandiose, sia preesistenti
che nuove (come il Castello seicentesco o il diver-
sissimo Borgo Medioevale) a episodio.
Con la trasformazione della riva in parco e con
le peculiarità del disegno di questo, il Valentino in-
troduce un modello di organizzazione del fluviale,
capace di estensione illimitata, almeno in linea di
principio, ed inoltre adatto ad assorbire, per mezzo
del «pittoresco», qualsiasi frammento o preesisten-
za. Infatti lo stilema del parco romantico è il primo
che oltrepassa il fiume e si articola unitariamente su
entrambe le sponde, con la sistemazione posteriore
ma perfettamente coerente del tratto confrontante,
sul luogo di parte della grande Esposizione Interna-
zionale del 1911. Questa manifestazione realizzò
temporaneamente il sogno eclettico, rappresentato
già nel famoso quadro del Bossoli, di una fastosa e
favolosa palazzata su entrambe le sponde, tutte co-
struite e murazzate: scenario per feste fluviali e fuo-
chi d'artificio; tuttavia dimostrò in fondo la maggior
forza della sistemazione a giardino «inglese><, dato
che di essa nulla resta,
se
non un lungo muro di
contenimento in calcestruzzo sulla sponda destra, a
sostegno del parco subito dopo impiantato.
Contemporaneamente alle Esposizioni, che usa-
rono del fiume come elemento scenografico ma che,
come si è accennato, per la loro natura effimera poco
contribuirono a determinarne la configurazione, se
non lasciando qualche manufatto sulle sponde, il
diffondersi dello sport introdusse la forma di utiliz-
zazione a tutt'oggi più caratterizzante del tronco del
fiume a monte della diga Michelotti; cioè la naviga-
zione da diporto ed il canottaggio, raggruppata in
numerose società sportive e che doveva maturare sin
745


















