
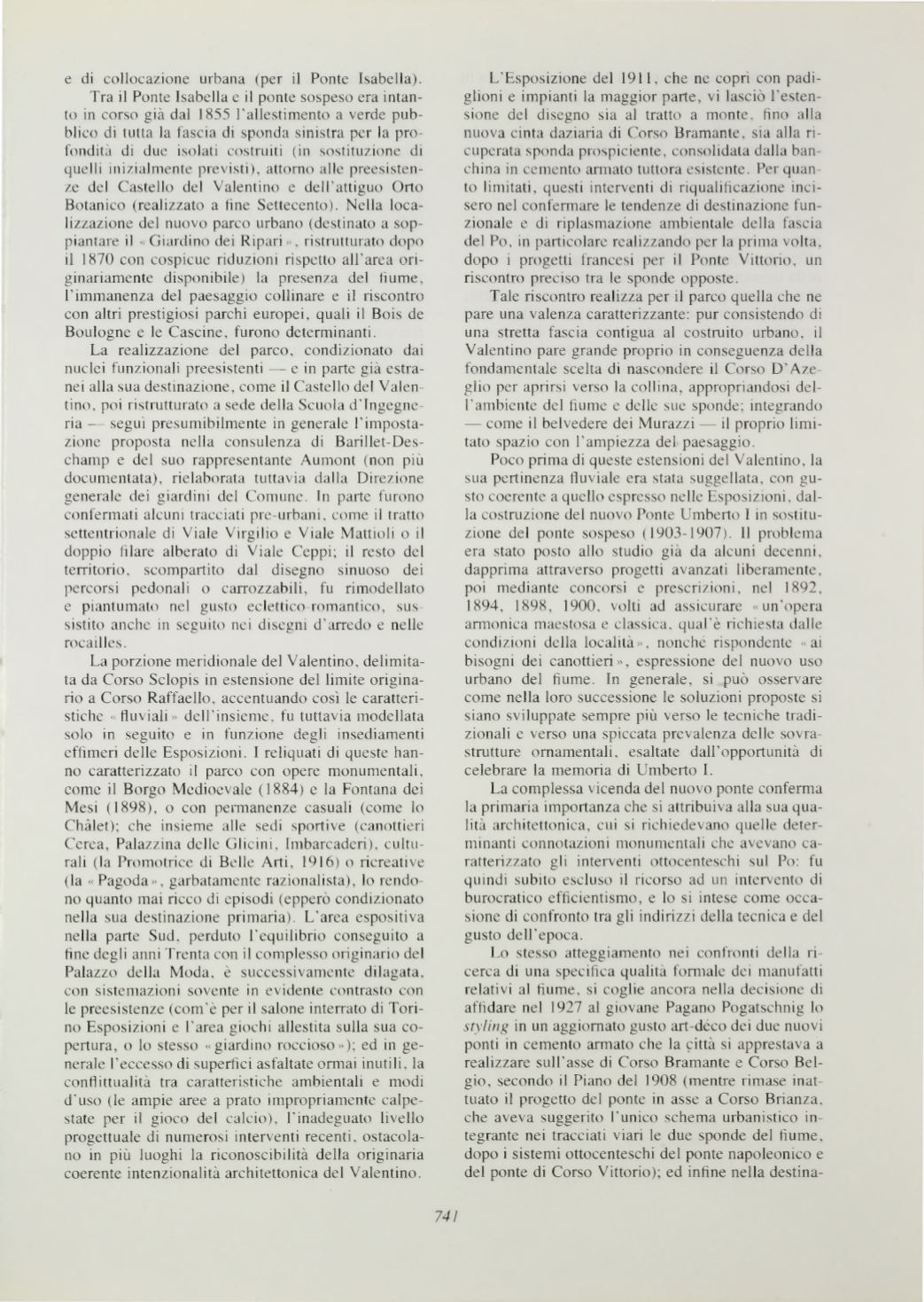
e di collocazione urbana (per il Ponte Isabella).
Tra il Ponte Isabella e il ponte sospeso era intan-
to in corso già dal I855 l'allestimento a verde pub-
blico di tutta la fascia di sponda sinistra per la pro-
fondità di due isolati costruiti (in sostituzione di
quelli inizialmente previsti), attorno alle preesisten-
ze del Castello del Valentino e dell'attiguo Orto
Botanico (realizzato a fine Settecento). Nella loca-
lizzazione del nuovo parco urbano (destinato a sop-
piantare il « Giardino dei Ripari », ristrutturato dopo
il 1870 con cospicue riduzioni rispetto all'area ori-
ginariamente disponibile) la presenza del fiume,
l'immanenza del paesaggio collinare e il riscontro
con altri prestigiosi parchi europei, quali il Bois de
Boulogne e le Cascine, furono determinanti.
La realizzazione del parco, condizionato dai
nuclei funzionali preesistenti — e in parte già estra-
nei alla sua destinazione, come il Castello del Valen-
tino, poi ristrutturato a sede della Scuola d'Ingegne-
ria — seguì presumibilmente in generale l'imposta-
zione proposta nella consulenza di Barillet-Des-
champ e del suo rappresentante Aumont (non più
documentata), rielaborata tuttavia dalla Direzione
generale dei giardini del Comune. In parte furono
confermati alcuni tracciati pre-urbani, come il tratto
settentrionale di Viale Virgilio e Viale Mattioli o il
doppio filare alberato di Viale Ceppi; il resto del
territorio, scompartito dal disegno sinuoso dei
percorsi pedonali o carrozzabili, fu rimodellato
e piantumato nel gusto eclettico-romantico, sus-
sistito anche in seguito nei disegni d'arredo e nelle
rocailles.
La porzione meridionale del Valentino, delimita-
ta da Corso Sclopis in estensione del limite origina-
rio a Corso Raffaello, accentuando così le caratteri-
stiche «fluviali» dell'insieme, fu tuttavia modellata
solo in seguito e in funzione degli insediamenti
effimeri delle Esposizioni. I reliquati di queste han-
no caratterizzato il parco con opere monumentali,
come il Borgo Medioevale (1884) e la Fontana dei
Mesi (1898), o con permanenze casuali (come lo
Chalet); che insieme alle sedi sporlive (canottieri
Cerea, Palazzina delle Glicini, Imbarcaderi), cultu-
rali (la Promotrice di Belle Arti, 1916) o ricreative
(la «Pagoda», garbatamente razionalista), lo rendo-
no quanto mai ricco di episodi (epperò condizionato
nella sua destinazione primaria). L'area espositiva
nella parte Sud, perduto l'equilibrio conseguito a
fine degli anni Trenta con il complesso originario del
Palazzo della Moda, è successivamente dilagata,
con sistemazioni sovente in evidente contrasto con
le preesistenze (com'è per il salone interrato di Tori-
no Esposizioni e l'area giochi allestita sulla sua co-
pertura, o lo stesso «giardino roccioso»); ed in ge-
nerale l'eccesso di superfici asfaltate ormai inutili, la
conflittualità tra caratteristiche ambientali e modi
d'uso (le ampie aree a prato impropriamente calpe-
state per il gioco del calcio), l'inadeguato livello
progettuale di numerosi interventi recenti, ostacola-
no in più luoghi la riconoscibilità della originaria
coerente intenzionalità architettonica del Valentino.
L'Esposizione del 191I, che ne copri con padi-
glioni e impianti la maggior parte, vi lasciò l'esten-
sione del disegno sia al tratto a monte, fino alla
nuova cinta daziaria di Corso Bramante, sia alla ri-
cuperata sponda prospiciente, consolidata dalla ban-
china in cemento armato tuttora esistente. Per quan-
to limitati, questi interventi di riqualificazione inci-
sero nel confermare le tendenze di destinazione fun-
zionale
e
di riplasmazione ambientale della fascia
del Po, in particolare realizzando per la prima volta,
dopo i progetti francesi per il Ponte Vittorio, un
riscontro preciso tra le sponde opposte.
Tale riscontro realizza per il parco quella che ne
pare una valenza caratterizzante: pur consistendo di
una stretta fascia contigua al costruito urbano, il
Valentino pare grande proprio in conseguenza della
fondamentale scelta di nascondere il Corso D'Aze-
glio per aprirsi verso la collina, appropriandosi del-
l'ambiente del fiume e delle sue sponde; integrando
come il belvedere dei Murazzi il proprio limi-
tato spazio con l'ampiezza del paesaggio.
Poco prima di queste estensioni del Valentino, la
sua pertinenza fluviale era stata suggellata, con gu-
sto coerente a quello espresso nelle Esposizioni, dal-
la costruzione del nuovo Ponte Umbe rto I in sostitu-
zione del ponte sospeso (1903-1907). I1 problema
era stato posto allo studio già da alcuni decenni,
dapprima attraverso progetti avanzati liberamente,
poi mediante concorsi e prescrizioni, nel 1892,
1894, 1898, 1900, volti ad assicurare « un'opera
armonica maestosa e classica, qual'è richiesta dalle
condizioni della località», nonché rispondente « ai
bisogni dei canottieri », espressione del nuovo uso
urbano del fiume. In generale, si può osservare
come nella loro successione le soluzioni proposte si
siano sviluppate sempre più verso le tecniche tradi-
zionali e verso una spiccata prevalenza delle sovra-
strutture ornamentali, esaltate dall'opportunità di
celebrare la memoria di Umberto I.
La complessa vicenda del nuovo ponte conferma
la primaria importanza che si attribuiva alla sua qua-
lità architettonica, cui si richiedevano quelle deter-
minanti connotazioni monumentali che avevano ca-
ratterizzato gli interventi ottocenteschi sul Po: fu
quindi subito escluso il ricorso ad un intervento di
burocratico efficientismo, e lo si intese come occa-
sione di confronto tra gli indirizzi della tecnica e del
gusto dell'epoca.
Lo stesso atteggiamento nei confronti della ri-
cerca di una specifica qualità formale dei manufatti
relativi al fiume, si coglie ancora nella decisione di
affidare nel 1927 al giovane Pagano Pogatschnig lo
styting
in un aggiornato gusto art-déco dei due nuovi
ponti in cemento armato che la città si apprestava a
realizzare sull'asse di Corso Bramante e Corso Bel-
gio, secondo il Piano del 1908 (mentre rimase inat-
tuato il progetto del ponte in asse a Corso Brianza,
che aveva suggerito l'unico schema urbanistico in-
tegrante nei tracciati viari le due sponde del fiume,
dopo i sistemi ottocenteschi del ponte napoleonico e
del ponte di Corso Vittorio); ed infine nella destina-
741


















