
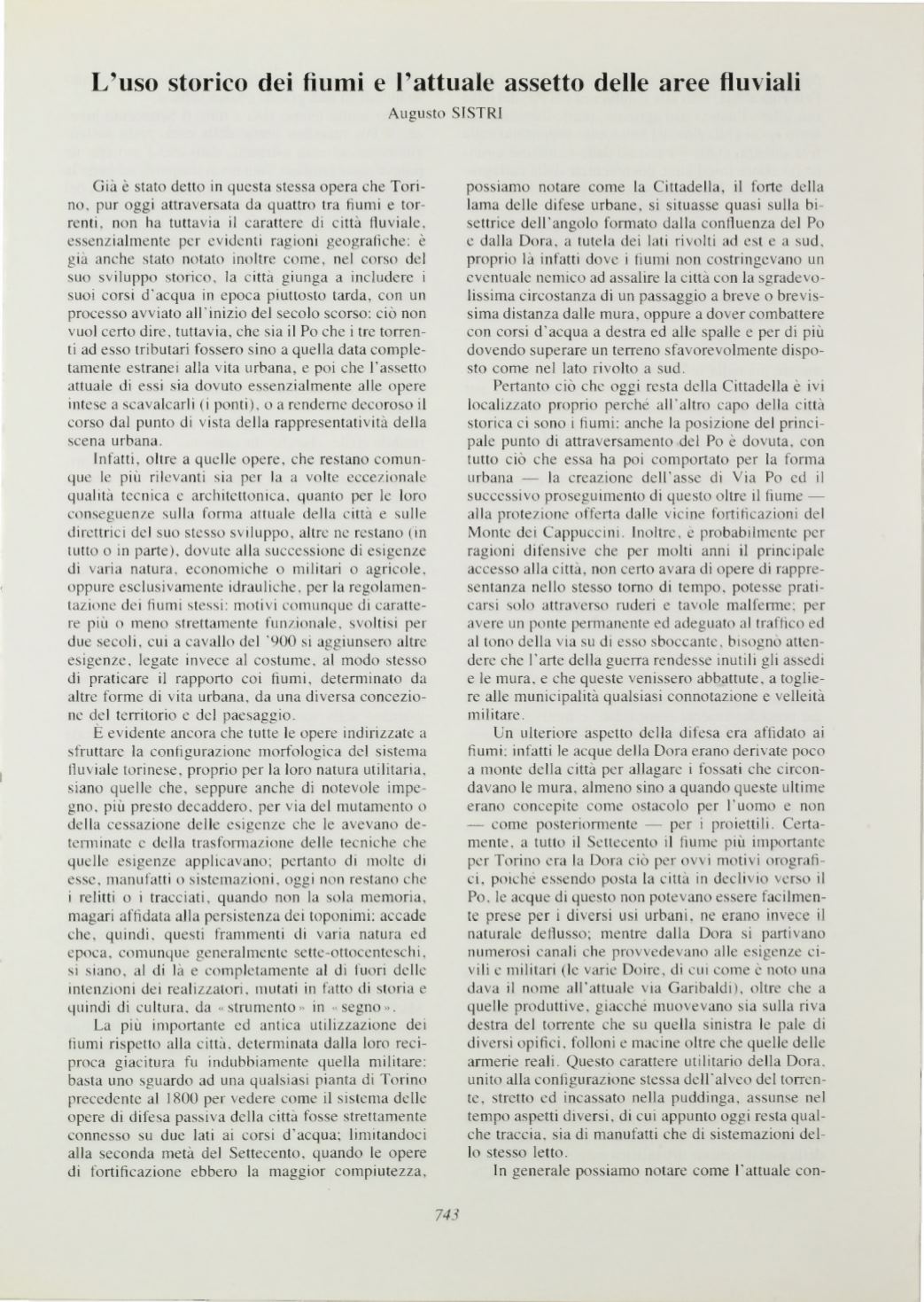
L'uso storico dei fiumi e l'attuale assetto delle aree fluviali
Augusto SISTRI
Già è stato detto in questa stessa opera che Tori-
no, pur oggi attraversata da quattro tra fiumi e tor-
renti, non ha tuttavia il carattere di città fluviale,
essenzialmente per evidenti ragioni geografiche: è
già anche stato notato inoltre come, nel corso del
suo sviluppo storico, la città giunga a includere i
suoi corsi d'acqua in epoca piuttosto tarda, con un
processo avviato all'inizio del secolo scorso: ciò non
vuol certo dire, tuttavia, che sia il Po che i tre torren-
ti ad esso tributari fossero sino a quella data comple-
tamente estranei alla vita urbana, e poi che l'assetto
attuale di essi sia dovuto essenzialmente alle opere
intese a scavalcarli (i ponti), o a renderne decoroso il
corso dal punto di vista della rappresentatività della
scena urbana.
Infatti, oltre a quelle opere, che restano comun-
que le più rilevanti sia per la a volte eccezionale
qualità tecnica e architettonica, quanto per le loro
conseguenze sulla forma attuale della città e sulle
direttrici del suo stesso sviluppo, altre ne restano (in
tutto o in parte), dovute alla successione di esigenze
di varia natura, economiche o militari o agricole,
oppure esclusivamente idrauliche, per la regolamen-
tazione dei fiumi stessi: motivi comunque di caratte-
re più o meno strettamente funzionale, svoltisi per
due secoli, cui a cavallo del '900 si aggiunsero altre
esigenze, legate invece al costume, al modo stesso
di praticare il rapporto coi fiumi, determinato da
altre forme di vita urbana, da una diversa concezio-
ne del territorio e del paesaggio.
È evidente ancora che tutte le opere indirizzate a
sfruttare la configurazione morfologica del sistema
fluviale torinese, proprio per la loro natura utilitaria,
siano quelle che, seppure anche di notevole impe-
gno, più presto decaddero, per via del mutamento o
della cessazione delle esigenze che le avevano de-
terminate e della trasformazione delle tecniche che
quelle esigenze applicavano; pertanto di molte di
esse, manufatti o sistemazioni, oggi non restano che
i relitti o i tracciati, quando non la sola memoria,
magari affidata alla persistenza dei toponimi: accade
che, quindi, questi frammenti di varia natura ed
epoca, comunque generalmente sette-ottocenteschi,
si siano, al di là e completamente al di fuori delle
intenzioni dei realizzatori, mutati in fatto di storia e
quindi di cultura, da «strumento» in «segno».
La più importante ed antica utilizzazione dei
fiumi rispetto alla città, determinata dalla loro reci-
proca giacitura fu indubbiamente quella militare:
basta uno sguardo ad una qualsiasi pianta di Torino
precedente al 1800 per vedere come il sistema delle
opere di difesa passiva della città fosse strettamente
connesso su due lati ai corsi d'acqua; limitandoci
alla seconda metà del Settecento, quando le opere
di fortificazione ebbero la maggior compiutezza,
possiamo notare come la Cittadella, il forte della
lama delle difese urbane, si situasse quasi sulla bi-
settrice dell'angolo formato dalla confluenza del Po
e dalla Dora, a tutela dei lati rivolti ad est e a sud,
proprio là infatti dove i fiumi non costringevano un
eventuale nemico ad assalire la città con la sgradevo-
lissima circostanza di un passaggio a breve o brevis-
sima distanza dalle mura, oppure a dover combattere
con corsi d'acqua a destra ed alle spalle e per di più
dovendo superare un terreno sfavorevolmente dispo-
sto come nel lato rivolto a sud.
Pertanto ciò che oggi resta della Cittadella è ivi
localizzato proprio perché all'altro capo della città
storica ci sono i fiumi: anche la posizione del princi-
pale punto di attraversamento del Po è dovuta, con
tutto ciò che essa ha poi comportato per la forma
urbana — la creazione dell'asse di Via Po ed il
successivo proseguimento di questo oltre il fiume
alla protezione offerta dalle vicine fortificazioni del
Monte dei Cappuccini. Inoltre,
è
probabilmente per
ragioni difensive che per molti anni il principale
accesso alla città, non certo avara di opere di rappre-
sentanza nello stesso torno di tempo, potesse prati-
carsi solo attraverso ruderi e tavole malferme; per
avere un ponte permanente ed adeguato al traffico ed
al tono della via su di esso sboccante, bisognò atten-
dere che l'arte della guerra rendesse inutili gli assedi
e le mura, e che queste venissero abbattute, a toglie-
re alle municipalità qualsiasi connotazione e velleità
militare.
Un ulteriore aspetto della difesa era affidato ai
fiumi: infatti le acque della Dora erano derivate poco
a monte della città per allagare i fossati che circon-
davano le mura, almeno sino a quando queste ultime
erano concepite come ostacolo per l'uomo e non
— come posteriormente — per i proiettili. Certa-
mente, a tutto il Settecento il fiume più importante
per Torino era la Dora ciò per ovvi motivi orografi-
ci, poiché essendo posta la città in declivio verso il
Po, le acque di questo non potevano essere facilmen-
te prese per i diversi usi urbani, ne erano invece il
naturale deflusso; mentre dalla Dora si partivano
numerosi canali che provvedevano alle esigenze ci-
vili e militari (le varie Doire, di cui come è noto una
dava il nome all'attuale via Garibaldi), oltre che a
quelle produttive, giacché muovevano sia sulla riva
destra del torrente che su quella sinistra le pale di
diversi opifici, folloni e macine oltre che quelle delle
armerie reali. Questo carattere utilitario della Dora,
unito alla configurazione stessa dell'alveo del torren-
te, stretto ed incassato nella puddinga, assunse nel
tempo aspetti diversi, di cui appunto oggi resta qual-
che traccia, sia di manufatti che di sistemazioni del-
lo stesso letto.
In generale possiamo notare come l'attuale con-
743


















