
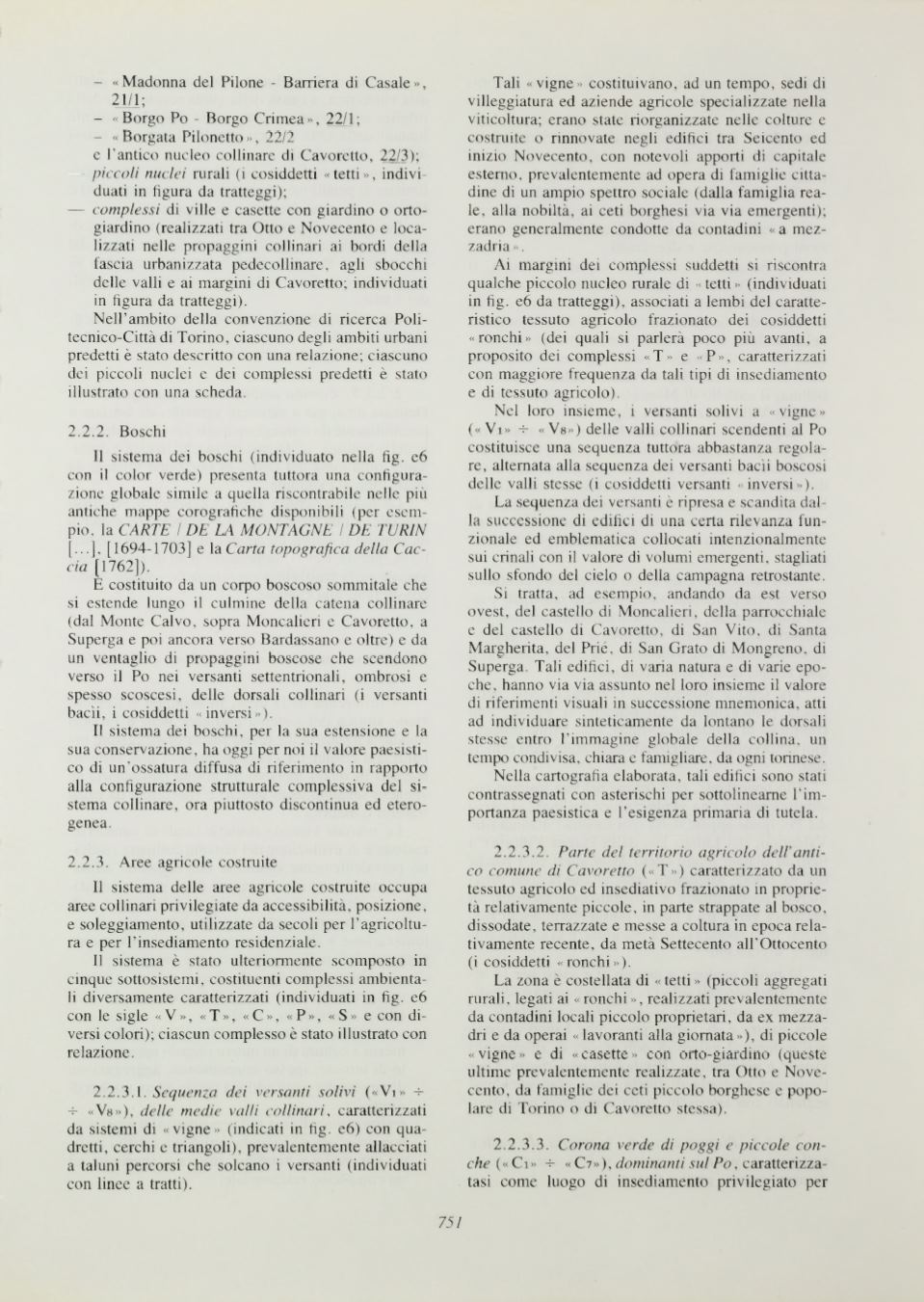
—« Madonna del Pilone - Barriera di
Casale'>,
21/1;
—« Borgo Po - Borgo
Crimea»,
22/1;
—« Borgata Pilonetto », 22/2
e l'antico nucleo collinare di Cavoretto,
22/3);
— piccoti nuctei
rurali (i cosiddetti « tetti », indivi-
duati in figura da tratteggi);
- complessi
di ville e casette con giardino o orto-
giardino (realizzati tra Otto e Novecento e loca-
lizzati nelle propaggini collinari ai bordi della
fascia urbanizzata pedecollinare, agli sbocchi
delle valli e ai margini di Cavoretto; individuati
in figura da tratteggi).
Nell'ambito della convenzione di ricerca Poli-
tecnico-Città di Torino, ciascuno degli ambiti urbani
predetti è stato descritto con una relazione; ciascuno
dei piccoli nuclei e dei complessi predetti è stato
illustrato con una scheda.
2.2.2. Boschi
Il sistema dei boschi (individuato nella fig. e6
con il color verde) presenta tuttora una configura-
zione globale simile a quella riscontrabile nelle più
antiche mappe corografiche disponibili (per esem-
pio, la
CARTE I DE LA MONTAGNE I DE TURIN
[ ... ] , [ 1694-1703]
e la
Carta topografica detta Cac-
cia
[17621).
E costituito da un corpo boscoso sommitale che
si estende lungo il culmine della catena collinare
(dal Monte Calvo, sopra Moncalieri e Cavoretto, a
Superga e poi ancora verso Bardassano e oltre) e da
un ventaglio di propaggini boscose che scendono
verso il Po nei versanti settentrionali, ombrosi e
spesso scoscesi, delle dorsali collinari (i versanti
bacii, i cosiddetti «inversi»).
Il
sistema dei boschi, per la sua estensione e la
sua conservazione, ha oggi per noi il valore paesisti-
co di un'ossatura diffusa di riferimento in rapporto
alla configurazione strutturale complessiva del si-
stema collinare, ora piuttosto discontinua ed etero-
genea.
2.2.3. Aree agricole costruite
Il sistema delle aree agricole costruite occupa
aree collinari privilegiate da accessibilità, posizione,
e soleggiamento, utilizzate da secoli per l'agricoltu-
ra e per l'insediamento residenziale.
Il sistema è stato ulteriormente scomposto in
cinque sottosistemi, costituenti complessi ambienta-
li diversamente caratterizzati (individuati in fig. e6
con le sigle «V»,
«T», «C», «P»,
«S» e con di-
versi colori); ciascun complesso è stato illustrato con
relazione.
2.2.3.1.
Sequenza dei versanti solivi
(«Vi»
«V8»),
detle medie vatti cottinari,
caratterizzati
da sistemi di « vigne » (indicati in fig. e6) con qua-
dretti, cerchi e triangoli), prevalentemente allacciati
a taluni percorsi che solcano i versanti (individuati
con linee a tratti).
Tali « vigne » costituivano, ad un tempo, sedi di
villeggiatura ed aziende agricole specializzate nella
viticoltura; erano state riorganizzate nelle colture e
costruite o rinnovate negli edifici tra Seicento ed
inizio Novecento, con notevoli apporti di capitale
esterno, prevalentemente ad opera di famiglie citta-
dine di un ampio spettro sociale (dalla famiglia rea-
le, alla nobiltà, ai ceti borghesi via via emergenti);
erano generalmente condotte da contadini « a mez-
zadria»
Ai margini dei complessi suddetti si riscontra
qualche piccolo nucleo rurale di « tetti » (individuati
in fig. e6 da tratteggi), associati a lembi del caratte-
ristico tessuto agricolo frazionato dei cosiddetti
«ronchi» (dei quali si parlerà poco più avanti, a
proposito dei complessi «T» e «P», caratterizzati
con maggiore frequenza da tali tipi di insediamento
e di tessuto agricolo).
Nel loro insieme, i versanti solivi a « vigne »
(« Vi» ± « Va») delle valli collinari scendenti al Po
costituisce una sequenza tuttora abbastanza regola-
re, alternata alla sequenza dei versanti bacii boscosi
delle valli stesse (i cosiddetti versanti «inversi »).
La sequenza dei versanti è ripresa e scandita dal-
la successione di edifici di una certa rilevanza fun-
zionale ed emblematica collocati intenzionalmente
sui crinali con il valore di volumi emergenti, stagliati
sullo sfondo del cielo o della campagna retrostante.
Si tratta, ad esempio, andando da est verso
ovest, del castello di Moncalieri, della parrocchiale
e del castello di Cavoretto, di San Vito, di Santa
Margherita, del Prié, di San Grato di Mongreno, di
Superga. Tali edifici, di varia natura e di varie epo-
che, hanno via via assunto nel loro insieme il valore
di riferimenti visuali in successione mnemonica, atti
ad individuare sinteticamente da lontano le dorsali
stesse entro l'immagine globale della collina, un
tempo condivisa, chiara e famigliare, da ogni torinese.
Nella cartografia elaborata, tali edifici sono stati
contrassegnati con asterischi per sottolinearne l'im-
portanza paesistica e l'esigenza primaria di tutela.
2.2.3.2.
Parte det territorio agricolo dell'anti-
co comune di Cavoretto («T
») caratterizzato da un
tessuto agricolo ed insediativo frazionato in proprie-
tà relativamente piccole, in parte strappate al bosco,
dissodate, terrazzate e messe a coltura in epoca rela-
tivamente recente, da metà Settecento all'Ottocento
(i cosiddetti «ronchi»).
La zona è costellata di « tetti » (piccoli aggregati
rurali, legati ai «ronchi», realizzati prevalentemente
da contadini locali piccolo proprietari, da ex mezza-
dri e da operai « lavoranti alla giornata»), di piccole
vigne » e di « casette » con orto-giardino (queste
ultime prevalentemente realizzate, tra Otto e Nove-
cento, da famiglie dei ceti piccolo borghese e popo-
lare di Torino o di Cavoretto stessa).
2.2.3.3.
Corona verde di poggi e piccole con-
che («
Ci» – «C7»),
dominanti sul Po,
caratterizza-
tasi come luogo di insediamento privilegiato per
751


















