
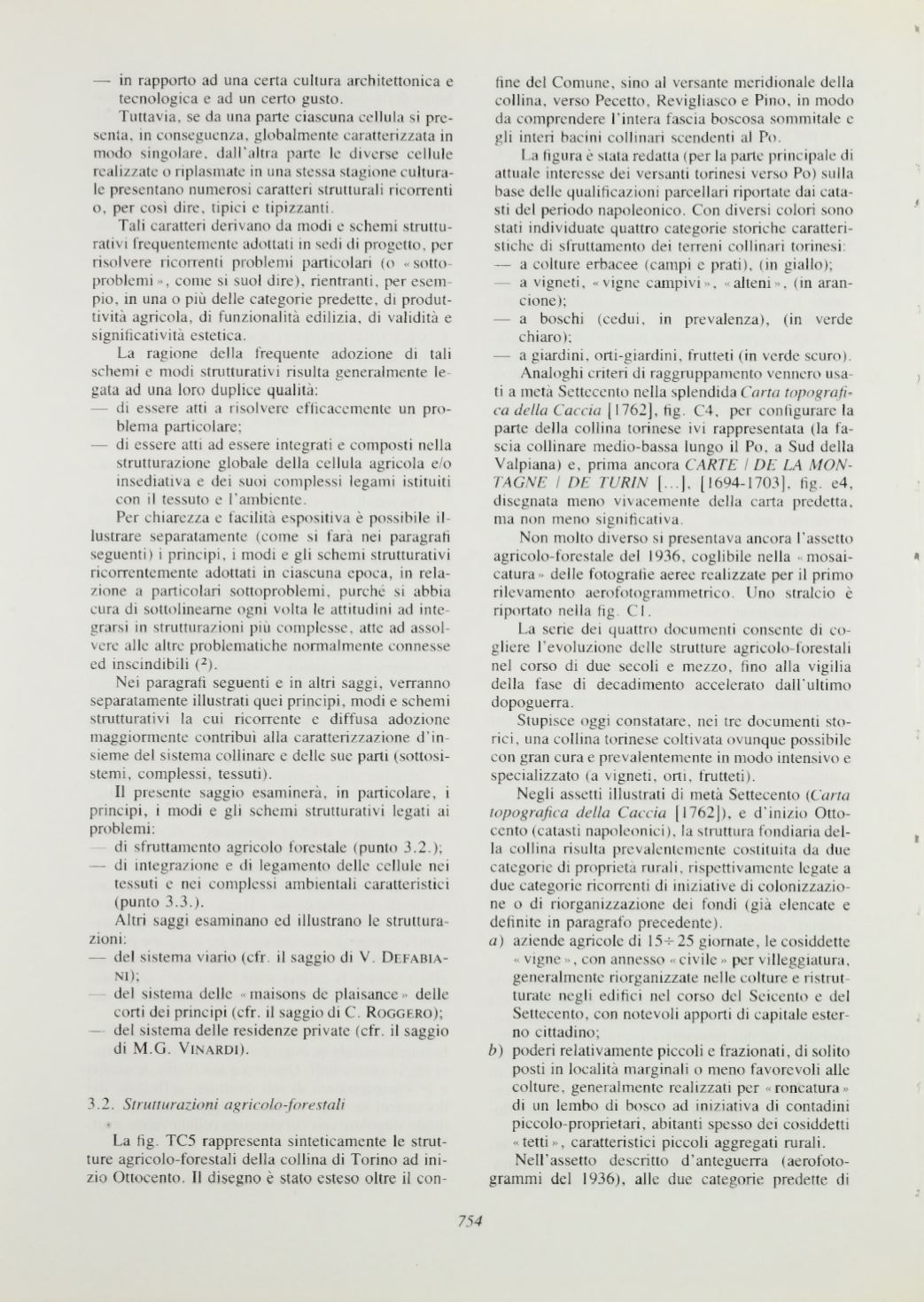
— in rapporto ad una certa cultura architettonica e
tecnologica e ad un certo gusto.
Tuttavia, se da una parte ciascuna cellula si pre-
senta, in conseguenza, globalmente caratterizzata in
modo singolare, dall'altra parte le diverse cellule
realizzate o riplasmate in una stessa stagione cultura-
le presentano numerosi caratteri strutturali ricorrenti
o, per così dire, tipici e tipizzanti.
Tali caratteri derivano da modi e schemi struttu-
rativi frequentemente adottati in sedi di progetto, per
risolvere ricorrenti problemi particolari (o « sotto-
problemi », come si suol dire), rientranti, per esem-
pio, in una o più delle categorie predette, di produt-
tività agricola, di funzionalità edilizia, di validità e
significatività estetica.
La ragione della frequente adozione di tali
schemi e modi strutturativi risulta generalmente le-
gata ad una loro duplice qualità:
- di essere atti a risolvere efficacemente un pro-
blema particolare;
— di essere atti ad essere integrati e composti nella
strutturazione globale della cellula agricola e/o
insediativa e dei suoi complessi legami istituiti
con il tessuto e l'ambiente.
Per chiarezza e facilità espositiva è possibile il-
lustrare separatamente (come si farà nei paragrafi
seguenti) i principi, i modi e gli schemi strutturativi
ricorrentemente adottati in ciascuna epoca, in rela-
zione a particolari sottoproblemi, purché si abbia
cura di sottolinearne ogni volta le attitudini ad inte-
grarsi in strutturazioni più complesse, atte ad assol-
vere alle altre problematiche normalmente connesse
ed inscindibili (
2
).
Nei paragrafi seguenti e in altri saggi, verranno
separatamente illustrati quei principi, modi e schemi
strutturativi la cui ricorrente e diffusa adozione
maggiormente contribuì alla caratterizzazione d'in-
sieme del sistema collinare e delle sue parti (sottosi-
stemi, complessi, tessuti).
Il presente saggio esaminerà, in particolare, i
principi, i modi e gli schemi strutturativi legati ai
problemi:
- di sfruttamento agricolo forestale (punto 3.2.);
— di integrazione e di legamento delle cellule nei
tessuti e nei complessi ambientali caratteristici
(punto 3.3.).
Altri saggi esaminano ed illustrano le struttura-
zion i:
— del sistema viario (cfr. il saggio di V. DEFABIA-
NI);
— del sistema delle «maisons de plaisance» delle
corti dei principi (cfr. il saggio di C. ROGGERo);
— del sistema delle residenze private (cfr. il saggio
di M.G. VINARDI).
3.2.
Strutturazioni agricolo forestali
La fig. TC5 rappresenta sinteticamente le strut-
ture agricolo-forestali della collina di Torino ad ini-
zio Ottocento. Il disegno
è
stato esteso oltre il con-
fine del Comune, sino al versante meridionale della
collina, verso Pecetto, Revigliasco e Pino, in modo
da comprendere l'intera fascia boscosa sommitale e
gli interi bacini collinari scendenti al Po.
La figura è stata redatta (per la parte principale di
attuale interesse dei versanti torinesi verso Po) sulla
base delle qualificazioni parcellari riportate dai cata-
sti del periodo napoleonico. Con diversi colori sono
stati individuate quattro categorie storiche caratteri-
stiche di sfruttamento dei terreni collinari torinesi:
a colture erbacee (campi e prati), (in giallo);
a vigneti, « vigne campivi » , « alieni », (in aran-
cione);
a boschi (cedui, in prevalenza), (in verde
chiaro);
a giardini, orti-giardini, frutteti (in verde scuro).
Analoghi criteri di raggruppamento vennero usa-
ti a metà Settecento nella splendida
Carta topografi-
ca detta Caccia [ 1762],
fig. C4, per configurare la
parte della collina torinese ivi rappresentata (la fa-
scia collinare medio-bassa lungo il Po, a Sud della
Valpiana) e, prima ancora
CARTE l DE LA MON-
TAGNE / DE TURIN [...], [
1694-1703], fig. e4,
disegnata meno vivacemente della carta predetta,
ma non meno significativa.
Non molto diverso si presentava ancora l'assetto
agricolo-forestale del 1936, coglibile nella « mosai-
catura » delle fotografie aeree realizzate per il primo
rilevamento aerofotogrammetrico. Uno stralcio è
riportato nella fig. Cl.
La serie dei quattro documenti consente di co-
gliere l'evoluzione delle strutture agricolo-forestali
nel corso di due secoli e mezzo, fino alla vigilia
della fase di decadimento accelerato dall'ultimo
dopoguerra.
Stupisce oggi constatare, nei tre documenti sto-
rici, una collina torinese coltivata ovunque possibile
con gran cura e prevalentemente in modo intensivo e
specializzato (a vigneti, orti, frutteti).
Negli assetti illustrati di metà Settecento
(Carta
topografica delta Caccia
[17621), e d'inizio Otto-
cento (catasti napoleonici), la struttura fondiaria del-
la collina risulta prevalentemente costituita da due
categorie di proprietà rurali, rispettivamente legate a
due categorie ricorrenti di iniziative di colonizzazio-
ne o di riorganizzazione dei fondi (già elencate e
definite in paragrafo precedente).
a) aziende agricole di 15-- 25 giornate, le cosiddette
« vigne » , con annesso « civile » per villeggiatura,
generalmente riorganizzate nelle colture e ristrut-
turate negli edifici nel corso del Seicento e del
Settecento, con notevoli apporti di capitale ester-
no cittadino;
b) poderi relativamente piccoli e frazionati, di solito
posti in località marginali o meno favorevoli alle
colture, generalmente realizzati per « roncatura»
di un lembo di bosco ad iniziativa di contadini
piccolo-proprietari, abitanti spesso dei cosiddetti
tetti » , caratteristici piccoli aggregati rurali.
Nell'assetto descritto d'anteguerra (aerofoto-
grammi del 1936), alle due categorie predette di
754


















