
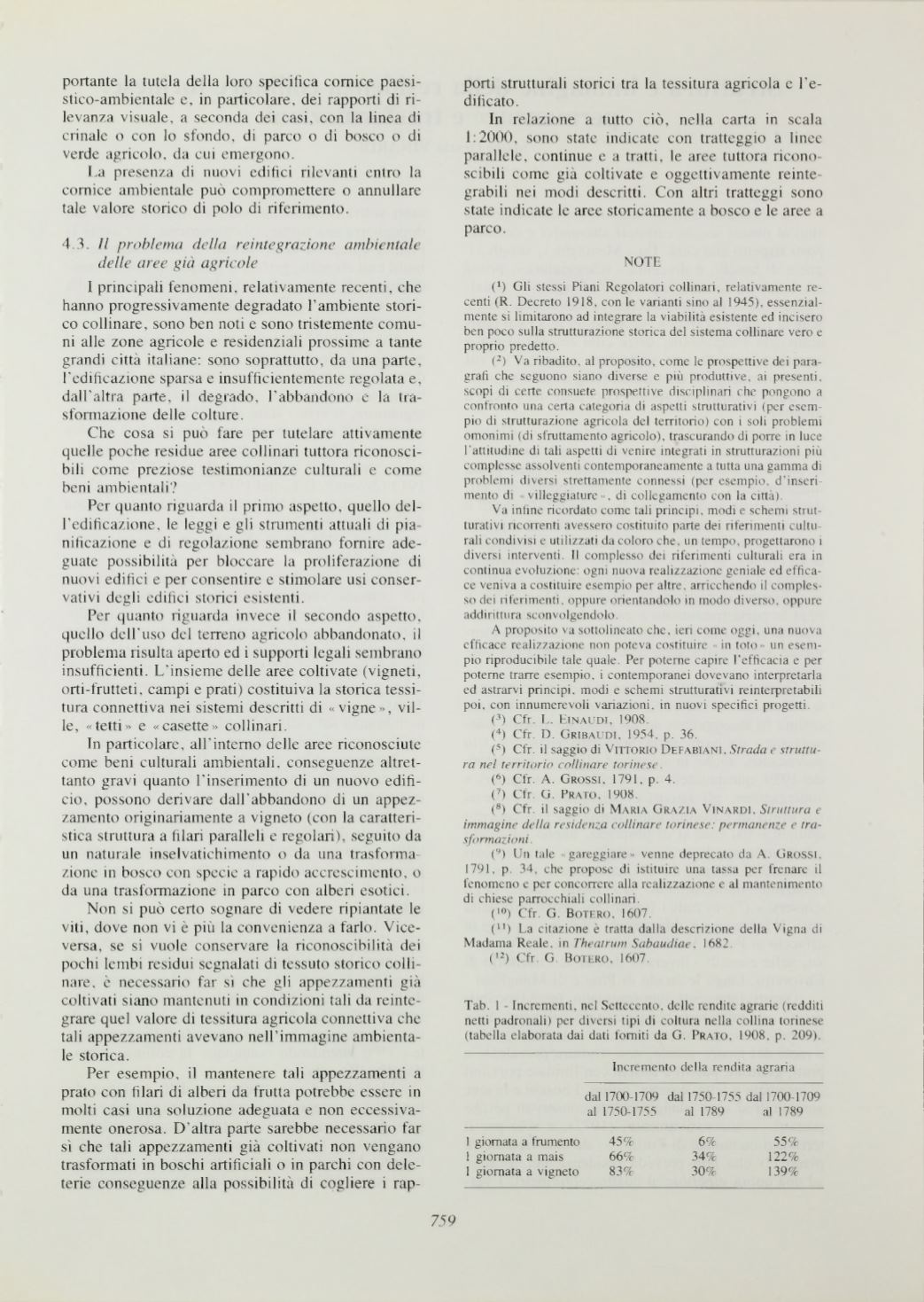
portante la tutela della loro specifica cornice paesi-
stico-ambientale e, in particolare, dei rapporti di ri-
levanza visuale, a seconda dei casi, con la linea di
crinale o con lo sfondo, di parco o di bosco o di
verde agricolo, da cui emergono.
La presenza di nuovi edifici rilevanti entro la
cornice ambientale può compromettere o annullare
tale valore storico di polo di riferimento.
4.3.
Il problema delta reintegrazione ambientate
detle aree già agricole
I
principali fenomeni, relativamente recenti, che
hanno progressivamente degradato l'ambiente stori-
co collinare, sono ben noti e sono tristemente comu-
ni alle zone agricole e residenziali prossime a tante
grandi città italiane: sono soprattutto, da una parte,
l'edificazione sparsa e insufficientemente regolata e,
dall'altra parte, il degrado, l'abbandono e la tra-
sformazione delle colture.
Che cosa si può fare per tutelare attivamente
quelle poche residue aree collinari tuttora riconosci-
bili come preziose testimonianze culturali e come
beni ambientali?
Per quanto riguarda il primo aspetto, quello del-
l'edificazione, le leggi e gli strumenti attuali di pia-
nificazione e di regolazione sembrano fornire ade-
guate possibilità per bloccare la proliferazione di
nuovi edifici e per consentire e stimolare usi conser-
vativi degli edifici storici esistenti.
Per quanto riguarda invece il secondo aspetto,
quello dell'uso del terreno agricolo abbandonato, il
problema risulta aperto ed i supporti legali sembrano
insufficienti. L'insieme delle aree coltivate (vigneti,
orti-frutteti, campi e prati) costituiva la storica tessi-
tura connettiva nei sistemi descritti di « vigne » , vil-
le, «
tetti» e «casette»
collinari.
In particolare, all'interno delle aree riconosciute
come beni culturali ambientali, conseguenze altret-
tanto gravi quanto l'inserimento di un nuovo edifi-
cio, possono derivare dall'abbandono di un appez-
zamento originariamente a vigneto (con la caratteri-
stica struttura a filari paralleli e regolari), seguito da
un naturale inselvatichimento o da una trasforma-
zione in bosco con specie a rapido accrescimento, o
da una trasformazione in parco con alberi esotici.
Non si può certo sognare di vedere ripiantate le
viti, dove non vi
è
più la convenienza a farlo. Vice-
versa, se si vuole conservare la riconoscibilità dei
pochi lembi residui segnalati di tessuto storico colli-
nare, è necessario far sì che gli appezzamenti già
coltivati siano mantenuti in condizioni tali da reinte-
grare quel valore di tessitura agricola connettiva che
tali appezzamenti avevano nell'immagine ambienta-
le storica.
Per esempio, il mantenere tali appezzamenti a
prato con filari di alberi da frutta potrebbe essere in
molti casi una soluzione adeguata e non eccessiva-
mente onerosa. D'altra parte sarebbe necessario far
sì che tali appezzamenti già coltivati non vengano
trasformati in boschi artificiali o in parchi con dele-
terie conseguenze alla possibilità di cogliere i rap-
porti strutturali storici tra la tessitura agricola e l'e-
dificato.
In relazione a tutto ciò, nella carta in scala
1:2000, sono state indicate con tratteggio a linee
parallele, continue e a tratti, le aree tuttora ricono-
scibili come già coltivate e oggettivamente reinte-
grabili nei modi descritti. Con altri tratteggi sono
state indicate le aree storicamente a bosco e le aree a
parco.
NOTE
(1) Gli stessi Piani Regolatori collinari, relativamente re-
centi
(R.
Decreto 1918, con le varianti sino al 1945), essenzial-
mente si limitarono ad integrare la viabilità esistente ed incisero
ben poco sulla strutturazione storica del sistema collinare vero e
proprio predetto.
(2) Va ribadito, al proposito, come le prospettive dei para-
grafi che seguono siano diverse e più produttive, ai presenti,
scopi di certe consuete prospettive disciplinari che pongono a
confronto una certa categoria di aspetti strutturativi (per esem-
pio di strutturazione agricola del territorio) con i soli problemi
omonimi (di sfruttamento agricolo), trascurando di porre in luce
l'attitudine di tali aspetti di venire integrati in strutturazioni più
complesse assolventi contemporaneamente a tutta una gamma di
problemi diversi strettamente connessi (per esempio, d'inseri-
mento di «villeggiature», di collegamento con la città).
Va infine ricordato come tali principi, modi e schemi strut-
turativi ricorrenti avessero costituito parte dei riferimenti cultu-
rali condivisi e utilizzati da coloro che, un tempo, progettarono i
diversi interventi. II complesso dei riferimenti culturali era in
continua evoluzione: ogni nuova realizzazione geniale ed effica-
ce veniva a costituire esempio per altre, arricchendo il comples-
so dei riferimenti, oppure orientandolo in modo diverso, oppure
addirittura sconvolgendolo.
A proposito va sottolineato che, ieri come oggi, una nuova
efficace realizzazione non poteva costituire « in toto» un esem-
pio riproducibile tale quale. Per poterne capire l'efficacia e per
poterne trarre esempio, i contemporanei dovevano interpretarla
ed astrarvi principi, modi e schemi strutturativi reinterpretabili
poi, con innumerevoli variazioni, in nuovi specifici progetti.
(3) Cfr. L.
EINAUDt,
1908.
(4) Cfr. D.
GRIBAUDI,
1954, p. 36.
(5) Cfr. il saggio di
VITTORIO DEFABIANI,
Strada e struttu-
ra nel territorio collinare torinese.
(6) Cfr. A.
GROsSI,
1791, p. 4.
(7) Cfr. G.
PRATO,
1908.
(8) Cfr. il saggio di
MARIA GRAZIA VINARDI,
Struttura e
immagine della residenza coltinare torinese: permanenze e tra-
sformazioni.
(
9
)
Un tale «gareggiare» venne deprecato da A.
GRossI,
1791, p. 34, che propose di istituire una tassa per frenare il
fenomeno e per concorrere alla realizzazione e al mantenimento
di chiese parrocchiali collinari.
(
1
°) Cfr. G.
BOTERO,
1607.
(") La citazione è tratta dalla descrizione della Vigna
di
Madama Reale, in
Theatrum Sabaudiae,
1682.
(
12
) Cfr. G.
BOTERO,
1607.
Tab. 1 - Incrementi, nel Settecento, delle rendite agrarie (redditi
netti padronali) per diversi tipi di coltura nella collina torinese
(tabella elaborata dai dati forniti da G.
PRATO,
1908, p. 209).
Incremento della rendita agraria
dal 1700-1709 dal 1750-1755 dal 1700-1709
al
1750-1755 al 1789
al
1789
1 giornata a frumento
45%
6%
55%
1 giornata a mais
66%
34% 122%
I
giornata a vigneto
83%
30% 139%
759


















