
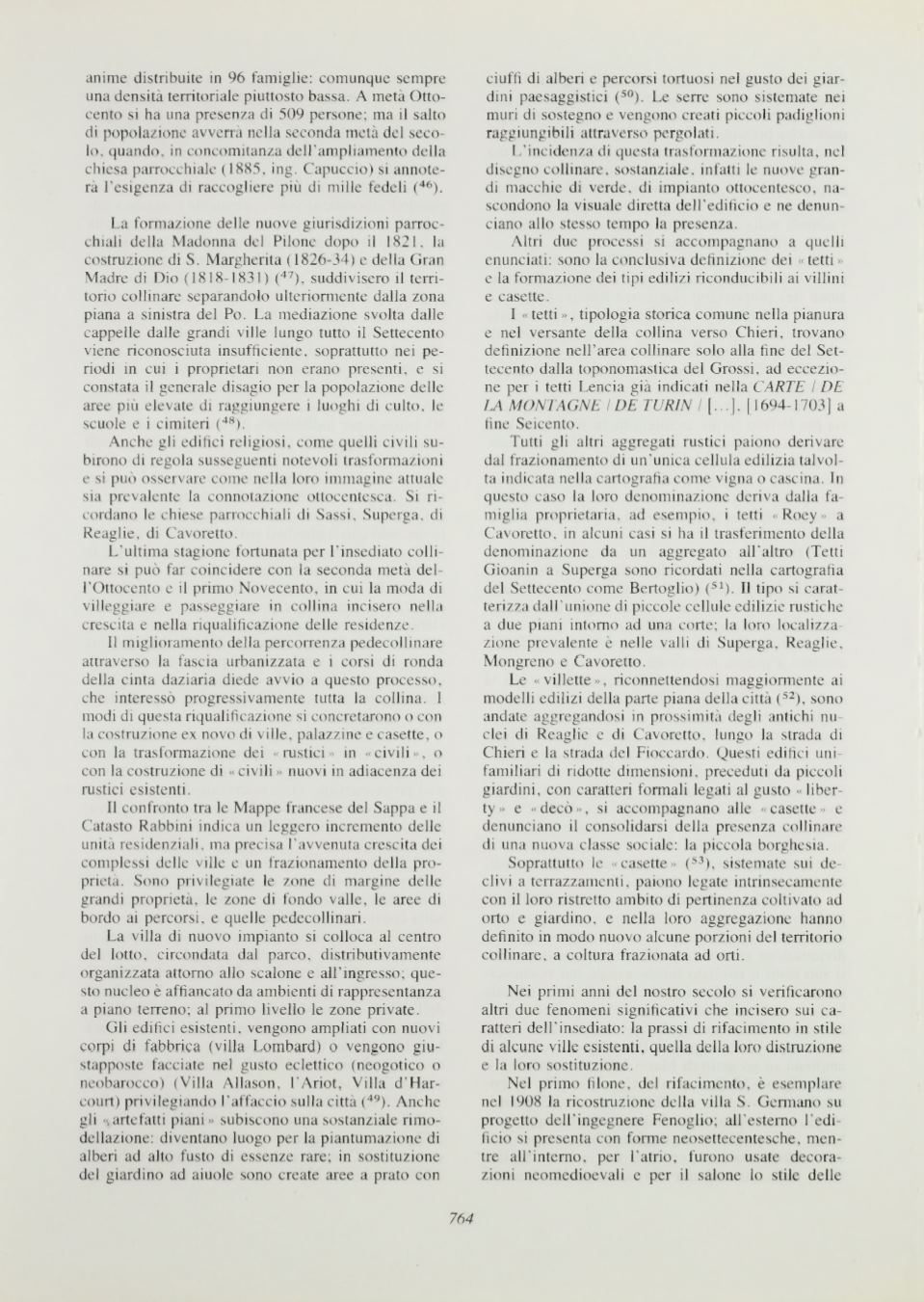
anime distribuite in 96 famiglie: comunque sempre
una densità territoriale piuttosto bassa. A metà Otto-
cento si ha una presenza di 509 persone; ma il salto
di popolazione avverrà nella seconda metà del seco-
lo, quando, in concomitanza dell'ampliamento della
chiesa parrocchiale (1885, ing. Capuccio) si annote-
rà l'esigenza di raccogliere più di mille fedeli (
46
).
La formazione delle nuove giurisdizioni parroc-
chiali della Madonna del Pilone dopo il 1821, la
costruzione di S. Margherita (1826-34) e della Gran
Madre di Dio (1818-1831) (
47
), suddivisero il terri-
torio collinare separandolo ulteriormente dalla zona
piana a sinistra del Po. La mediazione svolta dalle
cappelle dalle grandi ville lungo tutto il Settecento
viene riconosciuta insufficiente, soprattutto nei pe-
riodi in cui i proprietari non erano presenti, e si
constata il generale disagio per la popolazione delle
aree più elevate di raggiungere i luoghi di culto, le
scuole e i cimiteri (
48
).
Anche gli edifici religiosi, come quelli civili su-
birono di regola susseguenti notevoli trasformazioni
e si può osservare come nella loro immagine attuale
sia prevalente la connotazione ottocentesca. Si ri-
cordano le chiese parrocchiali di Sassi, Superga, di
Reaglie, di Cavoretto.
L'ultima stagione fortunata per l'insediato colli-
nare si può far coincidere con la seconda metà del-
l'Ottocento e il primo Novecento, in cui la moda di
villeggiare e passeggiare in collina incisero nella
crescita e nella riqualificazione delle residenze.
II miglioramento della percorrenza pedecollinare
attraverso la fascia urbanizzata e i corsi di ronda
della cinta daziaria diede avvio a questo processo,
che interessò progressivamente tutta la collina. I
modi di questa riqualificazione si concretarono o con
la costruzione ex novo di ville, palazzine e casette, o
con la trasformazione dei « rustici » in « civili », o
con la costruzione di « civili » nuovi in adiacenza dei
rustici esistenti.
Il confronto tra le Mappe francese del Sappa e il
Catasto Rabbini indica un leggero incremento delle
unità residenziali, ma precisa l'avvenuta crescita dei
complessi delle ville e un frazionamento della pro-
prietà. Sono privilegiate le zone di margine delle
grandi proprietà, le zone di fondo valle, le aree di
bordo ai percorsi, e quelle pedecollinari.
La villa di nuovo impianto si colloca al centro
del lotto, circondata dal parco, distributivamente
organizzata attorno allo scalone e all'ingresso; que-
sto nucleo è affiancato da ambienti di rappresentanza
a piano terreno; al primo livello le zone private.
Gli edifici esistenti, vengono ampliati con nuovi
corpi di fabbrica (villa Lombard) o vengono giu-
stapposte facciate nel gusto eclettico (neogotico o
neobarocco) (Villa Allason, l'Ariot, Villa d'Har-
court) privilegiando l'affaccio sulla città (
49
). Anche
gli
,
s artefatti piani » subiscono una sostanziale rimo-
dellazione: diventano luogo per la piantumazione di
alberi ad alto fusto di essenze rare; in sostituzione
del giardino ad aiuole sono create aree a prato con
ciuffi di alberi e percorsi tortuosi nel gusto dei giar-
dini paesaggistici (
50
). Le serre sono sistemate nei
muri di sostegno e vengono creati piccoli padiglioni
raggiungibili attraverso pergolati.
L'incidenza di questa trasformazione risulta, nel
disegno collinare, sostanziale, infatti le nuove gran-
di macchie di verde, di impianto ottocentesco, na-
scondono la visuale diretta dell'edificio e ne denun-
ciano allo stesso tempo la presenza.
Altri due processi si accompagnano a quelli
enunciati: sono la conclusiva definizione dei «tetti»
e la formazione dei tipi edilizi riconducibili ai villini
e casette.
I « tetti », tipologia storica comune nella pianura
e nel versante della collina verso Chieri, trovano
definizione nell'area collinare solo alla fine del Set-
tecento dalla toponomastica del Grossi, ad eccezio-
ne per i tetti Lencia già indicati nella
CARTE I DE
LA MONTAGNE I DE TURIN I [ ... ] . [ 1694
-
l
703] a
fine Seicento.
Tutti gli altri aggregati rustici paiono derivare
dal frazionamento di un'unica cellula edilizia talvol-
ta indicata nella cartografia come vigna o cascina. In
questo caso la loro denominazione deriva dalla fa-
miglia proprietaria, ad esempio, i tetti « Roey » a
Cavoretto, in alcuni casi si ha il trasferimento della
denominazione da un aggregato all'altro (Tetti
Gioanin a Superga sono ricordati nella cartografia
del Settecento come Bertoglio) (
51
). Il tipo si carat-
terizza dall'unione di piccole cellule edilizie rustiche
a due piani intorno ad una corte; la loro localizza-
zione prevalente è nelle valli di Superga, Reaglie,
Mongreno e Cavoretto.
Le « villette », riconnettendosi maggiormente ai
modelli edilizi della parte piana della città (
52
), sono
andate aggregandosi in prossimità degli antichi nu-
clei di Reaglie e di Cavoretto, lungo la strada
di
Chieri e la strada del Fioccardo. Questi edifici uni-
familiari di ridotte dimensioni, preceduti da piccoli
giardini, con caratteri formali legati al gusto « liber-
ty » e « decò » , si accompagnano alle « casette » e
denunciano il consolidarsi della presenza collinare
di una nuova classe sociale: la piccola borghesia.
Soprattutto le « casette » (
53
), sistemate sui de-
clivi a terrazzamenti, paiono legate intrinsecamente
con il loro ristretto ambito di pertinenza coltivato ad
orto e giardino, e nella loro aggregazione hanno
definito in modo nuovo alcune porzioni del territorio
collinare, a coltura frazionata ad orti.
Nei primi anni del nostro secolo si verificarono
altri due fenomeni significativi che incisero sui ca-
ratteri dell'insediato: la prassi di rifacimento in stile
di alcune ville esistenti, quella della loro distruzione
e la loro sostituzione.
Nel primo filone, del rifacimento, è esemplare
nel 1908 la ricostruzione della villa S. Germano su
progetto dell'ingegnere Fenoglio; all'esterno l'edi-
ficio si presenta con forme neosettecentesche, men-
tre all'interno, per l'atrio, furono usate decora-
zioni neomedioevali e per il salone lo stile delle
764


















