
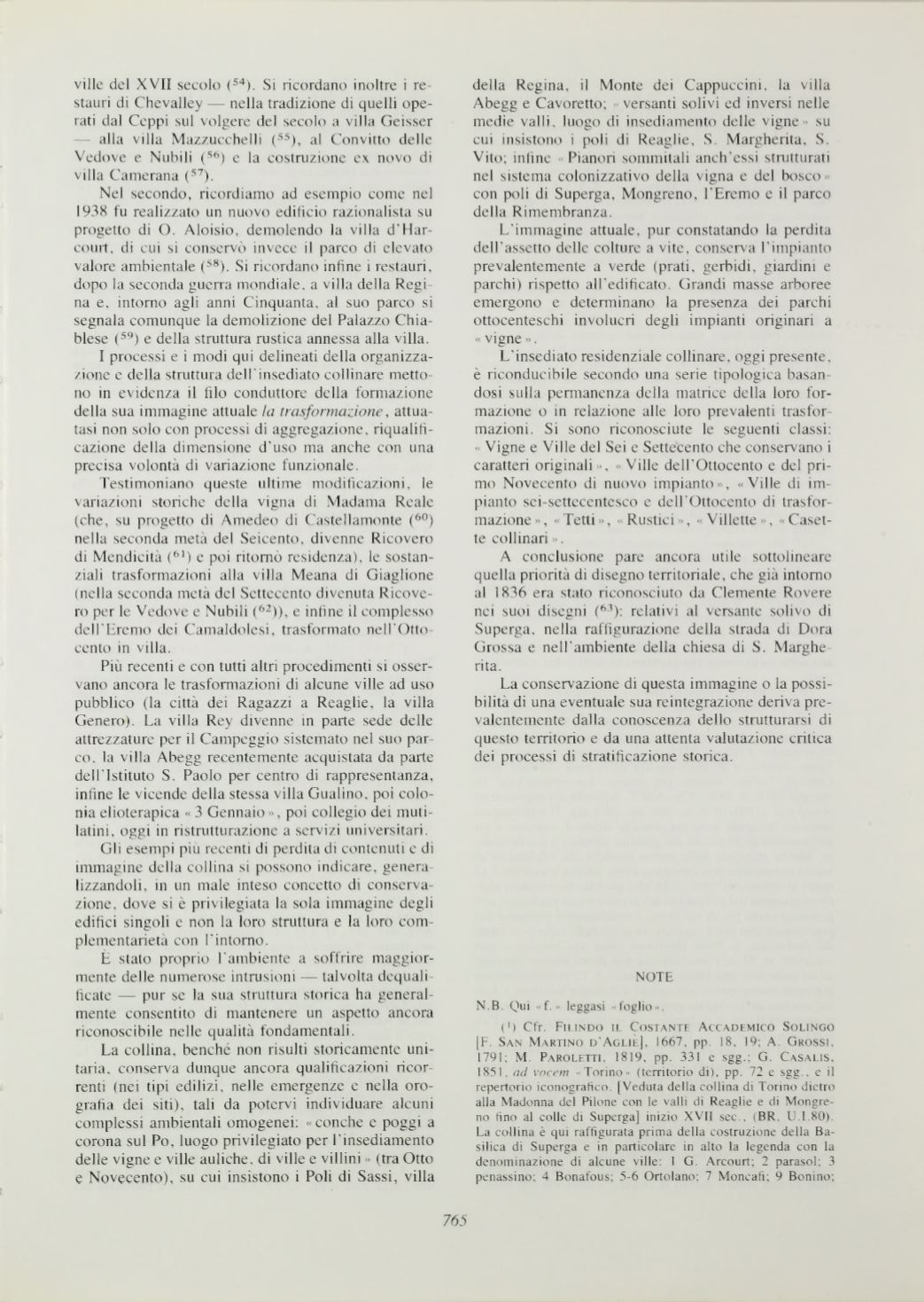
ville del XVII secolo (
54
). Si ricordano inoltre i re-
stauri di Chevalley nella tradizione di quelli ope-
rati dal Ceppi sul volgere del secolo a villa Geisser
— alla villa Mazzucchelli
(
55
),
al Convitto delle
Vedove e Nubili (
56
) e la costruzione ex novo di
villa Camerana (
57
).
Nel secondo, ricordiamo ad esempio come nel
1938 fu realizzato un nuovo edificio razionalista su
progetto di O. Aloisio, demolendo la villa d'Har-
court, di cui si conservò invece il parco di elevato
valore ambientale (
58
). Si ricordano infine i restauri,
dopo la seconda guerra mondiale, a villa della Regi-
na e, intorno agli anni Cinquanta, al suo parco si
segnala comunque la demolizione del Palazzo Chia-
blese
(
59
)
e della struttura rustica annessa alla villa.
I processi e i modi qui delineati della organizza-
zione e della struttura dell'insediato collinare metto-
no in evidenza il filo conduttore della formazione
della sua immagine attuale
ta trasformazione,
attua-
tasi non solo con processi di aggregazione, riqualifi-
cazione della dimensione d'uso ma anche con una
precisa volontà di variazione funzionale.
Testimoniano queste ultime modificazioni, le
variazioni storiche della vigna di Madama Reale
(che, su progetto di Amedeo di Castellamonte (60)
nella seconda metà del Seicento, divenne Ricovero
di Mendicità (
61
) e poi ritornò residenza), le sostan-
ziali trasformazioni alla villa Meana di Giaglione
(nella seconda metà del Settecento divenuta Ricove-
ro per le Vedove e Nubili (
62
)), e infine il complesso
dell'Eremo dei Camaldolesi, trasformato nell'Otto-
cento in villa.
Più recenti e con tutti altri procedimenti si osser-
vano ancora le trasformazioni di alcune ville ad uso
pubblico (la città dei Ragazzi a Reaglie, la villa
Genero). La villa Rey divenne in parte sede delle
attrezzature per il Campeggio sistemato nel suo par-
co, la villa Abegg recentemente acquistata da parte
dell'Istituto S. Paolo per centro di rappresentanza,
infine le vicende della stessa villa Gualino, poi colo-
nia elioterapica « 3 Gennaio », poi collegio dei muti-
latini, oggi in ristrutturazione a servizi universitari.
Gli esempi più recenti di perdita di contenuti e di
immagine della collina si possono indicare, genera-
lizzandoli, in un male inteso concetto di conserva-
zione, dove si è privilegiata la sola immagine degli
edifici singoli e non la loro struttura e la loro com-
plementarietà con l'intorno.
È stato proprio l'ambiente a soffrire maggior-
mente delle numerose intrusioni
talvolta dequali-
ficate pur se la sua struttura storica ha general-
mente consentito di mantenere un aspetto ancora
riconoscibile nelle qualità fondamentali.
La collina, benché non risulti storicamente uni-
taria, conserva dunque ancora qualificazioni ricor-
renti (nei tipi edilizi, nelle emergenze e nella oro-
grafia dei siti), tali da potervi individuare alcuni
complessi ambientali omogenei: « conche e poggi a
corona sul Po, luogo privilegiato per l'insediamento
delle vigne e ville auliche, di ville e villini » (tra Otto
e Novecento), su cui insistono i Poli di Sassi, villa
della Regina, il Monte dei Cappuccini, la villa
Abegg e Cavoretto; « versanti solivi ed inversi nelle
medie valli, luogo di insediamento delle vigne» su
cui insistono i poli di Reaglie, S. Margherita, S.
Vito; infine « Pianori sommitali anch'essi strutturati
nel sistema colonizzativo della vigna e del bosco »
con poli di Superga, Mongreno, l'Eremo e il parco
della Rimembranza.
L'immagine attuale, pur constatando la perdita
dell'assetto delle colture a vite, conserva l'impianto
prevalentemente a verde (prati, gerbidi, giardini e
parchi) rispetto all'edificato. Grandi masse arboree
emergono e determinano la presenza dei parchi
ottocenteschi involucri degli impianti originari a
«vigne».
L'insediato residenziale collinare, oggi presente,
è riconducibile secondo una serie tipologica basan-
dosi sulla permanenza della matrice della loro for-
mazione o in relazione alle loro prevalenti trasfor-
mazioni. Si sono riconosciute le seguenti classi:
« Vigne e Ville del Sei e Settecento che conservano i
caratteri originali » , «Ville dell'Ottocento e del pri-
mo Novecento di nuovo impianto», «Ville di im-
pianto sei-settecentesco e dell'Ottocento di trasfor-
mazione », « Tetti », « Rustici », « Villette », « Caset-
te collinari ».
A conclusione pare ancora utile sottolineare
quella priorità di disegno territoriale, che già intorno
al 1836 era stato riconosciuto da Clemente Rovere
nei suoi disegni (
63
): relativi al versante solivo di
Superga, nella raffigurazione della strada di Dora
Grossa e nell'ambiente della chiesa di S. Marghe-
rita.
La conservazione di questa immagine o la possi-
bilità di una eventuale sua reintegrazione deriva pre-
valentemente dalla conoscenza dello strutturarsi di
questo territorio e da una attenta valutazione critica
dei processi di stratificazione storica.
NOTE
N.B. Qui «f... leggasi «foglio'.
(') Cfr.
FILINDO IL COSTANTE ACCADEMICO SOLINGO
[F.
SAN MARTINO
D'AGLIE], 1667, pp. 18, 19; A.
GROSSI,
1791; M.
PAROLETTI,
1819, pp. 331 e sgg.; G.
CASALIS,
1851,
ad vocem «
Torino» (territorio di), pp. 72 e sgg., e il
repertorio iconografico. [Veduta della collina di Torino dietro
alla Madonna del Pilone con le valli di Reaglie e di Mongre-
no fino al colle di Superga] inizio XVII sec., (BR, U.I.80).
La collina
è
qui raffigurata prima della costruzione della Ba-
silica di Superga e in particolare in alto la legenda con la
denominazione di alcune ville: I G. Arcourt; 2 parasol: 3
penassino; 4 Bonafous; 5-6 Ortolano; 7 Moncafi; 9 Bonino;
765


















