
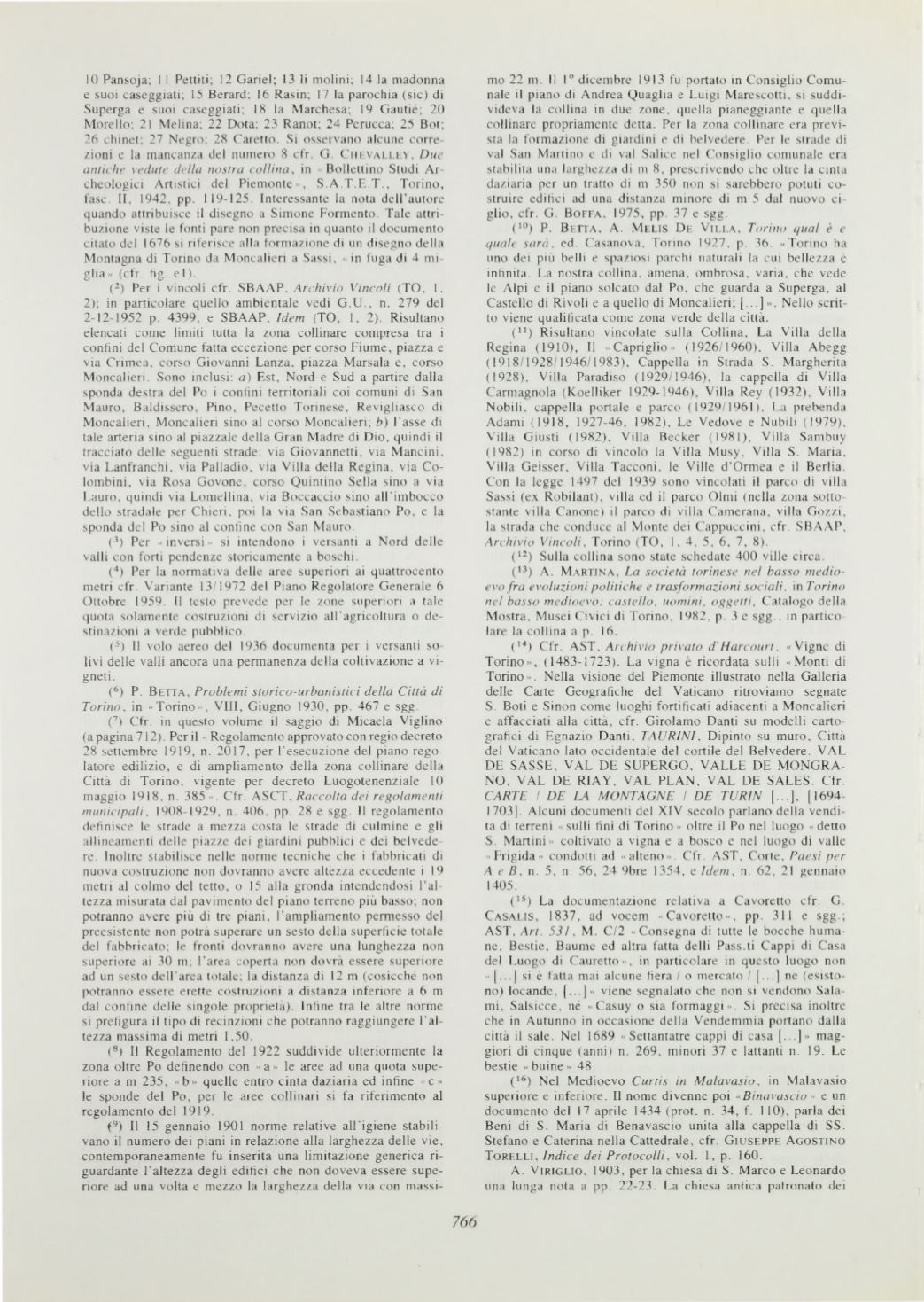
10 Pansoja; I I Pettiti; 12 Gariel; 13 li molini; 14 la madonna
e suoi caseggiati; 15 Berard; 16 Rasin; 17 la parochia (sic) di
Superga e suoi caseggiati; 18 la Marchesa; 19 Gautié; 20
Morello; 21 Melina; 22 Dota; 23 Ranot; 24 Perucca; 25 Bot;
26 chinet; 27 Negro; 28 Caretto. Si osservano alcune corre-
zioni e la mancanza del numero 8 cfr. G. CHEVALLEY,
Due
antiche vedute della nostra collina,
in «Bollettino Studi Ar-
cheologici Artistici del Piemonte», S. A. T. E.T., Torino,
fasc. II, 1942, pp. 119-125. Interessante la nota dell'autore
quando attribuisce il disegno a Simone Formento. Tale attri-
buzione viste le fonti pare non precisa in quanto il documento
citato del 1676 si riferisce alla formazione di un disegno della
Montagna di Torino da Moncalieri a Sassi, « in fuga di 4 mi-
glia» (cfr. fig. el).
(2) Per i vincoli cfr. SBAAP,
Archivio Vincoli
(TO, 1,
2); in particolare quello ambientale vedi G.U., n. 279 del
2-12-1952 p. 4399, e SBAAP,
Idem
(TO, 1, 2). Risultano
elencati come limiti tutta la zona collinare compresa tra i
confini del Comune fatta eccezione per corso Fiume, piazza e
via Crimea, corso Giovanni Lanza, piazza Marsala e, corso
Moncalieri. Sono inclusi:
a)
Est, Nord e Sud a partire dalla
sponda destra del Po i confini territoriali coi comuni di San
Mauro, Baldissero, Pino, Pecetto Torinese, Revigliasco di
Moncalieri, Moncalieri sino al corso Moncalieri;
b)
l'asse di
tale arteria sino al piazzale della Gran Madre di Dio, quindi il
tracciato delle seguenti strade: via Giovannetti, via Mancini,
via Lanfranchi, via Palladio, via Villa della Regina, via Co-
lombini, via Rosa Govone, corso Quintino Sella sino a via
Lauro, quindi via Lomellina, via Boccaccio sino all'imbocco
dello stradale per Chieri, poi la via San Sebastiano Po, e la
sponda del Po sino al confine con San Mauro.
(3) Per « inversi » si intendono i versanti a Nord delle
valli con forti pendenze storicamente a boschi.
(4) Per la normativa delle aree superiori ai quattrocento
metri cfr. Variante 13/1972 del Piano Regolatore Generale 6
Ottobre 1959. Il testo prevede per le zone superiori a tale
quota solamente costruzioni di servizio all'agricoltura o de-
stinazioni a verde pubblico.
(5) II volo aereo del 1936 documenta per i versanti so-
livi delle valli ancora una permanenza della coltivazione a vi-
gneti.
(6) P. BETTA,
Problemi storico-urbanistici della Città di
Torino,
in «Torino», VIII, Giugno 1930, pp. 467 e sgg.
(7) Cfr. in questo volume il saggio di Micaela Viglino
(a pagina 712). Per il « Regolamento approvato con regio decreto
28 settembre 1919, n. 2017, per l'esecuzione del piano rego-
latore edilizio, e di ampliamento della zona collinare della
Città di Torino, vigente per decreto Luogotenenziale 10
maggio 1918, n. 385 ». Cfr. ASCT,
Raccolta dei regolamenti
municipati,
1908-1929, n. 406, pp. 28 e sgg. Il regolamento
definisce le strade a mezza costa fe strade di culmine e gli
allineamenti delle piazze dei giardini pubblici e dei belvede-
re. Inoltre stabilisce nelle norme tecniche che i fabbricati di
nuova costruzione non dovranno avere altezza eccedente i 19
metri al colmo del tetto, o 15 alla gronda intendendosi l'al-
tezza misurata dal pavimento del piano terreno più basso; non
potranno avere più di tre piani, l'ampliamento permesso del
preesistente non potrà superare un sesto della superficie totale
del fabbricato; le fronti dovranno avere una lunghezza non
superiore ai 30 m; l'area coperta non dovrà essere superiore
ad un sesto dell'area totale; la distanza di 12 m (cosicché non
potranno essere erette costruzioni a distanza inferiore a 6 m
dal confine delle singole proprietà). Infine tra le altre norme
si prefigura il tipo di recinzioni che potranno raggiungere l'al-
tezza massima di metri 1,50.
(8) Il Regolamento del 1922 suddivide ulteriormente la
zona oltre Po definendo con « a » le aree ad una quota supe-
riore a m 235, «b» quelle entro cinta daziaria ed infine «c»
le sponde del Po, per le aree collinari si fa riferimento al
regolamento del 1919.
(9) Il 15 gennaio 1901 norme relative all'igiene stabili-
vano il numero dei piani in relazione alla larghezza delle vie,
contemporaneamente fu inserita una limitazione generica ri-
guardante l'altezza degli edifici che non doveva essere supe-
riore ad una volta e mezzo la larghezza della via con massi-
mo 22 m. Il 1° dicembre 1913 fu portato in Consiglio Comu-
nale il piano di Andrea Quaglia e Luigi Marescotti, si suddi-
videva la collina in due zone, quella pianeggiante e quella
collinare propriamente detta. Per la zona collinare era previ-
sta la formazione di giardini e di belvedere. Per le strade di
val San Martino e di val Salice nel Consiglio comunale era
stabilita una larghezza di m 8, prescrivendo che oltre la cinta
daziaria per un tratto di m 350 non si sarebbero potuti co-
struire edifici ad una distanza minore di m 5 dal nuovo ci-
glio, cfr. G. BOFFA, 1975, pp. 37 e sgg.
(io)
P.
BETTA, A. MELIS DE VILLA,
Torino qual è e
quate sarà,
ed. Casanova, Torino 1927, p. 36. «Torino ha
uno dei più belli e spaziosi parchi naturali la cui bellezza è
infinita. La nostra collina, amena, ombrosa, varia, che vede
le Alpi e il piano solcato dal Po, che guarda a Superga, al
Castello di Rivoli e a quello di Moncalieri; LI». Nello scrit-
to viene qualificata come zona verde della città.
(11) Risultano vincolate sulla Collina, La Villa della
Regina (1910), Il « Capriglio » (1926/1960), Villa Abegg
(1918/1928/1946/1983), Cappella in Strada S. Margherita
(1928), Villa Paradiso (1929/1946), la cappella di Villa
Carmagnola (Koelliker 1929-1946), Villa Rey (1932), Villa
Nobili, cappella portale e parco (1929/1961), La prebenda
Adami (1918, 1927-46, 1982), Le Vedove e Nubili (1979),
Villa Giusti (1982), Villa Becker (1981), Villa Sambuy
(1982) in corso di vincolo la Villa Musy, Villa S. Maria,
Villa Geisser, Villa Tacconi, le Ville d'Ormea e il Berlia.
Con la legge 1497 del 1939 sono vincolati il parco di villa
Sassi (ex Robilant), villa ed il parco Olmi (nella zona sotto-
stante villa Canone) il parco di villa Camerana, villa Gozzi,
la strada che conduce al Monte dei Cappuccini, cfr. SBAAP,
Archivio Vincoli,
Torino (TO, 1, 4, 5, 6, 7, 8).
(12) Sulla collina sono state schedate 400 ville circa.
(13) A. MARTINA,
La società torinese net basso medio-
evo fra evoluzioni politiche e trasformazioni sociali,
in
Torino
nel basso medioevo: castello, uomini, oggetti,
Catalogo della
Mostra, Musei Civici di Torino, 1982, p. 3 e sgg., in partico-
lare la collina a p. 16.
(14) Cfr. AST,
Archivio privato d'Harcourl, «Vigne
di
Torino», (1483-1723). La vigna
è
ricordata sulli «Monti di
Torino». Nella visione del Piemonte illustrato nella Galleria
delle Carte Geografiche del Vaticano ritroviamo segnate
S. Boti e Sinon come luoghi fortificati adiacenti a Moncalieri
e affacciati alla città, cfr. Girolamo Danti su modelli carto-
grafici di Egnazio Danti,
TAURINI,
Dipinto su muro, Città
del Vaticano lato occidentale del cortile del Belvedere. VAL
DE SASSE, VAL DE SUPERGO, VALLE DE MONGRA-
NO, VAL DE RIAY, VAL PLAN, VAL DE SALES. Cfr.
CARTE l DE LA MONTAGNE / DE TURIN [...],
[1694-
1703]. Alcuni documenti del XIV secolo parlano della vendi-
ta di terreni <. sulli fini di Torino » oltre il Po nel luogo « detto
S. Martini» coltivato a vigna e a bosco e nel luogo di valle
« Frigida » condotti ad ,. alteno » . Cfr. AST, Corte,
Paesi per
A e B,
n. 5, n. 56, 24 9bre 1354, e
Idem,
n. 62, 21 gennaio
1405.
(1s) La documentazione relativa a Cavoretto cfr. G.
CASALIS, 1837, ad vocem .Cavoretto .., pp. 311 e sgg.;
AST,
Art. 531 ,
M. C/2 « Consegna di tutte le bocche huma-
ne, Bestie, Baume ed altra fatta delli
Pass.tiCappi di Casa
del Luogo di Cauretto», in particolare in questo luogo non
[...] si è fatta mai alcune fiera / o mercato / [...] ne (esisto-
no) locande, [...]» viene segnalato che non si vendono Sala-
mi, Salsicce, né «Casuy o sia formaggi». Si precisa inoltre
che in Autunno in occasione della Vendemmia portano dalla
città il sale. Nel 1689 « Settantatre cappi di casa [...] » mag-
giori di cinque (anni) n. 269, minori 37 e lattanti n. 19. Le
bestie « buine » 48.
(16) Nel Medioevo
Curtis in Malavasio,
in Malavasio
superiore e inferiore. Il nome divenne poi
«Binavascio ..
e un
documento del 17 aprile 1434 (prot. n. 34, f. 110), parla dei
Beni di S. Maria di Benavascio unita alla cappella di SS.
Stefano e Caterina nella Cattedrale, cfr. GIUSEPPE AGOSTINO
TORELLI,
Indice dei Protocolli,
vol. 1, p. 160.
A. VIRIGLIO, 1903, per la chiesa di S. Marco e Leonardo
una lunga nota a pp. 22-23. La chiesa antica patronato dei
766


















