
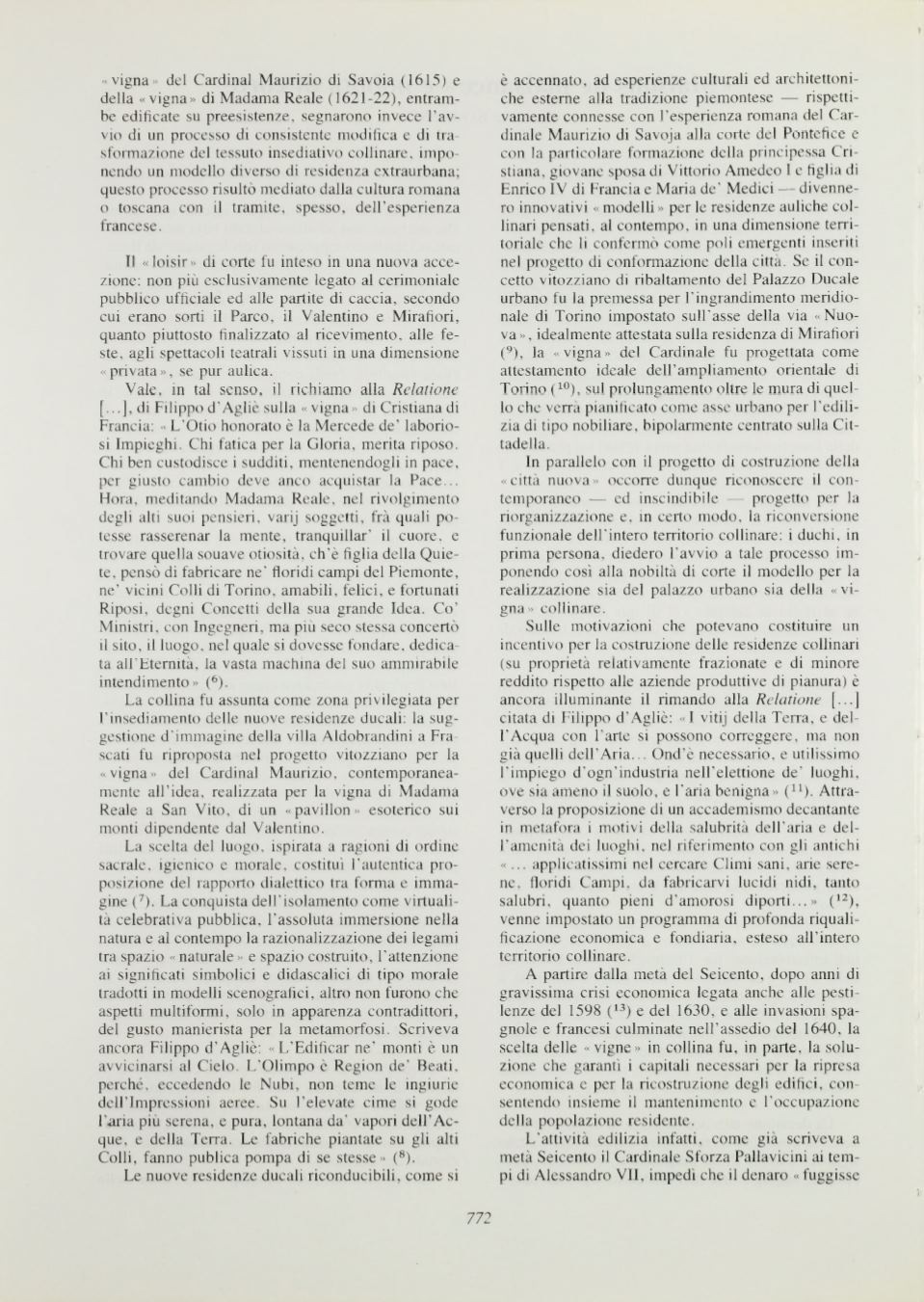
«vigna» del Cardinal Maurizio di Savoia (1615) e
della «vigna» di Madama Reale (1621-22), entram-
be edificate su preesistenze, segnarono invece l'av-
vio di un processo di consistente modifica e di tra-
sformazione del tessuto insediativo collinare, impo-
nendo un modello diverso di residenza extraurbana;
questo processo risultò mediato dalla cultura romana
o toscana con il tramite, spesso, dell'esperienza
francese.
Il «loisir» di corte fu inteso in una nuova acce-
zione: non più esclusivamente legato al cerimoniale
pubblico ufficiale ed alle partite di caccia, secondo
cui erano sorti il Parco, il Valentino e Mirafiori,
quanto piuttosto finalizzato al ricevimento, alle fe-
ste, agli spettacoli teatrali vissuti in una dimensione
«privata», se pur aulica.
Vale, in tal senso, il richiamo alla
Retatione
[...],
di Filippo d'Agliè sulla «vigna» di Cristiana di
Francia: « L'Otio honorato è la Mercede de' laborio-
si Impieghi. Chi fatica per la Gloria, merita riposo.
Chi ben custodisce i sudditi, mentenendogli in pace,
per giusto cambio deve anco acquistar la Pace...
Hora, meditando Madama Reale, nel rivolgimento
degli alti suoi pensieri, varij soggetti, frà quali po-
tesse rasserenar la mente, tranquillar' il cuore, e
trovare quella souave otiosità, ch'è figlia della Quie-
te, pensò di fabricare ne' floridi campi del Piemonte,
ne' vicini Colli di Torino, amabili, felici, e fortunati
Riposi, degni Concetti della sua grande Idea. Co'
Ministri, con Ingegneri, ma più seco stessa concertò
il sito, il luogo, nel quale si dovesse fondare, dedica-
ta all'Eternità, la vasta machina del suo ammirabile
intendimento » (
6
).
La collina fu assunta come zona privilegiata per
l'insediamento delle nuove residenze ducali: la sug-
gestione d'immagine della villa Aldobrandini a Fra-
scati fu riproposta nel progetto vitozziano per la
« vigna » del Cardinal Maurizio, contemporanea-
mente all'idea, realizzata per la vigna di Madama
Reale a San Vito, di un «pavilion» esoterico sui
monti dipendente dal Valentino.
La scelta del luogo, ispirata a ragioni di ordine
sacrale, igienico e morale, costituì l'autentica pro-
posizione del rapporto dialettico tra forma e imma-
gine (
7
). La conquista dell'isolamento come virtuali-
tà celebrativa pubblica, l'assoluta immersione nella
natura e al contempo la razionalizzazione dei legami
tra spazio «naturale» e spazio costruito, l'attenzione
ai significati simbolici e didascalici di tipo morale
tradotti in modelli scenografici, altro non furono che
aspetti multiformi, solo in apparenza contradittori,
del gusto manierista per la metamorfosi. Scriveva
ancora Filippo d'Agliè: « L'Edificar ne' monti è un
avvicinarsi al Cielo. L'Olimpo è Region de' Beati,
perché, eccedendo le Nubi, non teme le ingiurie
dell'Impressioni aeree. Su l'elevate cime si gode
l'aria più serena, e pura, lontana da' vapori dell'Ac-
que, e della Terra. Le fabriche piantate su gli alti
Colli, fanno publica pompa di se stesse» (
8
).
Le nuove residenze ducali riconducibili, come si
è accennato, ad esperienze culturali ed architettoni-
che esterne alla tradizione piemontese rispetti-
vamente connesse con l'esperienza romana del Car-
dinale Maurizio di Savoja alla corte del Pontefice e
con la particolare formazione della principessa Cri-
stiana, giovane sposa di Vittorio Amedeo I e figlia di
Enrico IV di Francia e Maria de' Medici — divenne-
ro innovativi «modelli» per le residenze auliche col-
linari pensati, al contempo, in una dimensione terri-
toriale che li confermò come poli emergenti inseriti
nel progetto di conformazione della città. Se il con-
cetto vitozziano di ribaltamento del Palazzo Ducale
urbano fu la premessa per l'ingrandimento meridio-
nale di Torino impostato sull'asse della via « Nuo-
va», idealmente attestata sulla residenza di Mirafiori
(
9
), la « vigna » del Cardinale fu progettata come
attestamento ideale dell'ampliamento orientale di
Torino (
10
), sul prolungamento oltre le mura di quel-
lo che verrà pianificato come asse urbano per l'edili-
zia di tipo nobiliare, bipolarmente centrato sulla Cit-
tadella.
In parallelo con il progetto di costruzione della
«città nuova» occorre dunque riconoscere il con-
temporaneo — ed inscindibile progetto per la
riorganizzazione e, in certo modo, la riconversione
funzionale dell'intero territorio collinare: i duchi, in
prima persona, diedero l'avvio a tale processo im-
ponendo così alla nobiltà di corte il modello per la
realizzazione sia del palazzo urbano sia della « vi-
gna» collinare.
Sulle motivazioni che potevano costituire un
incentivo per la costruzione delle residenze collinari
(su proprietà relativamente frazionate e di minore
reddito rispetto alle aziende produttive di pianura) è
ancora illuminante il rimando alla
Retatione [...]
citata di Filippo d'Agliè: «I vitij della Terra, e del-
l'Acqua con l'arte si possono correggere, ma non
già quelli dell'Aria... Ond'è necessario, e utilissimo
l'impiego d'ogn'industria nell'elettione de' luoghi,
ove sia ameno il suolo, e l'aria benigna» (
11
). Attra-
verso la proposizione di un accademismo decantante
in metafora i motivi della salubrità dell'aria e del-
l'amenità dei luoghi, nel riferimento con gli antichi
« ... applicatissimi nel cercare Climi sani, arie sere-
ne, floridi Campi, da fabricarvi lucidi nidi, tanto
salubri, quanto pieni d'amorosi diporti...
>> (12),
venne impostato un programma di profonda riquali-
ficazione economica e fondiaria, esteso all'intero
territorio collinare.
A partire dalla metà del Seicento, dopo anni di
gravissima crisi economica legata anche alle pesti-
lenze del 1598 (
13
) e del 1630, e alle invasioni spa-
gnole e francesi culminate nell'assedio del 1640, la
scelta delle «vigne» in collina fu, in parte, la solu-
zione che garantì i capitali necessari per la ripresa
economica e per la ricostruzione degli edifici, con-
sentendo insieme il mantenimento e l'occupazione
della popolazione residente.
L'attività edilizia infatti, come già scriveva a
metà Seicento il Cardinale Sforza Pallavicini ai tem-
pi di Alessandro VII, impedì che il denaro « fuggisse
772


















