
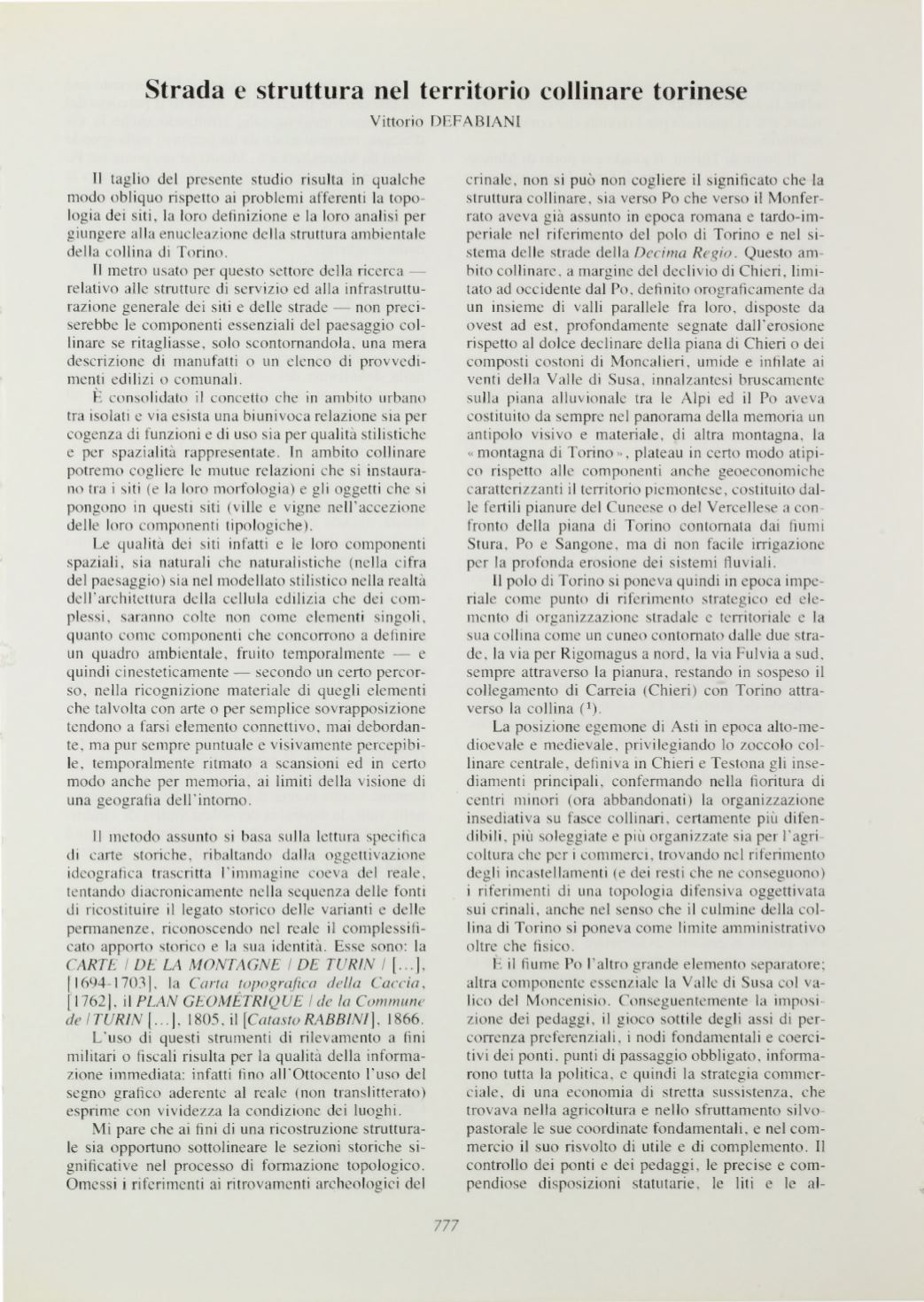
Strada e struttura nel territorio collinare torinese
Vittorio DEFABIANI
Il taglio del presente studio risulta in qualche
modo obliquo rispetto ai problemi afferenti la topo-
logia dei siti, la loro definizione e la loro analisi per
giungere alla enucleazione della struttura ambientale
della collina di Torino.
Il metro usato per questo settore della ricerca
relativo alle strutture di servizio ed alla infrastruttu-
razione generale dei siti e delle strade non preci-
serebbe le componenti essenziali del paesaggio col-
linare se ritagliasse, solo scontornandola, una mera
descrizione di manufatti o un elenco di provvedi-
menti edilizi o comunali.
È consolidato il concetto che in ambito urbano
tra isolati e via esista una biunivoca relazione sia per
cogenza di funzioni e di uso sia per qualità stilistiche
e per spazialità rappresentate. In ambito collinare
potremo cogliere le mutue relazioni che si instaura-
no tra i siti (e la loro morfologia) e gli oggetti che si
pongono in questi siti (ville e vigne nell'accezione
delle loro componenti tipologiche).
Le qualità dei siti infatti e le loro componenti
spaziali, sia naturali che naturalistiche (nella cifra
del paesaggio) sia nel modellato stilistico nella realtà
dell'architettura della cellula edilizia che dei com-
plessi, saranno colte non come elementi singoli,
quanto come componenti che concorrono a definire
un quadro ambientale, fruito temporalmente — e
quindi cinesteticamente — secondo un certo percor-
so, nella ricognizione materiale di quegli elementi
che talvolta con arte o per semplice sovrapposizione
tendono a farsi elemento connettivo, mai debordan-
te, ma pur sempre puntuale e visivamente percepibi-
le, temporalmente ritmato a scansioni ed in certo
modo anche per memoria, ai limiti della visione di
una geografia dell'intorno.
Il metodo assunto si basa sulla lettura specifica
di carte storiche, ribaltando dalla oggettivazione
ideografica trascritta l'immagine coeva del reale,
tentando diacronicamente nella sequenza delle fonti
di ricostituire il legato storico delle varianti e delle
permanenze, riconoscendo nel reale il complessifi-
cato apporto storico e la sua identità. Esse sono: la
CARTE I DE LA MONTAGNE I DE
TURIN
I
[...J,
[1694-1703]
, la
Carta topografica detta Caccia,
[ 1762], il
PLAN GEOMÉTRIQUE I de ta Commune
de I TURIN [...],
1805, il
[Catasto RABBINI],
1866.
L'uso di questi strumenti di rilevamento a fini
militari o fiscali risulta per la qualità della informa-
zione immediata: infatti fino all'Ottocento l'uso del
segno grafico aderente al reale (non translitterato)
esprime con vividezza la condizione dei luoghi.
Mi pare che ai fini di una ricostruzione struttura-
le sia opportuno sottolineare le sezioni storiche si-
gnificative nel processo di formazione topologico.
Omessi i riferimenti ai ritrovamenti archeologici del
crinale, non si può non cogliere il significato che la
struttura collinare, sia verso Po che verso il Monfer-
rato aveva già assunto in epoca romana e tardo-im-
periale nel riferimento del polo di Torino e nel si-
stema delle strade della
Decima Regio.
Questo am-
bito collinare, a margine del declivio di Chieri, limi-
tato ad occidente dal Po, definito orograficamente da
un insieme di valli parallele fra loro, disposte da
ovest ad est, profondamente segnate dall'erosione
rispetto al dolce declinare della piana di Chieri o dei
composti costoni di Moncalieri, umide e infilate ai
venti della Valle di Susa, innalzantesi bruscamente
sulla piana alluvionale tra le Alpi ed il Po aveva
costituito da sempre nel panorama della memoria un
antipolo visivo e materiale, di altra montagna, la
« montagna di
Torino»,
plateau in certo modo atipi-
co rispetto alle componenti anche geoeconomiche
caratterizzanti il territorio piemontese, costituito dal-
le fertili pianure del Cuneese o del Vercellese a con-
fronto della piana di Torino contornata dai fiumi
Stura, Po e Sangone, ma di non facile irrigazione
per la profonda erosione dei sistemi fluviali.
Il polo di Torino si poneva quindi in epoca impe-
riale come punto di riferimento strategico ed ele-
mento di organizzazione stradale e territoriale e la
sua collina come un cuneo contornato dalle due stra-
de, la via per Rigomagus a nord, la via Fulvia a sud,
sempre attraverso la pianura, restando in sospeso il
collegamento di Carreia (Chieri) con Torino attra-
verso la collina (
1
).
La posizione egemone di Asti in epoca alto-me-
dioevale e medievale, privilegiando lo zoccolo col-
linare centrale, definiva in Chieri e Testona gli inse-
diamenti principali, confermando nella fioritura di
centri minori (ora abbandonati) la organizzazione
insediativa su fasce collinari, certamente più difen-
dibili, più soleggiate e più organizzate sia per l'agri-
coltura che per i commerci, trovando nel riferimento
degli incastellamenti (e dei resti che ne conseguono)
i riferimenti di una topologia difensiva oggettivata
sui crinali, anche nel senso che il culmine della col-
lina di Torino si poneva come limite amministrativo
oltre che fisico.
È il fiume Po l'altro grande elemento separatore;
altra componente essenziale la Valle di Susa col va-
lico del Moncenisio. Conseguentemente la imposi-
zione dei pedaggi, il gioco sottile degli assi di per-
correnza preferenziali, i nodi fondamentali e coerci-
tivi dei ponti. punti di passaggio obbligato, informa-
rono tutta la politica, e quindi la strategia commer-
ciale, di una economia di stretta sussistenza, che
trovava nella agricoltura e nello sfruttamento silvo-
pastorale le sue coordinate fondamentali, e nel com-
mercio il suo risvolto di utile e di complemento. Il
controllo dei ponti e dei pedaggi, le precise e com-
pendiose disposizioni statutarie, le liti e le al-
777


















