
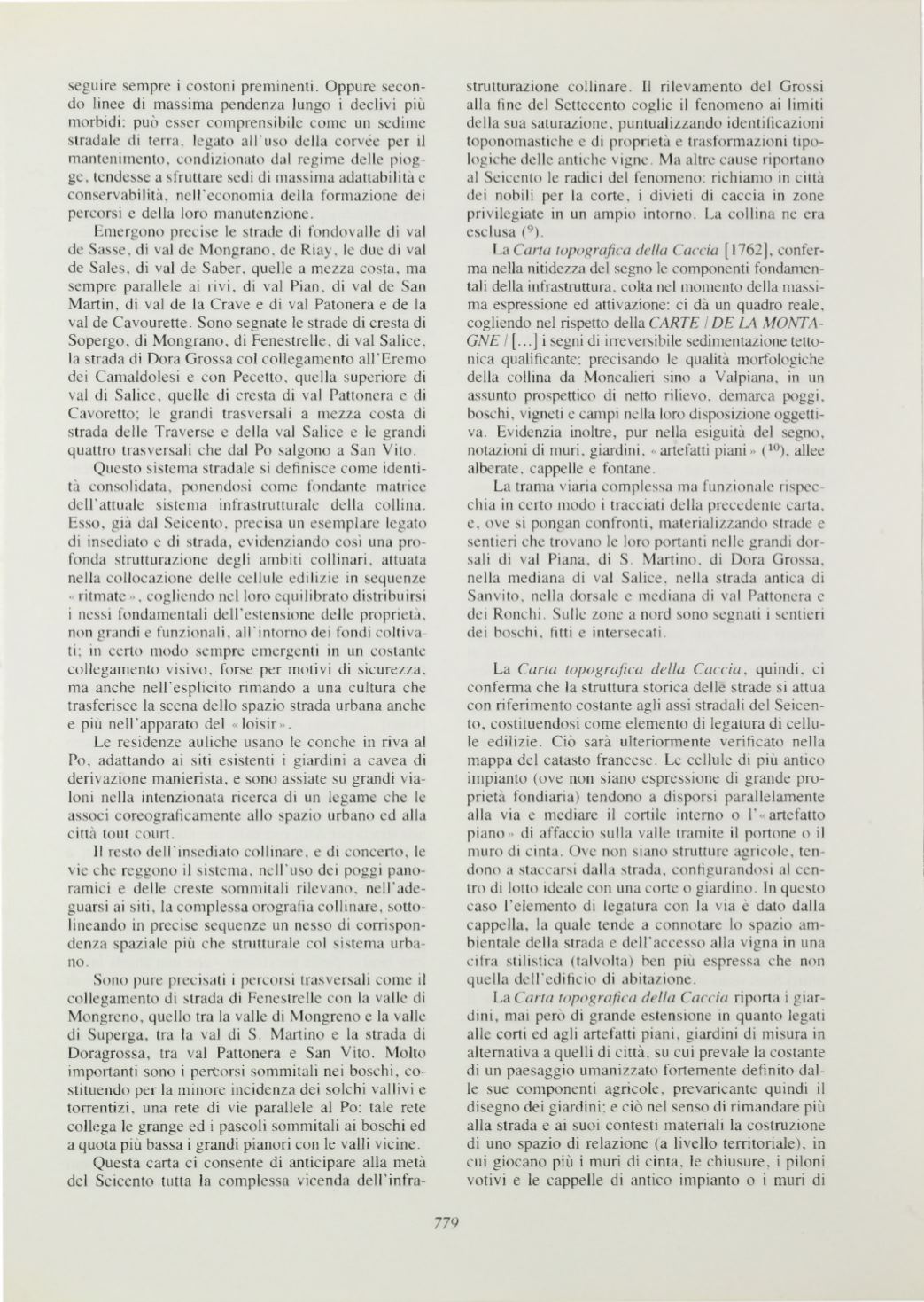
seguire sempre i costoni preminenti. Oppure secon-
do linee di massima pendenza lungo i declivi più
morbidi: può esser comprensibile come un sedime
stradale di terra, legato all'uso della corvée per il
mantenimento, condizionato dal regime delle piog-
ge, tendesse a sfruttare sedi di massima adattabilità e
conservabilità, nell'economia della formazione dei
percorsi e della loro manutenzione.
Emergono precise le strade di fondovalle di val
de Sasse, di val de Mongrano, de Riay, le due di val
de Sales, di val de Saber, quelle a mezza costa, ma
sempre parallele ai rivi, di val Pian, di val de San
Martin, di val de la Crave e di val Patonera e de la
val de Cavourette. Sono segnate le strade di cresta di
Sopergo, di Mongrano, di Fenestrelle, di val Salice,
la strada di Dora Grossa col collegamento all'Eremo
dei Camaldolesi e con Pecetto, quella superiore di
val di Salice, quelle di cresta di val Pattonera e di
Cavoretto; le grandi trasversali a mezza costa di
strada delle Traverse e della val Salice e le grandi
quattro trasversali che dal Po salgono a San Vito.
Questo sistema stradale si definisce come identi-
tà consolidata, ponendosi come fondante matrice
dell'attuale sistema infrastrutturale della collina.
Esso, già dal Seicento, precisa un esemplare legato
di insediato e di strada, evidenziando così una pro-
fonda strutturazione degli ambiti collinari, attuata
nella collocazione delle cellule edilizie in sequenze
ritmate», cogliendo nel loro equilibrato distribuirsi
i nessi fondamentali dell'estensione delle proprietà,
non grandi e funzionali, all'intorno dei fondi coltiva-
ti; in certo modo sempre emergenti in un costante
collegamento visivo, forse per motivi di sicurezza,
ma anche nell'esplicito rimando a una cultura che
trasferisce la scena dello spazio strada urbana anche
e più nell'apparato del «loisir».
Le residenze auliche usano le conche in riva al
Po, adattando ai siti esistenti i giardini a cavea di
derivazione manierista, e sono assiate su grandi via-
loni nella intenzionata ricerca di un legame che le
associ coreograficamente allo spazio urbano ed alla
città tout cou rt .
Il resto dell'insediato collinare, e di concerto, le
vie che reggono il sistema, nell'uso dei poggi pano-
ramici e delle creste sommitali rilevano, nell'ade-
guarsi ai siti, la complessa orografia collinare, sotto-
lineando in precise sequenze un nesso di corrispon-
denza spaziale più che strutturale col sistema urba-
no.
Sono pure precisati i percorsi trasversali come il
collegamento di strada di Fenestrelle con la valle di
Mongreno, quello tra la valle di Mongreno e la valle
di Superga, tra la val di S. Martino e la strada di
Doragrossa, tra val Pattonera e San Vito. Molto
importanti sono i percorsi sommitali nei boschi, co-
stituendo per la minore incidenza dei solchi vallivi e
torrentizi, una rete di vie parallele al Po: tale rete
collega le grange ed i pascoli sommitali ai boschi ed
a quota più bassa i grandi pianori con le valli vicine.
Questa carta ci consente di anticipare alla metà
del Seicento tutta la complessa vicenda dell'infra-
strutturazione collinare. Il rilevamento del Grossi
alla fine del Settecento coglie il fenomeno ai limiti
della sua saturazione, puntualizzando identificazioni
toponomastiche e di proprietà e trasformazioni tipo-
logiche delle antiche vigne. Ma altre cause riportano
al Seicento le radici del fenomeno: richiamo in città
dei nobili per la corte, i divieti di caccia in zone
privilegiate in un ampio intorno. La collina ne era
esclusa (
9
).
La
Carta topografica delta Caccia
[1762], confer-
ma nella nitidezza del segno le componenti fondamen-
tali della infrastruttura, colta nel momento della massi-
ma espressione ed attivazione: ci dà un quadro reale,
cogliendo nel rispetto della
CARTE I DE LA MONTA-
GNE I [...]
i segni di irreversibile sedimentazione tetto-
nica qualificante; precisando le qualità morfologiche
della collina da Moncalieri sino a Valpiana, in un
assunto prospettico di netto rilievo, demarca poggi,
boschi, vigneti e campi nella loro disposizione oggetti-
va. Evidenzia inoltre, pur nella esiguità del segno,
notazioni di muri, giardini, « artefatti piani » (
10
), allee
alberate, cappelle e fontane.
La trama viaria complessa ma funzionale rispec-
chia in certo modo i tracciati della precedente carta,
e, ove si pongan confronti, materializzando strade e
sentieri che trovano le loro portanti nelle grandi dor-
sali di val Piana, di S. Martino, di Dora Grossa,
nella mediana di val Salice, nella strada antica di
Sanvito, nella dorsale e mediana di val Pattonera e
dei Ronchi. Sulle zone a nord sono segnati i sentieri
dei boschi, fitti e intersecati.
La
Carta topografica detta Caccia,
quindi, ci
conferma che la struttura storica delle strade si attua
con riferimento costante agli assi stradali del Seicen-
to, costituendosi come elemento di legatura di cellu-
le edilizie. Ciò sarà ulteriormente verificato nella
mappa del catasto francese. Le cellule di più antico
impianto (ove non siano espressione di grande pro-
prietà fondiaria) tendono a disporsi parallelamente
alla via e mediare il cortile interno o I'« artefatto
piano » di affaccio sulla valle tramite il portone o il
muro di cinta. Ove non siano strutture agricole, ten-
dono a staccarsi dalla strada, configurandosi al cen-
tro di lotto ideale con una corte o giardino. In questo
caso l'elemento di legatura con la via è dato dalla
cappella, la quale tende a connotare lo spazio am-
bientale della strada e dell'accesso alla vigna in una
cifra stilistica (talvolta) ben più espressa che non
quella dell'edificio di abitazione.
La
Carta topografica detla Caccia
riporta i giar-
dini, mai però di grande estensione in quanto legati
alle corti ed agli artefatti piani, giardini di misura in
alternativa a quelli di città, su cui prevale la costante
di un paesaggio umanizzato fortemente definito dal-
le sue componenti agricole, prevaricante quindi il
disegno dei giardini; e ciò nel senso di rimandare più
alla strada e ai suoi contesti materiali la costruzione
di uno spazio di relazione (a livello territoriale), in
cui giocano più i muri di cinta, le chiusure, i piloni
votivi e le cappelle di antico impianto o i muri di
779


















