
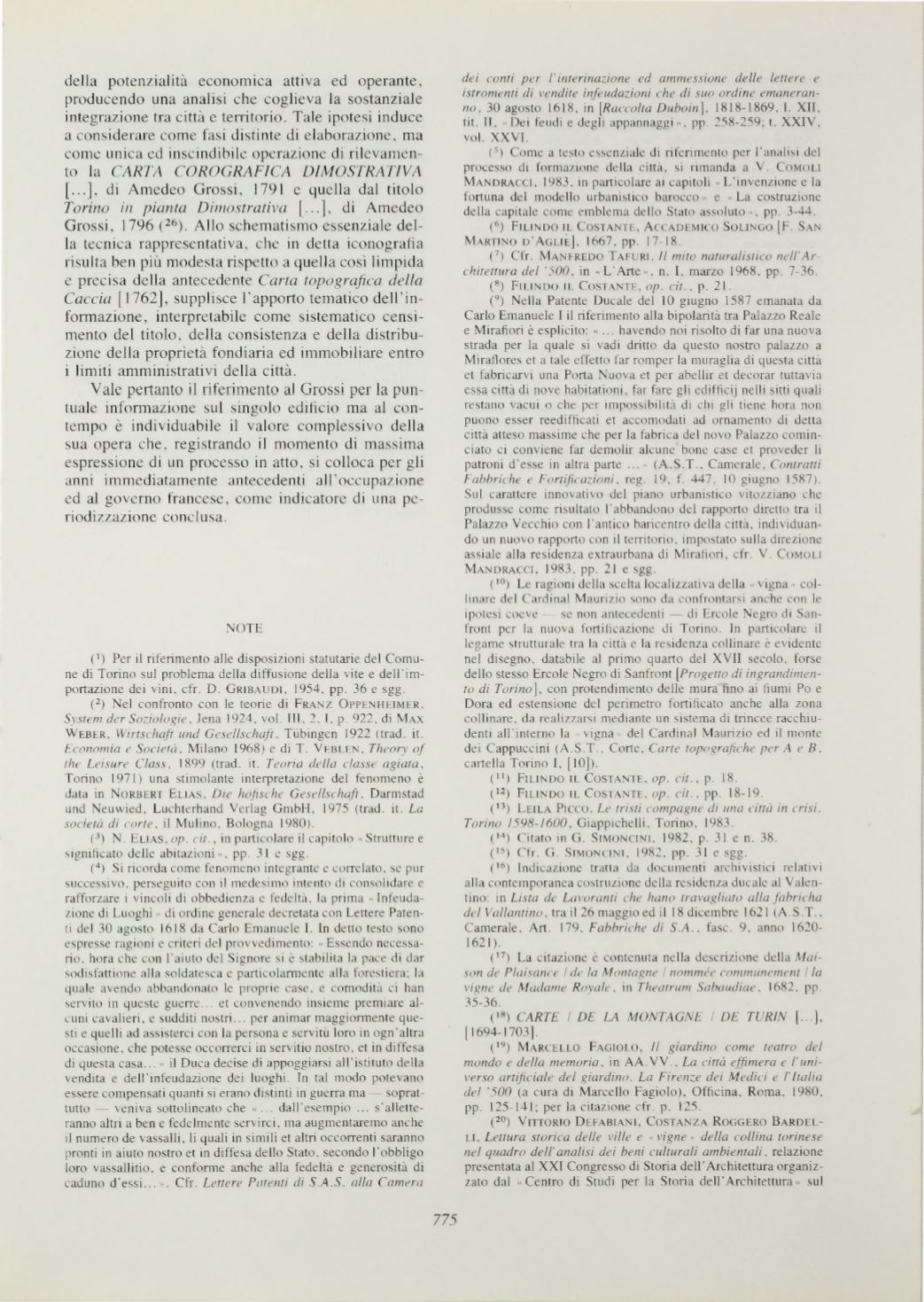
della potenzialità economica attiva ed operante,
producendo una analisi che coglieva la sostanziale
integrazione tra città e territorio. Tale ipotesi induce
a considerare come fasi distinte di elaborazione, ma
come unica ed inscindibile operazione di rilevamen-
to la
CARTA COROGRAFICA DIMOSTRATIVA
[...], di Amedeo Grossi, 1791 e quella dal titolo
Torino in pianta Dimostrativa [...],
di Amedeo
Grossi, 1796 (
26
). Allo schematismo essenziale del-
la tecnica rappresentativa, che in detta iconografia
risulta ben più modesta rispetto a quella così limpida
e precisa della antecedente
Carta topografica della
Caccia [ 1762],
supplisce l'apporto tematico dell'in-
formazione, interpretabile come sistematico censi-
mento del titolo, della consistenza e della distribu-
zione della proprietà fondiaria ed immobiliare entro
i limiti amministrativi della città.
Vale pertanto il riferimento al Grossi per la pun-
tuale informazione sul singolo edificio ma al con-
tempo è individuabile il valore complessivo della
sua opera che, registrando il momento di massima
espressione di un processo in atto, si colloca per gli
anni immediatamente antecedenti all'occupazione
ed al governo francese, come indicatore di una pe-
riodizzazione conclusa.
NOTE
(1) Per il riferimento alle disposizioni statutarie del Comu-
ne di Torino sul problema della diffusione della vite e dell'im-
portazione dei vini, cfr. D.
GRIBAUDI,
1954, pp. 36 e sgg.
(2) Nel confronto con le teorie di
FRANz OPPENHEIMER,
System der Soziologie,
Jena 1924, vol. III. 2, I, p. 922, di
MAX
WEBER,
Wirtschaft und Geseltschaft,
Tubingen 1922 (trad. it.
Economia e Società,
Milano 1968) e di T.
VEBLEN,
Theo
ry
of
the Leisure Class,
1899 (trad. it.
Teoria della classe agiata,
Torino 1971) una stimolante interpretazione del fenomeno è
data in
NORBERT ELIAS,
Die hòfische Geseltschaft,
Darmstad
und Neuwied, Luchterhand Verlag GmbH, 1975 (trad. it.
La
società di corte,
il Mulino, Bologna 1980).
(3) N.
ELIAS,
op. cit.,
in particolare il capitolo « Strutture e
significato delle abitazioni», pp. 31 e sgg.
(4) Si ricorda come fenomeno integrante e correlato, se pur
successivo, perseguito con il medesimo intento di consolidare e
rafforzare i vincoli di obbedienza e fedeltà, la prima « Infeuda-
zione di Luoghi „ di ordine generale decretata con Lettere Paten-
ti del 30 agosto 1618 da Carlo Emanuele I. In detto testo sono
espresse ragioni e criteri del provvedimento: « Essendo necessa-
rio, hora che con l'aiuto del Signore si è stabilita la pace di dar
sodisfattione alla soldatesca e particolarmente alla forestiera; la
quale avendo abbandonato le proprie case, e comodità ci han
servito in queste guerre... et convenendo insieme premiare al-
cuni cavalieri, e sudditi nostri... per animar maggiormente que-
sti e quelli ad assisterci con la persona e servitù loro in ogn'altra
occasione, che potesse occorrerci in servitio nostro, et in diffesa
di questa casa.... il Duca decise di appoggiarsi all'istituto della
vendita e dell'infeudazione dei luoghi. In tal modo potevano
essere compensati quanti si erano distinti in guerra ma — soprat-
tutto — veniva sottolineato che «... dall'esempio ... s'allette-
ranno altri a ben e fedelmente servirci, ma augmentaremo anche
il numero de vassalli, li quali in simili et altri occorrenti saranno
pronti in aiuto nostro et in diffesa dello Stato, secondo l'obbligo
loro vassallitio, e conforme anche alla fedeltà e generosità di
caduno d'essi... ». Cfr.
Lettere Palenti di S.A.S. alla Camera
dei conti per l' interinazione ed ammessione delle lettere e
istromenti di vendite infeudazioni che di suo ordine emaneran-
no,
30 agosto 1618, in
[Raccolta Duboin],
1818-1869, 1. XII,
tit. II, «Dei feudi e degli appannaggi», pp. 258-259; t. XXIV,
vol. XXVI.
(5) Come a testo essenziale di riferimento per l'analisi del
processo di formazione della città, si rimanda a V. CoMoLI
MANDRACCI,
1983, in particolare ai capitoli «L'invenzione e la
fortuna del modello urbanistico barocco » e « La costruzione
della capitale come emblema dello Stato assoluto», pp. 3-44.
(6) FILINDO IL COSTANTE, ACCADEMICO SOLINGO
[F.
SAN
MARTINO D'AGLIE],
1667, pp. 17-18.
(7) Cfr.
MANFREDO TAFURI, Il
mito naturatistico nell'Ar-
chitettura del '500,
in '<L'Arte», n. I, marzo 1968, pp. 7-36.
(8) FILINDO IL COSTANTE,
op. cit.,
p. 21.
(9) Nella Patente Ducale del 10 giugno 1587 emanata da
Carlo Emanuele I il riferimento alla bipolarità tra Palazzo Reale
e Mirafiori è esplicito: « ... havendo noi risolto di far una nuova
strada per la quale si vadi dritto da questo nostro palazzo a
Miraflores et a tale effetto far romper la muraglia di questa città
et fabricarvi una Porta Nuova et per abellir et decorar tuttavia
essa città di nove habitationi, far fare gli edifficij nelli sitti quali
restano vacui o che per impossibilità di chi gli tiene hora non
puono esser reedifficati et accomodati ad ornamento di detta
città atteso massime che per la fabrica del novo Palazzo comin-
ciato ci conviene far demolir alcune bone case et proveder li
patroni d'esse in altra parte ...» (A.S.T., Camerale,
Contratti
Fabbriche e Fortificazioni,
reg. 19, f. 447, 10 giugno 1587).
Sul carattere innovativo del piano urbanistico vitozziano che
produsse come risultato l'abbandono del rapporto diretto tra il
Palazzo Vecchio con l'antico baricentro della città, individuan-
do un nuovo rapporto con il territorio, impostato sulla direzione
assiale alla residenza extraurbana di Mirafiori, cfr. V. CoMoLI
MANDRACCI,
1983, pp. 21 e sgg.
(10) Le ragioni della scelta localizzativa della « vigna» col-
linare del Cardinal Maurizio sono da confrontarsi anche con le
ipotesi coeve — se non antecedenti — di Ercole Negro di San-
front per la nuova fortificazione di Torino. In particolare il
legame strutturale tra la città e la residenza collinare è evidente
nel disegno, databile al primo quarto del XVII secolo, forse
dello stesso Ercole Negro di Sanfront
[Progetto di ingrandimen-
to di Torino],
con protendimento delle mura fino ai fiumi Po e
Dora ed estensione del perimetro fortificato anche alla zona
collinare, da realizzarsi mediante un sistema di trincee racchiu-
denti all'interno la vigna del Cardinal Maurizio ed il monte
dei Cappuccini (A.S.T., Corte,
Carte topografiche per A e B,
cartella Torino I, [10]).
(11) FILINDO IL COSTANTE,
op. cit.,
p. 18.
(12) FILINDO IL COSTANTE,
op. cit. ,
pp. 18-19.
(13) LEILA
PICCO,
Le tristi compagne di una città in crisi.
Torino 1598-1600,
Giappichelli, Torino, 1983.
(14) Citato in G.
SIMONCINI,
1982, p. 31 e n. 38.
(15) Cfr. G.
SIMONCINI,
1982, pp. 31 e sgg.
(16) Indicazione tratta da documenti archivistici relativi
alla contemporanea costruzione della residenza ducale al Valen-
tino: in
Lista de Lavoranti che hano travagliato alla fabricha
det Valtantino,
tra il 26 maggio ed il 18 dicembre 1621 (A.S.T.,
Camerale, Art. 179,
Fabbriche di S.A.,
fasc. 9, anno 1620-
1621).
(17) La citazione è contenuta nella descrizione della
Mai-
son de Ptaisance I de la Montagne I nommée conununement I la
vigne de Madame Royale,
in
Theatrum Sabaudiae,
1682, pp.
35-36.
(18) CARTE I DE LA MONTAGNE I DE TURIN [...],
[1694-1703].
(19) MARCELLO FAGIOLO,
II giardino come teatro det
mondo e delta memoria,
in
AA.VV.,
La città effimera e l'uni-
verso artificiale det giardino. La Firenze dei Medici e l'Itatia
del '500
(a cura di Marcello Fagiolo), Officina, Roma, 1980,
pp. 125-141; per la citazione cfr. p. 125.
(20) VITTORIO DEFABIANI, COSTANZA ROGGERO BARDEL-
LI,
Lettura storica delle ville e .. vigne » detla collina torinese
net quadro dell'analisi dei beni culturali ambientali,
relazione
presentata al XXI Congresso di Storia dell'Architettura organiz-
zato dal Centro di Studi per la Storia dell'Architettura» sul
775


















